Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla sua origine fino al presente
[Frontispizio] §
Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla sua origine fino al presente.
opera di Stefano Arteaga
Socio dell’Accademia delle scienze, arti e belle lettere di Padova.
Seconda edizione
Accresciuta, variata, e corretta dall’autore
Tomo primo
In Venezia MDCCLXXXV. nella stamperia di Carlo Palese con pubblica approvazione
[Epigrafo] §
«Il faut se rendre à ce palais magique,
Où les beaux vers, la danse, la musique,
L’art de tromper les yeux par les couleurs,
L’art plus heureux de seduire les cœurs
De cent plaisirs font un plaisir unique.»
Tomo primo §
[Dedica] §
A sua eccellenza il signor D. Giuseppe Niccolo’ d’Azara
Cavaliere del reale e distinto ordine Carlo III, consigliere di S. M. Cattolica nel consiglio di azienda, suo agente procurator generale e ministro plenipotenziario nella corte di Roma ec.
[1] Se in un secolo come il nostro, se ad un uomo quale voi siete, io non presento una di quelle opere importanti che influiscono direttamente sul bene delle nazioni; io vi prego, o Signore, ad attribuirlo meno al non averne sentito gl’impulsi che al destino che mi vieta di secondarli. Il privilegio di afferrare certa classe d’oggetti, siccome non è concesso a tutti gl’ingegni, così non è proprio di tutte le circostanze. La natura, che non ha voluto annoverarmi tra quelli, è andata perfettamente d’accordo colla fortuna che mi frappone l’inciampo di queste.
[2] Ma a chi non può inalzare da pianta un novello edifizio rimane pur anco il non isteril compenso d’osservare, ed illeggiadrire i già fabbricati. Il gusto che percepisce, confronta ed analizza i rapporti; la critica che ci rende sensibili alle bellezze e ai difetti e che, indicando gli errori altrui, ci premunisce contro alle inavvertenze proprie, sono non men necessari ai progressi dell’umano spirito di quello che lo siano gli slanci del genio sempre coraggioso, ma talvolta poco avveduto. Il primo è come il microscopio applicato a gli occhi della ragione. La seconda è quel freno salutare, senza cui gl’impeti più felici non sono per lo più che altrettanti indizi di non lontana caduta.
[3] Incoraggiato da tai riflessi oso offrirvi, o Signore,
insiem colla storia del più brillante spettacolo di Europa alcune
mie osservazioni sulla maniera di perfezionar le varie e moltiplici parti, che lo
compongono. Avrei voluto, e l’avrei certamente voluto con quel zelo, che l’amor
nazionale ispira, e giustifica, consecrar alla nostra comune dilettissima patria le mie
fatiche: allora io vi sarei venuto avanti con un dono più degno di voi, e la mia
patriotica riconoscenza non sentirebbe ad ogni momento l’involontario rimorso di menar
sulla terra una vita inutile affatto per la sua gloria. Ma dopo qualche lavoro
intrapreso ad ottener un tal fine, mi ritrovai per mancanza degli opportuni letterari
sussidi, come il Dedalo della favola allorché
adagiava le piume sugli omeri del figlio «Bis conatus eram… Bis patriae cecidere
manus.»
[4] Degnate non per tanto onorare dell’autorevol vostro suffragio codesto tenue saggio del mio zelo per gli studi voi, che siete solito d’accogliere con tanta benignità tutto ciò, che spetta l’avanzamento delle arti, e delle lettere; voi, che in una città maestra della religione e della politica sostenete con tanto decoro i diritti di un monarca cognito all’universo non meno per la sua pietà nella prima che per la sua prudenza nella seconda; voi, che collocato ih carica sì luminosa rarissimo esempio avete dato a’ vostri pari di sensibilità spargendo lagrime, e fiori sulla tomba d’un amico illustre; voi, finalmente, che nelle vostre sensate, profonde e per’ogni verso filosofiche riflessioni intorno alle opere di avete fatto vedere che il talento di regolare gli affari non è incompatibile con quello di conoscere le più intime sorgenti del bello, e che il più’gran genio del nostro secolo nella pittura era ben degno d’avere per illustratore de’ suoi pensieri, e confidente uno degli spiriti più elevati della Spagna nella penetrazione e sagacità dell’ingegno come nella squisitezza del gusto.
Avvertimento al lettore per la presente edizione §
[1] Motivi che interessano soltanto alcuni particolari, hanno trattenuto finora la continuazione delle Rivoluzioni del teatro musicale italiano nei torchi di Bologna. Però riflettendo al rispetto ch’esigge il pubblico, deliberai di procurarne io stesso un’altra edizione, che può dirsi ed è realmente una cosa affatto diversa e per le considerabili mutazioni ed accrescimenti fatti al primo tomo stampato, e per l’aggiunta di sette lunghi capitoli che formano la parte più utile e la più essenziale dell’opera.
[2] Ne’ ragionamenti che servono ad ispiegare lo stato attuale del dramma, ho riguardata la musica sotto ad un aspetto nuovo in Italia. I pratici di questa nazione non l’hanno considerata finora se non come un affare di puro istinto e d’abitudine, né si sono inalzati al di là della sua parte grammaticale. I teorici non si sono occupati che di regole, combinazioni e rapporti fra i suoni; in una parola, della sua parte matematica o dottrinale. Io senza inoltrarmi in così spinose ricerche ho cercato di far conoscere la rettorica e la filosofia dell’arte, quelle parti cioè le più trascurate dai moderni musici, ma le quali io giudico essere le più essenziali fra tutte, poiché c’insegnano l’uso che dee farsi de’ mezzi particolari ad ottenere nella maggior estensione possibile il fin generale.
[3] Dai principi onde parto, sono derivate naturalmente molte conseguenze che riusciranno poco gradevoli agli interessati. Di nulla meno si tratta che di fare man bassa e pressoché annientare quanto forma in oggi la delizia, l’ammirazione e il trasporto del teatro musicale italiano. Preveggo non per tanto gli insulti della ignoranza e i clamori del pregiudizio. Ma, oh adorabile verità! Se gli uomini mi negheranno il compenso del loro sterile suffragio, io il ritroverò dentro di me medesimo nella soddisfazione di averti servito.
[Epigrafo] §
«Non per questo perché a noi manca quella squisitezza, e quella vivezza d’ingegno, la quale ebbero Tucidide, e gli altri scrittori insigni, saremo egualmente privi della facoltà che essi ebbero nel giudicare. Imperocché è pur lecito il dar giudizio di quelle professioni, in cui furono eccellenti Apelle, Zeusi e Protogene, anche a coloro i quali ad essi non possono in verun patto agguagliarsi: né fu interdetto agli altri artefici il dire il parer loro sopra le opere di Fidia, di Policleto e di Mirone, tuttoché ad essi di gran lunga fossero addietro. Tralascio che spesso avviene che un uomo idiota, avendosi a giudicare di cose sottoposte al senso, non è inferiore a’ periti.»
nel Giudizio sopra Tucidide.
Discorso preliminare premesso alla prima edizione §
[1] Il teatro considerato come un pubblico spettacolo introdotto, o permesso dalle leggi in una nazione può considerarsi in tanti aspetti differenti quante sono le classi degli spettatori, che vi concorrono. Diversamente il considerano l’uomo di mondo, il politico, l’erudito, l’uomo di gusto, e il filosofo. Percorriamo brevemente queste cinque classi.
[2] Quegli schiavi insensati del pregiudizi, que’ corpi senz’anima, quelle creature indifinibili, che si chiamano gente di mondo, le massime delle quali consistono nel distrugger i sentimenti della natura per inalzar sulle loro rovine l’idolo dell’opinione, nel ridurre ogni affezione del cuore alla sola voluttà, ogni morale al personale interesse, nel far che un’apparente politezza tenga luogo di tutte le virtù, e nel colorir con brillanti sofismi l’orrore del vizio non altrimenti che soglionsi coprire con vistosa vernice i putridi legni dalla vecchiezza o dal tarlo corrosi; fanno del teatro quell’uso appunto, che sogliono fare delle altre cose. Come la regola loro di pensare e di vivere non è il sentimento ma l’uso, così non vanno al teatro a fine di risentire il piacevole incanto dell’arte drammatica, ma perché vi vanno gli altri soltanto. Adocchiare per esser adocchiati, aggirarsi da scioperati da palchetto in palchetto, scoprir nelle regioni della galanteria paesi non per anco tentati, spiar in aria di somma importanza i segreti movimenti d’Irene o di Nice verso Celadone o Silvandro, riempiere l’intervallo di quelle ore lunghissime con isquisita e deliziosa mormorazione, oppure col giuoco (quella occupazione insipida ritrovata dall’ozio, e dall’avarizia per consolar tante anime vuote, che non sanno che farsi della propria esistenza) ecco il fine, al quale rivolgono essi la grand’arte di e di . Uditori altrettanto incomodi per l’indiscretezza loro quanto giudici infelici pel niun discernimento recherebbono danno anzi che vantaggio alla perfezione del gusto, se le spese inevitabili al mantenimento d’un teatro non rendesse necessaria la frequenza loro, come la necessità di far numero in un’armata costrigne sovente i generali ad ammetterne infiniti poltroni.
[3] Il politico, osservando unicamente gli oggetti per la relazione che hanno colla civile economia e coi fini dello stato, lo riguarda come un luogo atto a far circolar il danaro dei privati e a render più brillante il soggiorno d’una capitale; come un nuovo ramo di commercio, ove si dà più voga alle arti di lusso pella gara che accendesi scambievolmente di primeggiare negli abbigliamenti e pel maggior concorso de’ forastieri chiamati dalla bellezza dello spettacolo; come un ricovero all’inquieta effervescenza di tanti oziosi, i quali in altra guisa distratti potrebbono alla società divenire nocivi, impiegando contro di essa non meno i propri divertimenti che le proprie occupazioni; come un mezzo termine infine opportuno a dileguar i bisbigli de’ malcontenti, o a impedire le ragunanze sempre di torbidezza feconde e di pericolo. Più profondo insieme e più maligno nelle sue mire egli lo prenderà come un diversivo offerto talvolta al popolo spensierato per nasconder agli occhi suoi l’aspetto di quelle catene che la politica va lavorando in silenzio, per infiorare gli orli del precipizio, dove lentamente lo guida il despotismo, e per mantenerlo più agevolmente in quella picciolezza e dissipazione di spirito, che tanto comoda riesce a chi vuol soggiogare. Così la Sibilla di , volendo inoltrarsi nelle vietate regioni d’Averno, prese il partito d’addormentare col preparato boccone quel mostro, che le ne impediva l’ingresso.
[4] Quei pesanti raccoglitori chiamati eruditi, che hanno tutta l’anima riposta nella sola reminiscenza, che valutano le ragioni secondo il numero delle citazioni, e il merito degli autori secondo i secoli della loro nascita, giudicano a un dippresso dell’arte drammatica come il famoso cieco di Cheselden giudicava delle rose, delle quali per quanto s’ingegnassero i circostanti a fargli capire la soavità e freschezza di colorito, altro egli non potè sentire giammai che le spine. Il loro studio consiste nel verificar appuntino le date, nel sapere il numero e i titoli delle produzioni d’un autore, per quanti mesi ei le ritenne chiuse nello scrigno, quanti manoscritti se ne facessero, in qual anno e da quale stampatore vedessero la pubblica luce, quante edizioni siano state fatte finora. Ciò che più converrebbe gustare, vale a dire la dilicatezza, il sentimento, l’immaginazione, la pittura forte de’ caratteri, il linguaggio fine delle passioni, tutto è per loro come se non esistesse. Se per disavventura delle lettere s’affibbiano essi la giornea d’Aristarco per giudicare, l’impegno loro si riduce ad accozzar con freddissima logica una serie di precetti comunali tratti dall’esempio e dall’autorità degli antichi mal intesi e peggio gustati da loro per misurar poscia su quelli come sul letto di Procuste i più celebri ingegni. Non resteranno poco né molto commossi dal terribile e magnifico quadro della morte di Didone, ma ti faranno bensì una lunga diceria sull’anacronismo del poeta, che fece viver ai medesimi tempi Enea e la regina di Cartago. Se leggono , lasciando da banda le inesprimibili sue bellezze, si fermeranno a cercar nell’Odissea la geografia antica, e nella Iliade l’armatura dei Greci, o la figura delle loro fibbie, seppur le avevano. Se ragionasi di teatro, anteporranno l’Ulisse di all’Olimpiade del , e tel proveranno con un testo della poetica d’ comentata dall’, riguarderanno con disprezzo il Tartuffo e il Misantropo, que’ due capi d’opera sovrani nel genere comico, e vorranno piuttosto seguir l’esempio di , il quale in una sua commedia intitolata la Valigia introdusse a dialogizzar insieme un coro d’agli e di cipolle per imitar , che aveva parimenti fatto parlare sul teatro d’Atene le rane, le vespe, e le nugole.
[5] Dotato di cuor sensibile e d’immaginazione vivace, osservator fedele della natura e degli uomini, ammaestrato ai fonti di , di , e d’, versato nella lettura de’ primi modelli antichi e moderni l’uomo di gusto è il solo, che prenda lo spettacolo per se stesso e non per gli accessori. Ei solo, penetrando più addentro nello spirito delle regole, sa fino a qual punto debbano esse incatenar il genio, e quando questo possa legittimamente spezzarne i legami: sa stabilir i confini tra l’autorità e la ragione, tra l’arbitrario e l’intrinseco: sa perdonar i difetti in grazia delle virtù, e misurar il pregio delle virtù per l’effetto, che ne producono. Ei paragonando insieme le diverse bellezze degli autori, delle nazioni e de’ secoli, si forma in mente una immagine del bello ideale, la quate poi applicata alle diverse produzioni degli ingegni gli serve, come il filo ad Arianna, per inoltrarsi nel sempre oscuro e difficile labirinto del gusto: contempla l’oggetto delle belle arti modificato in mille maniere secondo i climi, le costumanze e i governi, come la materia fisica si combina sotto mille forme diverse: conosce che tutti i gran geni hanno diritto alla stima pubblica, e che un sol genere di bello non dee, e non può donar la esclusiva agli altri. Quindi imparziale e giusto ne suoi giudici sentesi grandeggiar con e , s’intenerisce con , , e , freme con e , ammira senza imitarli , , e , preferisce a’ comici di tutti i tempi, bilancia il merito degli autori subalterni secondo più o meno s’avvicinano al loro esemplare, e getta dentro a’ gorghi di Lete i pedanti ridicoli, i versificatori sterili, i languidi copisti, gli autoruzzi insomma d’un giorno commendati invano e difesi da protettori ignoranti, da fogli prezzolati, e da insensate apologie.
[6] Il filosofo avvezzo a ridur le cose a’ suoi primi principi e a considerarle secondo la relazione che hanno colle affezioni primitive dell’uomo, riguarda la scena ora come un divertimento inventato affine di sparger qualche fiore sull’affannoso sentiero dell’umana vita, e di consolarci in parte de’ crudeli pensieri che amareggiano sovente in ogni condizione la nostra breve e fuggitiva esistenza: ora come un ritratto delle passioni umane esposto agli occhi del pubblico, affinchè ciascheduno rinvenga dentro del proprio cuore l’originale: ora come un sistema di morale messa in azione, che abbellisce la virtù per renderla più amabile, e che addimanda in prestito al cuore il suo linguaggio per far meglio valere i precetti della ragione: ora come uno specchio, che rappresenta le inclinazioni, e il carattere d’una nazione, lo stato attuale de’ suoi costumi, la maggior o minore attività del governo, il grado di libertà politica in cui si trova, le opinioni, e i pregiudizi che la signoreggiano.
[7] In quale degli accennati aspetti deggia fissare lo sguardo chiunque la storia d’un teatrale spettacolo imprende a narrare può da ogni lettore avveduto dopo qualche riflessione fatta su cotali materie non difficilmente conoscersi. Se fosse quistione di scrivere per lo teatro, e non del teatro, l’uomo di gusto esser dovrebbe l’unico giudice, che se ne scegliesse, siccome quello, che avendo meglio d’ogni altro studiate le regole di piacere ad un pubblico illuminato, meglio d’ogni altro saprebbe additare que’ mezzi, che a così fatto fine conducono. Le altre mire o non entrano affatto nel suo progetto, o ci entrano solo per incidenza. Ma la storia apre alle ricerche degli studiosi un campo più vasto. Non solo la cognizione richiedesi, e il possesso di quelle leggi ricavate dal consenso comune, e dalla esperienza, onde l’autore possa dettare intorno alle cose un ben fondato giudizio: non sol gli è d’uopo investigare il legame segreto, che corre tra il genio della nazione e la natura dello spettacolo, tra il genere di letteratura, che è il principal argomento dell’opera, e gli altri che gli tengono mano, ma indispensabile diviene per lui eziandio l’erudizione, quell’erudizione medesima, della quale l’uomo di genio fa così poco conto, e senza cui niuno storico edifizio può alzarsi. Se la simmetria, la vaghezza, e il disegno della fabbrica sono del gusto, sua ne è la raccolta de’ materiali, e il tragitto. Se la filosofia le aggiugne giustezza e profondità, l’erudito anch’egli concorre con braccia poderose, e con incessante fatica: dal che avviene che se la gloria di quest’ultimo è meno luminosa e brillante, non è perciò men solida né meno sicura. Ha egli non per tanto a vestire or l’uno or l’altro tutti i personaggi. Non dee solamente cercare sterili fatti, ma l’ordine e il congegnamento tra essi: dee usar di stile conveniente al soggetto, ma senza tralasciar le riflessioni opportune, e il colorito talvolta vivace: ora rispettar modestamente l’autorità, ora aver a tempo e luogo il coraggio di misurarla colla bilancia della ragione: quando apprezzar le particolarità, che servono ad illustrar l’argomento, quando troncarle allorché divengono oziose: dove avvicinar i secoli passati e presenti per rilevar col confronto i progressi delle arti, dove risalire fino ai principi a fine di rintracciar meglio l’origine della perfezione loro, o del loro decadimento. In una parola si ricerca che sia erudito, critico, uomo di gusto, e filosofo al medesimo tempo. Tal è la grande idea, ch’io non mi lusingo d’avere nemmen da lungo tratto adeguata, ma che bramerei pure di poter eseguire accingendomi a scrivere le Rivoluzioni del teatro musicale italiano.
[8] Una fortunata combinazione, che con dolce compiacenza mi fo un dovere di palesar al pubblico, e che renderà tanto meno scusabili i falli miei quanto più mezzi ho avuti di schivarli, mi fece scoprire una miniera di notizie appartenenti alla musica nella conoscenza ed amicizia del reverendissimo padre maestro fra de’ minori conventuali. Questo dottissimo religioso, del quale è inutile fermarsi a tesser l’elogio, poiché meglio di me lo fa l’Italia tutta e l’Europa, fu il primiero, che mi confortò alla intrapresa, che rimosse da me ogni dubbiezza, che m’indicò le sorgenti, che mi fornì buon numero di libri rari, e di manoscritti, e che m’aprì ne’ suoi famigliari discorsi fonti d’erudizione vieppiù copiosi di quelli che ritrovassi negli autori. Tutto ciò con un candor d’animo, e con una tal gentilezza inesprimibile, che avranno meco divisa quanti uomini di lettere hanno la buona sorte d’avvicinarglisi, e che non suol vedersi troppo comunemente negli avari posseditori d’erudite ricchezze, i quali somiglianti al drago custode degli orti Esperidi, vietano che altri accosti la mano a quegli aurei frutti, ch’essi pur guardano da lontano senza mai toccarli1. Su questi materiali, e su altri che mi procacciai altronde colla diligenza, scortato ovunque dal giudizio di persone intelligenti nei vari e moltiplici rami di che mi convien ragionare, giunsi a distendere la presente storia di quel brillante spettacolo sì caro all’Italia, il quale pel complesso di tutti i piaceri dello spirito, della immaginazione, del cuore, della vista e dell’udito combinati insieme ad agitar l’animo dell’uomo e sorprenderlo, è senza dubbio il maggiore sforzo delle belle arti congiunte, e il diletto più perfezionato, che da esse attender possa la politica società.
[9] Avendo bevuto a tali sorgenti, non mi dò il menomo vanto della esattezza e novità delle notizie sulle quali è appoggiato quanto qui si scrive. Leggendo i molti e celebri autori che mi hanno preceduto nello scriver della letteratura, ho avuto ocularmente occasione di confermarmi in un sentimento, che avea da lungo tempo adottato, ed è che la storia non meno letteraria che politica delle nazioni altro non sia che un vasto mare d’errori, ove a tratto a tratto galleggiano sparse alla ventura alcune verità isolate. Mio primo pensiero era di rilevar passo a passo le inesattezze di molti, di rettificarne gli abbagli, e di ridurre al suo intrinseco valore l’autorità di cert’uni, che opprimono col nome loro i lettori creduli ed infingardi. Ma presto m’avvidi, che siffatto metodo cangierebbe la storia in una discussione polemica rincrescevole al pubblico , il quale pago per lo più di trovarne il vero poco si cura di risapere, se gli altri abbiano smarrita la via. Mi riserbai non per tanto a farlo in qualche occorrenza, ove mi parve che lo richiedesse il bisogno, e m’astenni sul medesimo riflesso dall’affastellare ad ogni pagina le citazioni sì per non frastornar ad ogni tratto l’attenzione del lettore, come per non ingrossar di troppo il volume. Qualunque sia stata la mia premura nel rintracciar la verità delle notizie, mio principal assunto non è d’offrire una sterile compilazione di reminiscenze, ma di ragionare sui fatti, di far conoscere le relazioni che gli legano insieme, e d’abbracciare gli oggetti analoghi, i quali, entrando comodamente nel mio argomento, potevano servire a maggiormente illustrarlo. Così benché il titolo del libro riguardi il solo teatro musicale, il lettore vi troverà ciò nonostante, la storia non affatto superficiale della musica italiana e de’ suoi cangiamenti, come della tragedia ancora e della commedia con molte riflessioni sugli altri rami della poesia, e su altri punti. Debbo avvertire bensì, che scrivendo io la storia dell’arte e non degli artefici, vana riuscirebbe la speranza di chiunque vi cercasse per entro quelle minute indagini intorno al nome, cognome, patria, nascita e morte degli autori, di tutte quante le opere, ch’essi pubblicarono, delle varie edizioni e tai cose che sogliono essere le più care delizie degli eruditi a nostri tempi. Mille altri libri appagheranno la curiosità di coloro che stimassero cotali ricerche di somma importanza.
[10] Ad ogni modo però son ben lontano dal lusingarmi d’avere sfuggito ogni motivo di riprensione. Senza incolpar i lettori di malivolenza né d’ingiustizia (frase inventata dagli autori infelici per vendicarsi dal giusto disprezzo con cui sono stati ricevuti dal pubblico ) io veggo quante accuse mi si possono fare parte provenienti dalla ragione, parte dal pregiudizio di coloro che il proprio gusto vorrebbero a tutti far passare per legge, e parte ancora da quegli uomini incomodi, i quali veggendo le altrui fatiche esser un tacito rimprovero della loro dappocaggine, si sforzano di consolar il loro amor proprio dispregiandole essi stessi, e cercando che vengano dispregiate dagli altri: somiglianti appunto a que’ satiri che ci descrive , i quali esclusi per la loro petulanza e schifezza dal soggiorno delle grazie, si fermavano dietro alle siepi sogghignando maliziosamente a quei felici mortali che venivano per man d’Amore introdotti ne’ dilettosi giardini. Sarebbe operosa e inutil fatica il risponder a quelle perché la verità non ammerte risposta, e a queste perché taluni non cangiano opinione giammai ove si tratta di vilipendere.
[11] Una ci ha nonostante, la quale quant’otterrà facile indulgenza da giudici illuminati e sinceri, altrettanto darà fastidio a certe persone pusillanimi che scambiano mai a proposito il rispetto colla debolezza. Questa è l’urbana bensì ma ferma, e imparziale maniera con cui si parla delle opere e degli autori. Avrebbono forse desiderato, ch’io fossi stato più circospetto: cioè nella significazione che danno essi a tal parola, che non avessi osato, di profferir il mio sentimento se non colla timidezza propria d’uno schiavo, che avessi incensato gli errori e i pregiudizi del secolo, e che avessi fatto l’eco vituperevole di tanti giudizi stoltissimi, che sentonsi ogni giorno ne’ privati discorsi e nelle stampe. né vi mancheranno di quelli, i quali, ricorrendo a’ luoghi topici della ignoranza, troveranno nel titolo di straniero una suspizione d’invidia contro l’Italia. Quanto a me animato perfettamente da spirito repubblicano in punto di lettere ho sempre stimato, che la verità e la libertà debbano essere l’unica insegna di chi non vuol avvilire il rispettabile nome d’autore: ho creduto, che l’accondiscender ai pregiudizi divenga egualmente nuocevole agli avanzamenti del gusto di quella che lo sia ai’ progressi della morale il patteggiare coi vizi: ho pensato, che la verace stima verso una nazione non meno che verso le persone private non si manifesti con cerimoniosi e mentiti riguardi, figli per lo più dell’interesse, o della paura, ma col renderle senza invidia la giustizia che merita, e col dirle senza timore le verità di cui abbisognai ho giudicato, che siccome l’amico, che riprende, palesa più sincera affezione che non il cortigiano che adula, così più vantaggiosa opinione dimostra ad altrui chi capace il crede d’ascoltar ragione in causa propria che non faccia quell’altro, il quale tanto acciecato il suppone dall’amor proprio che non possa sostener a viso fermo l’aspetto della verità conosciuta: mi sono finalmente avvisato, che se il rispetto per un particolare mi sollecitava a usare di qualche parzialità, il rispetto vieppiù grande che deggio avere per il pubblico , mi vietava il farlo, facendomi vedere cotal parzialità biasimevole, e ingiusta. Circa il sospetto ch’io, come straniero, voglia screditar la nazione, esso sarebbe tanto più insussistente quanto che la maggior parte di quest’opera depone in contrario. Basta legger soltanto di fuga i primi capitoli per vedere quanto ivi si largheggi di lodi colla Italia, come si preferiscano la musica e il melodramma italiano alla musica, e al melodramma degli altri popoli, in qual guisa si mettano, a coperto delle imputazioni degli oltramontani, ove si trovino poco fondate, e come si renda dappertutto giustizia al merito illustre de’ tanti suoi poeti e di tanti musici. Che se ciò nonostante alcun m’attribuisse intenzioni che non ho mai sognato d’avere: se dalla stessa mia ingenuità si prendesse argomento a interpretare malignamente le mie intenzioni, come dall’aver inventato un nuovo genere di pruove fortissime a dimostrar l’esistenza d’Iddio, non mancò ch’il volesse far passare per ateista: se altro mezzo non v’ha di far ricreder costoro, che quello d’avvilir la mia penna con adulazioni vergognose, ovvero d’assoggettarmi ad uno spirito di partito ridicolo; in tal caso rimangano essi anticipatamente avvisati, che non ho scritto per loro, e che la mia divisa per cotal genia di lettori sarà sempre quel verso d’:
«Odi profanum vulgus, et arceo.»
[12] Mi resta solo il far una riflessione dopo la quale finisco. Prendendo io a narrare l’origine, i progressi e lo stato attuale del melodramma in Italia, ove più che altrove si è coltivato, e si coltiva pur ora, mi s’affacciò in sul principio una difficolta, che quasi mi fece venir manco il coraggio. La tragedia, la commedia e persino la pastorale hanno delle leggi fisse, con cui possono giudicarsi, cavate dall’esempio de’ grandi autori, dal consenso presso che unanime delle colte nazioni, e dagli scritti di tanti uomini illustri, i quali o come filosofi, o come critici hanno ampiamente e dottamente ragionato intorno ad esse. Il dramma in musica all’opposto, come parto ancora recente nato sotto il cielo dell’Italia, giacciuto lunga stagione nell’avvilimento, ne rivestito dal suo splendore se non al nostro secolo, non ha avuto per anco di qua dai monti un grande ingegno, il quale prendendolo a disaminare nella interna sua costituzione ne abbia indicati i veri principi, fissate le regole, stabilito il sistema, e dataci, a così dire, l’arte poetica. Attalchè quelli autori, che hanno sensatamente parlato d’ogni altro genere di poesia, vanno tastoni nel ragionare del melodramma, ora rilegandolo ai mondi della favola, ora mettendolo tra le cose per sua natura difettose, ed assurde, ora sbadatamente confondendolo colla tragedia. Forse questa trascuratezza, e questo abbuiamento tornerà in maggior suo vantaggio, convenendo, secondo l’osservazione del gran , che non si tosto s’affrettino i filosofi a fissare i confini d’un’arte senza prima vedere le diverse forme, ch’essa può prendere dalle diverse combinazioni de’ tempi e delle circostanze; ma egli è vero altresì, che chiunque ne vorrà giudicare si troverà perplesso fra tante e sì contrarie opinioni, non avendo alla mano principi, onde avvalorar il proprio giudizio, Gl’Italiani, che hanno scritto fin’ora, non sono stati in ciò più felici. Senza far parola d’, del , di , del , del , del , del , del , del , e di tanti altri, che toccarono questo punto alla sfuggita, tre sono stati gli autori, che hanno parlato più di proposito. Il uomo di lettura immensa, d’erudizione poco sicura, di gusto mediocre, e di critica infelice impiegò un mezzo tomo della sua voluminosa opera intitolata Storia e ragione d’ogni poesia nel trattare dell’opera in musica, ove il lettore altro non sa rinvenire che titoli, che date e nomi d’autori ammucchiati senz’ordine a spavento della memoria, e a strazio della pazienza. Quella noiosa nomenclatura vien preceduta da una definizione del dramma cavata unicamente dagli abusi, da parecchie osservazioni triviali, da pregiudizi stabiliti in regola frammischiati a qualche precetto sensato. Il celebre Conte ne schizzò un breve Saggio, nel quale col solito suo spirito e leggiadria di stile olezzante de’ più bei fiori della propria e della peregrina favella si trovano scritte riflessioni assai belle, che lo fanno vedere quell’uomo di gusto ch’egli era in così fatte materie. Ma limitato unicamente alla pratica non volle, o non seppe risalire fino a’ principi, come forse avrebbe dovuto fare per meritar l’onore d’essere annoverato fra i critici di prima sfera. Più erudito, più universale, più ragionato e per conseguenza più utile è il Trattato dell’opera in musica del Cavalier napoletano. Egli abbraccia in tutta la sua estensione il suo oggetto. Le sue osservazioni circa le belle arti in genere, e circa la musica, e direzione del teatro in particolare sono assai giudiziose, e proficue, e dappertutto respirano l’onestà, la decenza, e il buon gusto. Nientedimeno senza derogar al merito d’un libro, ch’io credo il migliore di quanti siano usciti fin’ora alla luce massimamente nella parte didascalica, parmi che i pensieri dell’autore intorno alla parte poetica del dramma non abbiano né la giustezza né la profondità che campeggiano in altri luoghi: mi sembra, che abbia poco felicemente indagati i distintivi fra l’opera e la tragedia, e che non venga dato gran luogo alla critica e molto meno alla storia, ond’è che molto ei ci lascia a desiderare si nell’una che nell’altra.
[13] Sarebbe in me imperdonabile baldanza il presumere di poter supplire a ciò che non hanno fatto gli altri, e che probabilmente non si farà così presto. Un sistema drammatico, almeno, com’io lo concepisco, appoggiato sull’esatta relazione de’ movimenti dell’animo cogli accenti della parola, o del linguaggio, di questi colla melodia musicale, e di tutti colla poesia richiederebbe riuniti in un sol uomo i talenti d’un filosofo come , d’un grammatico come , d’un musico come , o , e d’un poeta come . Tuttavia finché qualche cosa di meglio non ci si appresenta, emmi paruto necessario, non che opportuno, il premettere due Ragionamenti sì per ovviare alla mancanza degli scrittori su questo punto, come per aver qualche principio fisso, onde partire nell’esame de’ poeti drammatici. Nel primo, derivando dagl’intimi fonti della filosofia la natura del melodramma, si cercherà di rintracciare independentemente da ogni autorità, e da ogni esempio le vere leggi di questo componimento, e i limiti inalterabili, onde vien separato dalle altre produzioni teatrali. Nel secondo s’investigherò la proporzione che ha per la musica la lingua italiana, e ciò che rimane a farsi per perfezionarla. Se le riflessioni in gran parte nuove che ho procurato spargere su tali materie, come su parecchie altre contenute in questo libro, non bastassero a formar un sistema completo (lo che non è stato mai il mio oggetto) e se i maestri dell’arte non le trovassero degne di loro, potranno, esse almeno divenir opportune ai giovani, pei quali furono scritte principalmente. Io mi terrò fortunato se da miei errori altri prenderà occasione d’illustrar con penna più maestrevole codesto bell’argomento, non men degno delle ricerche d’un filosofo che delle premure d’un uomo di gusto.
Capitolo primo §
Saggio Analitico sulla natura del dramma musicale. Differente che lo distinguono dagli altri componimenti drammatici. Leggi sue costitutive derivanti dalla unione della poesia, musica e della prospettiva.
[1] Qualora sentesi nominare questa parola “opera” non s’intende una cosa sola ma molte, vale a dire, un aggregato di poesia, di musica, di decorazione, e di pantomima, le quali, ma principalmente le tre prime, sono fra loro così strettamente unite, che non può considerarsene una senza considerarne le altre, né comprendersi bene la natura del melodramma senza l’unione di tutte. Mi farò dunque a ragionare paratamente di esse, lasciando per ora il parlare del ballo, il quale non sembra costituire parte essenziale dell’opera italiana, giacché quasi sempre si frappone come intermezzo, e di rado s’innesta nel corpo dell’azione. In qualsivoglia altro componimento poetico la poesia è la padrona assoluta, a cui si riferisce il restante; nell’opera non è la padrona ma la compagna delle altre due, anzi in tanto si dice buona, o cattiva, in quanto più, o meno si adatta ai genio della musica, e della decorazione. Attalchè gli argomenti poeti ci, che acconci non sono ad invaghire gli orecchi colla soavità de’ suoni, né ad appagar l’occhio colla vaghezza dello spettacolo, sono per sua natura sbanditi dal dramma; come all’opposto i più atti sono quelli, che riuniscono l’una e l’altra delle anzidette qualità. Ma siccome la parte più essenziale del dramma viene comunemente riputata la musica, e che da lei prende sua maggior forza, e vaghezza la poesia, così le mutazioni da essa introdotte formano il principal carattere dell’opera.
[2] L’unione della musica colla poesia è dunque il primo costitutivo, che distingue codesto componimento dalla tragedia, e dalla commedia. né da tale unione risulta un tutto così inverosimile come pretenderebbero alcuni, a cui pare una stravaganza che gli eroi e l’eroine s’allegrino, s’adirino, e si dicano le loro ragioni cantando. Tal cosa sarebbe certamente un assurdo, se si dovesse prender al naturale, ma così non è nel dramma musicale, il quale, siccome avviene a tutti gli altri lavori delle arti imitative, non ha tanto per oggetto il vero quanto la rappresentazione del vero, né si vuole da esso, che esprima la natura nuda e semplice qual è, ma che l’abbellisca, e la foggi al suo modo. Al pittore non si comanda soltanto, che dipinga un uomo, ma che il perfezioni nel dipignerlo, aggiungendovi quella proporzione delle parti, e quella mistura de’ colori, ch’egli non ha comunemente. Così è fino a noi pervenuta la fama di Zeusi, che volendo far il ritratto di Elena, e non trovando alcun individuo della natura, il quale adeguasse quella sublime idea della perfezione, ch’egli avea nella sua mente concetto, raccolse da molte fanciulle bellissime i tratti più perfetti, onde poi un tutto formò, che non esisteva fuorché nella mente del pittore. Si richiede dal tragico, che esprima le passioni, e i caratteri, ma che gli esprima cogli stromenti propri dell’arte sua, cioè col verso, e collo stile poetico; altrimenti s’avesse a dipignere veramente le cose quali furono, sarebbe costretto a far parlar Maometto, e Zaira in linguaggio arabo piuttosto che in francese, in prosa familiare, e non in versi alessandrini. Così la musica imita la natura, ma la imita pei mezzi, che le si appartengono, cioè col canto e col suono: il qual linguaggio, attesa la tacita convenzione che passa tra l’uditore, e il musico, non è meno verosimile in se stesso di quello che lo sia il linguaggio dei versi, e l’assortimento de’ colori, poiché l’oggetto, che la musica ad imitar si propone, esiste realmente nella natura non altramenti, ch’esista quello, che prendono ad imitare la pittura, e la poesia. Onde accusar il dramma musicale perché introduce i personaggi che cantano, è lo stesso che condannarlo perché si prevale nella imitazione de’ mezzi suoi invece di prevalersi degli altrui: è un non voler, che si trovino nella natura cose atte ad imitarsi col suono, e col canto: è in una parola accusar la musica perché è musica.
[3] Posta la prima legge fondamentale del dramma, la filosofia propone a sciogliere il seguente problema : Data la intrinseca unione della poesia colla musica, quai mutazioni debbono sultare da sì fatto accoppiamento in un tutto drammatico. Tentiamo, se si può, di metter in chiaro cotal questione, che abbraccia tutto l’argomento del nostro discorso. S’io non m’inganno, la soluzione dipende dall’esame intimo delle relazioni, che corrono fra le due facoltà.
[4] Il poeta ha per oggetto tre cose: commuovere, dipingere, ed istruire. Commuove il poeta or direttamente scoprendo negli oggetti quelle circostanze, che hanno più immediata relazione con noi, e che ridestano per conseguenza il nostro interesse, giacché niuna viva affezione può nascere nell’animo nostro verso un oggetto, il quale indifferente del tutto ci sia: ora indirettamente muovendo col ritmo, e colla cadenza poetica, colla inflessione, e coll’accento naturale della voce quelle fibre intime, all’azione delle quali è, per così dire, attaccato il sentimento.
[5] Questa seconda maniera è quella che rende la poesia tanto acconcia ad accoppiarsi colla musica: anzi siffatta proprietà, la quale fino ad un certo segno è comune ugualmente alla eloquenza che alla poesia, non è che il fondamento della melodia imitativa, ovvero sia del canto: dal che ne seguita eziandio, che la possanza della eloquenza se non in tutto almeno in gran parte dipende dalle qualità musicali della lingua, ovvero sia dalla magia de’ suoni combinati diversamente nel numero oratorio, o nella pronunzia. Dipinge ora rivestendo d’immagini materiali le idee spirituali ed astratte: ora raccogliendo le bellezze sparse nella natura per ragunarle in un solo oggetto: ora la proprietà d’un essere ad un altro trasferendo a vicenda: ora cercando, che la collocazione, la pronunzia, e il suono stesso de’ segni arbitrari, cioè delle parole l’immagine mentale da lui creata esprimano perfettamente. Anche in quest’ultima proprietà un’altra ragione d’analogia della musica colla poesia consiste: imperciocché quanto più la espressione poetica de’ motti s’avvicina alla natura delle cose, che si rappresentano, tanto più agevolmente potrà la musica le cose stesse imitare. Istruisce cercando per mezzo della cognizione del bello intellettuale, e del bello fisico portar gli uomini alla cognizione, e all’amore del bello morale. Sebbene codesto oggetto non forma un carattere distintivo della poesia se non in quanto è una conseguenza delle altre due: cosicché una istruzione scompagnata da ogni sentimento e da ogni immagine nulla affatto si converebbe alla poesia. Ciò si vede in il più celebre poeta filosofo dell’antichità, il quale si rende insoffribile, allorché, abbandonati i suoi vaghi episodi, s’innoltra nel puro didascalico, e più chiaramente si scorge ne’ moderni suoi pretesi imitatori, i quali si credono di poter discacciar Apollo dal seggio del parnaso, e di farci assaporire la bevanda de’ numi qualora ci regalano pezzi d’ottica, d’idrostatica, e talvolta di nuda e secca geometria nelle loro gotiche poesie2.
[6] Egli è vero che negli autori anche più celebri si trovano spesso delle sentenze morali, che paiono scompagnate dall’uno e dall’altro, e già veggo alcuno farmisi incontro con alla mano il Saggio sopra l’uomo del , e con qualche altra poesia inglese, o francese tutta di moralità e d’istruzione composta: ma esaminando bene cotai componimenti, si troverà, che le sentenze loro o si risolvono ultimamente in qualche movimento di passione, o in qualche immagine, o che altrimenti annoiano tosto.
[7] Delle tre cose accennate la musica non si propone se non due sole, come fine principale il commuovere, come subalterno il dipignere. Commuove la musica ora imitando colla melodia vocale le interiezioni, i sospiri, gli accenti, l’esclamazioni, e le inflessioni della favella ordinaria, onde si risvegliano le idee, che delle passioni furono principio: ora raccogliendo cotali inflessioni, che si trovano sparse ordinariamente nella voce appassionata, e radunandole in un canto continuo, che è quello che soggetto s’appella: ora ricercando coi suoni armonici, colla misura, col movimento, e colla melodia que’ fisici riposti nervi, i quali con certa ma inesplicabil legge movendosi, all’odio, o all’amore, all’ira, al gaudio, o alla tristezza ci spingono. Dipinge ora imitando col romore degli stranienti dal ritmo musicale dottamente regolati il suono materiale degli oggetti fisici, che sono capaci d’agire sull’animo nostro qualora li sentiamo nella natura, come fa la musica allorché esprime l’armeggiar d’una battaglia, o il fragore del tuono: ora risvegliando colla melodia le sensazioni, che in noi producono le immagini di quegli oggetti, i quali per esser privi di suono non cadono sotto la sfera della musica, come allorché non potendo significare la tomba di Nino, l’odore de’ fiori, o tai cose, che appartengono ad altri sensi e non all’udito; il musico rappresenta invece loro l’effetto, che in noi cagiona la veduta maninconica di quel mausoleo, o il placido languore che inducono i fiori odorati: ora eccitando per mezzo dell’udito movimenti analoghi a quelli, ch’eccitano in noi gli altri sensi; come allora quando il musico volendo esprimere il tranquillo riposo d’uno che dorme, ovvero la solitudine della notte, e il silenzio maestoso della natura, trasporta, dirò così, l’occhio nell’orecchio, e ci rappresenta la sospensione e il terror segreto, onde vien compreso lo spettatore nel rimirare siffatti oggetti. Il lettore mi risparmierà l’entrare in più profonda ricerca intorno a questo punto. Cotale spiegazione, che tutta dipende dalla maniera con cui agiscono i suoni sulla nostra macchina, e dalla intima relazione che passa tra la vista e l’udito, relazione sospettata prima dalla esperienza, poi messa nel suo maggior lume dal Neutono, oltrachè diventerebbe troppo prolissa, non è essenzialmente legata col mio argomento3.
[8] L’istruire direttamente non le appartiene in verun conto, imperocché, essendo destinata a parlar ai sensi, e per mezzo loro al cuore, né potendo agire per altra via che per quella del movimento, non ha conseguentemente i mezzi d’arrivare fino all’astratta ragione. I suoni altro non sono che suoni: rendono le sensazioni e le immagini ma in niun modo le idee. Può nulla meno la musica accompagnare le sentenze istruttive della poesia, se non colla viva espressione d’un canto imitativo, almanco seguitando colla misura, coll’andamento e col tempo il tuono generale del discorso, purché i versi, che s’accompagnano, non abbiano suono così malagevole e rozzo, che al canto inetti riescano, e per conseguenza non siano drammatici. Per esempio in codesti versi:
«Comincia il regnoDa te medesmo: i desideri tuoiSiano i primi vassalli: onde i soggettiAbbiano in chi comandaL’esempio d’ubbidir. Sia quel che deiNon quel che puoi dell’opre tue misura.Il pubblico procuraPiù che il tuo ben. Fa che in te s’ami il padre,Non si tema il tiranno. È de’ regnantiMal sicuro custodel’altrui timore…»
sebbene la musica non ne renda il senso, poiché in essi nulla si trova d’immaginativo né d’affettuoso, può nonostante accrescer colla melodia naturale maggior forza alle varie posature e modulazioni della voce. Ma siccome non ha la disposizione intrinseca, che s’abbisogna per isprimerli, niente niente che duri il dissertare diverrà un rumore insignificante, che avrà l’apparenza esterna della musica senz’averne io spirito.
[9] Da questo paragone della musica colla poesia risultano due osservazioni spettanti al mio proposito. La prima che la musica è più povera della poesia, limitandosi quella al cuore, all’orecchio, e in qualche modo alla immaginazione, laddove questa si stende anche allo spirito, ed alla ragione. In contraccambio la musica è più espressiva della poesia, perché imita i segni inarticolati che sono il linguaggio naturale, e per conseguenza il più energico, egli imita col mezzo de’ suoni, i quali, perché agiscono fisicamente sopra di noi, sono più atti a conseguire l’effetto loro che non sono i versi, i quali dipendendo dalla parola, che è un segno di convenzione, e parlando unicamente alle facoltà interne dell’uomo, hanno per esser gustati bisogno di più squisito, e dilicato sentimento. Quindi è, che una melodia semplice commuove universalmente assai più che non faccia un bel componimento poetico. La seconda è che la poesia fatta per accoppiarsi colla musica, debbe rivestirsi delle qualità, che questa richiede, e rigettarne tutte le altre: circostanza che tanto più divien necessaria quanto la lingua è men musicale, poiché qual cosa imiterebbe la musica in un linguaggio privo d’accento, se la poesia non le somministrasse né sentimenti, né immagini?
[10] La breve analisi fatta finora ci ha, se mal non m’appongo, appianata la via alla soluzione del problema proposto. Se la poesia dee secondare l’indole della musica, e se questa non può esprimere se non gli oggetti, che contengono passione, o pittura, dunque il dramma musicale dee principalmente versare circa argomenti, che abbondino dell’una e dell’altra, e rigettarne quelli altresì che apportando seco lente discussioni, lunghi ragionamenti, o lunghi consigli, al genere istruttivo, del quale la musica non è capace, s’appartengono perfettamente. E così abbiam trovata la prima qualità essenziale, che distingue l’opera dalla tragedia. Questa non assoggettandosi alle leggi della musica, può maggiormente approfittarsi dei vantaggi della poesia, onde non le si disconvengono i dialoghi ragionati, gli affari politici, e tali cose, purché si facciano a proposito, e con diletto. La prima scena del Pompeo in , e il primo atto del Bruto in sono squarci di singolar bellezza in quelle tragedie. Ma se trasferirli volessimo all’opera farebbero morir di languore gli uditori.
[11] Quindi l’andamento del dramma dee essere rapido: imperocché se il poeta si perde intorno ai punti troppo circostanziati, la musica non può se non assai tardi arrivare a quei momenti d’interesse e d’azione, dove essa principalmente campeggia. Dal che nascono due inconvenienti: il primo che essendo il linguaggio della musica troppo vago e generico, e dovendo conseguentemente per individuare l’oggetto che vuol esprimere, far lunghe giravolte, e scorrere per moltiplicità di note; l’azione diverrebbe d’una lunghezza insoffribile se il poeta non si prendesse la cura di troncare le circostanze più minute. Il secondo, che siffatte minutezze per esser prive di calore e di energia non potrebbero accompagnarsi se non da modulazione insignificante, e triviale, che niuno spirito aggiungesse alle parole. Un passaggio facile, e pronto da situazione in situazione, un risparmio di circostanze oziose, una serie artifiziosamente combinata di scene vive ed appassionate, una economia di discorso, che serva, per così dire, come di testo, su cui la musica ne faccia poscia il commento; ecco ciò che il poeta drammatico debbe somministrare al compositore. Lasciando al tragico l’ampiezza delle parole, e il lento, ed artifizioso sviluppo degli avvenimenti, appiglisi egli pure alla precisione de’ sentimenti, e alla speditezza, e rapidità dell’intreccio. Merope nella tragedia francese che porta il suo nome, fa una lunga ed eloquente parlata chiedendo a Polifonte, che le venga restituito il proprio figliuolo. Una madre introdotta da in simili circostanze si spiega in poche parole:
«Rendimi il figlio mio:Ahi! mi si spenga il cor:Non son più madre, oh Dio!Non ho più figlio.»
[12] Ecco un esempio della concisione ch’esige il melodramma. Ma questi quattro versetti soli accompagnati dalla mossa e vivacità che ricevono da una bella musica faranno, come riflette sagiamente nel suo Discorso sul poema lirico, un effetto vieppiù sorprendente sugli animi degli uditori, che non la tragica e artifiziosa scena della Merope di .
[13] Per la stessa ragione una orditura troppo complicata mal si confarebbe colla natura del dramma. La musica, perché faccia il suo effetto, ha bisogno di certi intervalli o distanze, che lascino luogo alla espressione, altrimenti scorrendo su troppo velocemente per le diverse note, vi si confondono i passaggi, e l’armonia si disperde. Laddove se le si accoppia una poesia troppo carica d’incidenti, l’affollamento di essi fa che l’una non vada mai d’accordo coll’altra, e che la musica non possa marcar le situazioni, che le somministra la poesia. Ed ecco un altro distintivo dell’opera cioè la simplicità, e la rapidità dell’argomento.
[14] La dipendenza altresì della poesia rispetto alla musica induce una mutazione non piccola nello stile. Questo nella tragedia debbe essere puramente drammatico, nel dramma musicale debbe essere drammatico lirico. Per far capir meglio tal differenza è d’uopo risalire fino ai principi.
[15] Il canto è una espressione naturale degli affetti dell’animo ispirataci dall’istinto, come ci sono ispirati gli altri segni esterni del dolore, gaudio, tristezza, voluttà, speranza, e timore, colla circostanza che ciascuna di esse passioni ha il suo segno particolare, che la esprime, laddove il canto le esprime tutte senza differenza. Il canto suppone dunque agitazione nell’animo, come la suppongono le lagrime, e il riso, e tanto più grande quanto esso è più vivo e calcato. Cosicché chi canta è in qualche maniera fuori dal suo stato naturale come si dicono esser fuori di se gli uomini agitati da qualche sorpresa, o affetto: dal che ne siegue che il linguaggio, che corrisponde al canto, debbe essere diverso dal comune, cioè, tale quale si converrebbe ad un uomo, che esprime una situazione dell’animo suo non ordinaria. Ora cotal alienazione, o agitazione, o come vogliamo chiamarla, o ha per oggetto le cose che interessano vivamente il cuore, e allora lo stile di chi canta sarà appassionata, ovvero ha per iscopo quelle che colpiscono l’immaginazione, e in tal caso chi canta userà del linguaggio immaginativo, o pittoresco, il quale in sostanza non è altro che il lirico. Quindi lo stile figurato, e traspositivo de’ poeti lirici, quantunque paia strano a prima vista, è nondimeno assai conforme alla natura; imperocché, supponendo che e’ cantino ciò che dicono, si suppone parimenti, che siano invasi, o sorpresi. Il canto è dunque il linguaggio della illusione, e chi canta inganna se stesso, e chi ascolta eziandio, facendogli parere d’esser divenuto maggior degli altri, e quasi divinizzatosi. A mascherare maggiormente l’errore contribuisce la musica strumentale, la quale accoppiatasi colla vocale rende più forte, e più durevole la sorpresa, e trattenendo l’uditore della sua dolcezza, fa sì ch’ei non si avvegga della sua illusione, come il cinto misterioso d’Armida impediva Rinaldo dal conoscere ch’era incantato. La possanza dell’una e dell’altra a risvegliar idee grandi, sublimi, e fuori dell’ordinario si vede da ciò che spesso i sacri Profeti avanti di proferir i vaticini ispirati loro da Iddio, richiedevano il suonatore, che risvegliasse loro lo spirito. Si vede tra i profani nell’incominciamento d’alcune odi d’, e più di lui nell’inimitabile , appo cui tutti i nostri , , , , , , e sono ciò, che è l’uccello, che svolazza intorno alle paludi, paragonato coll’aquila, che spazia imperiosamente pell’immenso vuoto dell’aria.
[16] La natura stessa del canto ci porta dunque ad ammettere lo stile lirico. Perciò molti modi di dire, che grandemente piacciono nel dramma, non piacerebbero punto nella tragedia. Per esempio questa leggiadrissima arietta del :
«Placido zeffiretto,Se trovi il caro oggetto,Digli, che sei sospiro,Ma non gli dir di chi.Limpido ruscelletto,Se ti rincontri in leiDille, che pianto sei,Ma non le dir qual ciglioCrescer ti fe’ così.»
o questi altri versi del nell’Iside pieni di dilicatezza e d’armonia:
«Le zéphyr fut témoin, l’onde fut attentiveQuand la nimphe jura de ne changer jamais,Mais le zéphyr léger et l’onde fugitive,Ont enfin emporté les serments qu’elle a faits.»
sarebbero senza dubbio mal collocati nell’Alzira, nel Polieuto, o nel Mitridate, ma bisognerebbe esser troppo in odio al dio che presiede ai musicali diletti, per volerli escludere dal teatro lirico. Ci è ancora una ragione di più per ammetterlo nell’opera, ed è l’uniformità che risulterebbe nella musica, se dovesse aggirarsi soltanto intorno ai soggetti patetici, privandoci noi spontaneamente della ricca sorgente di bellezze armoniche, che somministra la pittura degli altri oggetti. Bellissima è la musica, che esprime le affettuose smanie di Timante:
«Misero pargolettoIl tuo destin non sai:Ah! non gli dite maiChi fosse il genitor.Come in un punto, oh Dio!Tutto cangiò d’aspetto!Voi foste il mio diletto,Voi siete il mio terror.»
[17] Ma non è men bella l’altra che corrisponde a quell’aria tutta lirica dell’Orfeo:
«Chi mai dell’EreboFra le caliginiSull’orme d’ErcoleO di PiritooConduce il piè?D’orror l’ingombrinoLe fiere Eumenidi,E lo spaventinoGli urli del CerberoSe un dio non è.»
[18] Quanto più varia, e per conseguenza più dilettevole non si rende la musica frammezzando le bellezze di questo secondo genere a quelle del primo? Qual vaghezza di contrasti, qual ricchezza non si cresce alla poesia? Dal che si vede che troppo nemici de’ nostri piaceri si sono mostrati quegli autori per altro stimabili, i quali hanno voluto tutte le parti dello spettacolo drammatico al solo genere appassionato ridurre.
[19] È però d’avvertirsi, che sebbene il principio da noi stabilito sia generalmente vero, si modifica tuttavia diversamente secondo i diversi generi di poemi, ai quali si applica. Nell’ode siccome chi canta è particolarmente agitato dall’estro, e siccome la sua fantasia si suppone essere nel maggior delirio, così la espressione de’ concetti debbe essere più disordinata, e più libera, piena di voli ardimentosi, di trasposizioni e d’immagini, che esprimano lo stato in cui si trova lo spirito del cantore. Ma nel dramma, dove né si può, né si debbe supporre che i personaggi abbiano la mente alienata fino a tal segno, e dove l’azione, l’interesse e l’affetto hanno tanto luogo, il linguaggio, che corrisponde, può essere lirico bensì ma con parsimonia, quanto basti per dar al canto grazia e vivacità, senza toglier i suoi diritti alla teatrale verosimiglianza, e al diverso genere di passione, che vi si rappresenta. Quindi l’origine dello stile lirico drammatico proprio dell’opera in musica, la esatta proporzione del quale è quella che caratterizza sopra tutti gli altri.
[20] Si osserva facilmente quanto la natura del canto e dello stil musicale debba influire sul carattere de’ personaggi. Se il canto è il linguaggio del sentimento, e della illusione, dunque non si debbono introdurre a parlarlo se non persone capaci di commozioni vive e profonde, né in altre circostanze che in quelle che suppongono agitazione. Mal s’applicherebbe la più possente e la più energica delle arti d’imitazione ad un discorso freddo e insignificante. Mal si confarebbe ad un , ad uno stoico di viso arcigno, che scevro da ogni commozione d’affetto mi chiudesse in un’arietta quattro apotegmi del liceo. Male ad un vecchio, che agghiacciato dalla età i rivolge verso di se unicamente la sensibilità, che gli altri oggetti richiederebbono. Male ad uno statista, ad un avaro, ad un politico, a que’ caratteri insomma, che capaci solo di passioni sordide, o cupe, e per interesse, o per le circostanze divenuti guardinghi, non sciolgono giammai l’animo ad un ingenuo, e facile trasporto. Siffatti personaggi, usando per lo più d’un tuono di voce uniforme e composto, non fanno spiccar nella favella loro quella chiarezza e forza d’accento, quella varietà d’inflessioni, che sono l’anima della musica imitativa. Però si dee schivare che s’introducano nei melodramma, oppure se vi si introducono, non dovranno occupare se non un luogo subalterno, lasciando ad essi l’onore d’ottener posti più riguardevoli pella tragedia, dove una orditura più circostanziata apre più vasto campo allo sviluppo di tai caratteri. Callicrate nel Dione, Lusignano nella Zaira, Polidoro nella Merope, e simili altri fanno un gran effetto sul teatro tragico, perché i personaggi che imitano, parlano alla ragione eziandio, e perché la poesia piace non meno quando istruisce che quando commuove; la prima delle quali cose può conseguirsi egualmente coi caratteri freddi, tranquilli, o dissimulati, che coi loro opposti. Ma la natura del canto, per cui vuolsi energia e commozione d’affetto, e che non sa imitare dell’anima se non il trasporto, li rigettarebbe come inopportuni al suo scopo. Ma, poiché essi sono talvolta necessari allo sviluppo degli avvenimenti, qual luogo deggiono ottenere precisamente nel melodramma?
[21] Ecco che l’accennata interrogazione ci porta ad un altra
cognizione non meno interessante, a quella cioè dei diversi generi di canto che
corrispondono al diverso carattere, e alla situazione diversa dei personaggi. Havvi una
situazione tranquilla, nella quale eglino s’informano a vicenda dello stato attuale
delle cose, con cui si espongono le circostanze, e si riempie, per così dire,
l’intervallo che passa tra un movimento di passione e un altro. Codesto genere, che
appartiensi perfettamente al narrativo, è quello che caratterizza il recitativo
semplice, di cui sono proprie siccome d’ogni altra narrazione la perspicuità, la
chiarezza e la brevità, osservando che l’ultima di queste doti è più necessaria
nell’opera che nella tragedia sì per la strettezza, e rapidità
che la musica esige, e sì perché, essendo il canto o la melodia l’ultimo fine della
musica imitativa, l’uditore è impaziente finché non arriva a conseguirlo. Nel recitativo
semplice adunque, che declamazion musicale piuttosto che canto dee propriamente
chiamarsi, giacché della musica altro non s’adopra che il Basso, che serve di quando in
quando a sostenere la voce, né si scorre se non rade volte per intervalli perfettamente
armonici: hanno il lor luogo i personaggi subalterni, che noi abbiamo supposto finora
inutili al canto. Havvi un’altra situazione d’animo più veemente e concitata, dove i
primi impeti delle passioni si spiegano, quando l’anima, ondeggiando in un tumulto
d’affetti contrari, sentesi tormentata dalle proprie dubbiezze senza però sapere a qual
partito piegare. Siffatta incertezza, e l’alternativo passaggio da un movimento in un
altro diverso è quello che forma il recitativo obbligato, lo stile del quale dee
conseguentemente essere vibrato, e interciso, che mostri nell’andamento suo la
sospensione di chi parla, e il turbamento, e che lasci alla musica strumentale
l’incombenza di esprimere negli intervalli della voce ciò che tace il cantante. L’anima
stanca delle sue incertezze si risolve finalmente, e abbraccia quel partito che più
confacente le sembra. Gli affetti più liberamente si spandono, e sono, per così dire,
nell’ultimo lor periodo. Cotal situazione è la propria dell’aria, la quale considerata
sotto questo filosofico aspetto non è altro che la conclusione, l’epilogo, o epifonema
della passione, e il compimento più perfetto della melodia. Un esempio rischiarerà
meglio il mio pensiero. Selene sorella della
sfortunata Didone viene a ragguagliarla
ch’Enea senza punto curarsi delle sue
preghiere ha nel silenzio della notte ragunati i suoi compagni, allestite le navi, ed è
fuggito da Cartago. Questa scena è composta di semplice recitativo. Didone colpita dalla
improvvisa novella ondeggia fra un tumulto d’affetti, di pensieri, e di dubbi, se deggia
con mano armata inseguir Enea che fugge, o darsi in braccio a Jarba suo rivale, o piuttosto procacciarsi da disperata
la morte. Codesta situazione, che comunemente si esprime in un monologo, è propria del
recitativo obbligato. Si decide infine, e il desiderio di morire la vince: ecco il luogo
opportuno per l’aria. Che se il personaggio non si risolve, ma rimane nelle sue
dubbiezze, come talvolta addiviene, allora l’aria dovrà essere come una cscita, una
scappata del sentimento, cioè quella riflessione ultima, in cui l’anima si trattiene per
isfogar in quel momento il suo dolore, o qualsivoglia altra affezione. Siffatta
riflessione alle volte è morale cavata dall’avvertenza che si fa alle proprie
circostanze; in tal caso l’aria chiude naturalmente una sentenza; giacché io non saprei
convenire col cavalier 4,
né col 5, i
quali ogni e qualunque sentenza vorrebbero escludere dalle arie, «perché, dicono essi, della passione non è proprio il
dommatizzare»
. Certamente non è proprio di essa, se per «dommatizzare»
s’intenda l’intuonar sul teatro un capitolo di , ovvero alcuna di quelle lunghe tiritere morali, di che tanto
abbondano le tragedie de’ cinquecentisti, nel qual senso sono state ancora da me
condannate: ma non è già così di piccole, e brievi sentenze, che spontaneamente vengono
suggerite all’animo dallo stato presente del nostro spirito. Le quali lontano dal
disconvenirsi ad una persona appassionata le sono anzi naturalissime per quel segreto
vincolo, che lega insieme tutte le facoltà interne dell’uomo, onde avvien che la
riflessione desti in noi le passioni, e queste destino la riflessione scambievolmente,
come ognun può osservare in se stesso, e come vedesi praticato dai primi autori.
[22] L’errore di tal opinione è nata al mio avviso dal non aver penetrato abbastanza nella filosofia delle passioni, e dall’avere stabilito come regola generale ciò che dovrebbe essere una eccezione soltanto. V’ha delle passioni che ammettono le sentenze riflesse, v’ha di quelle che le ricusano. Fra queste ultime è l’amore, e la ragione dipende dall’indole di quell’affetto. L’amante, che prostrato a’ piedi della sua bella, chiede la sospirata mercede de’ suoi lunghi sospiri, sa benissimo ch’egli non è debitore né al suo ingegno, né alla sua dottrina della fortuna d’essere riamato. Sa che l’amore indipendente per lo più della riflessione, e della ragione non ha altro domicilio che il cuore, né altra legge che quella, che gli detta l’affetto. Le lagrime sono li suoi argomenti: la fedeltà, e la costanza sono i suoi titoli: tutta la sua logica consiste nel far valere la sua tenerezza, e la sua sommissione. Sarebbe dunque inutile anzi contrario al fine ch’ei si propone, l’assalire il cuore della sua amata con teoremi, o con principi tratti da una filosofia, che l’amore non riconosce.
«Egle distratta intantoTorna, disse, a ridir, ch’io nulla intesi.»
[23] Ecco il perché gli apotegmi amorosi riescono così insipidi sul teatro. Lo stesso dico dello sdegno, il quale determinandosi sul momento, non ha né il tempo né l’occasione di generalizzare le idee. Non è così per esempio dell’ambizione. L’oggetto che questa si propone di sovrastar tutti gli altri, e di regnar, se potesse, in un universo di schiavi, non può conseguirsi senza un intima cognizione degli uomini, delle loro proprietà, e debolezze, delle vicende della fortuna, delle circostanze de’ tempi, e de’ mezzi di prevalersene. Cotale studio suppone nell’ambizioso uno spirito d’osservazione, e di sistema capace di rilevar la connessione delle cause coi loro eventi, e di risalire fino ai principi. Èdunque assai conforme all’indole di tal passione l’esprimersi con massime generali, che suppongono meditazione. Non è verosimile che Mirtillo nel Pastor fido la prima volta, che si abbocca con Amarilli per iscoprirle il suo amore, s’intertenga con essa lei a far, per così dire, una scaramuccia di sentenze, né ch’egli dica
«Non è in man di chi perdel’anima il non morire.»
nè ch’ella risponda
«Chi s’arma di virtù vince ogni affetto»
o ch’ei ripigli
«Virtù non vince ove trionfa amore»
affinch’ella soggiunga
«Chi non può quel che vuol, quel che può voglia»
colla lunga filastrocca che seguita. Ma è naturale bensì, che Artabano compreso da smoderato desiderio di regnare, al quale ha le sue mire indirizzate, si spieghi col figlio in tali termini:
«È l’innocenza, Arbace,Un pregio che consisteNel credulo consensoDi chi l’ammira, e se le togli questoIn nulla si risolve: Il giusto è soloChi sa fingerlo meglio, e chi nascondeCon più destro artificio i sensi suiNel teatro del mondo agli occhi altrui.»
[24] Nel primo si vede il poeta, che vuol far pompa di spirito in mancanza del sentimento; nel secondo si scorge un uomo, cui la sua passione ha fatto divenir scellerato per sistema. Dall’applicazion convenevole di tai principi alle diverse passioni dedur si potrebbe una teoria generale cavata dalla natura delle cose, che risparmierebbe molte critiche poco fondate, e che riuscirebbe utilissima a chi vuol innoltrarsi nella difficile, e delicata carriera del teatro.
[25] Lo stesso dee dirsi delle comparazioni. Mi sembra egualmente ingiusto lo sbandirle affatto dal dramma, che il volerle tutte senza eccezione difendere. L’uomo generalmente è più dominato dai sensi che dalla ragione. Le catene colle quali la natura l’ha legato agli altri esseri dell’universo, e la necessaria dipendenza, in cui vive, degli oggetti esteriori, lo costringono sovente a paragonarsi con essi, e a discoprirvi le relazioni segrete che passano tra la natura loro e la propria. La fantasia ripiena di ciò che le vien tramandato per mezzo degli organi non sa creare se non immagini corrispondenti a quello che vede, e l’uomo, sul quale ha codesta facoltà sì grande imperio, non sa immaginare le cose anche più astratte se non rivestite delle proprietà che osserva negli oggetti sensibili. Quindi l’origine della metafora, figura la più conforme di tutte alla umana natura, poiché la veggiamo usarsi ad ogni momento dai fanciulli, e dalle persone più rozze anche inavvertentemente ne’ loro famigliari discorsi. “Ardo di rabbia”, “cielo allegro”, “giornata maninconica” con cento altre somiglianti espressioni s’odono ad ogni tratto nella bocca de’ più idioti. Quindi l’origine eziandio delle similitudini egualmente naturali all’uomo, allorché non trovando espressione che corrisponda alla vivacità del suo concetto mentale, s’appiglia per farsi capire alla comparazione colle cose sensibili. Nel che è da osservarsi in confermazione del mio proposito, che l’uso del parlar figurato e comparativo tanto è maggiore in un popolo quanto è più scarso il linguaggio, e meno progressi v’ha fatto la coltura delle artie delle scienze. Leggansi le prime poesie di tutte le nazioni, come sono i frammenti degl’islandesi, i poemi d’, le favole di , il Gulistan di , e le canzonette americane, e vi si troverà una somiglianza che a prima vista sorprende, benché scritte da nazioni e in tempi così diversi. Tutto in esse è metafora, tutto è comparazione. Par quasi che il poeta non viva, e non senta, ma che senta e viva per lui la natura. A misura però che il linguaggio si stende, che le arti si moltiplicano, e che la coltura delle lettere vi si aumenta, lo stile delle figure e de’ segni s’indebolisce, s’introduce l’uso de’ termini astratti, la filosofia, riducendo l’espressioni al significato lor naturale, va poco a poco ammorzando l’entusiasmo, la poesia, e la eloquenza divengono più polite, e più regolari, ma conseguentemerite meno espressive: appunto come i grani d’oro assottigliati, e ridotti in foglia dagli artefici, i quali, come dice l’Abbate , perdono in solidità tutto ciò che acquistano in estensione.
[26] Può dunque il poeta drammatico metter in bocca de’ suoi personaggi le similitudini, ma acciochè riescano verosimili, dee metterle come lo farebbe la natura, e non altrimenti. Ora che insegna la natura su tal proposito agli uomini appassionati? A non usar di comparazioni dirette, a non fermarsi su tutti i punti di convenienza, a non esaminar ogni menoma relazione. Ciò s’appartiene piuttosto allo spirito tranquillo che alla passione, la quale occupata unicamente di se, non vede gli altri oggetti se non se alla sfuggita. Allorché sento una persona incollorita, che parlando di sé, prorompe:
«Orsa nel sen piagata,Serpe, che è al suol calcata,Tigre, che ha perso i figli,Leon, che aprì gli artigliFiera così non è.»
[27] Io conosco per cotali similitudini proferite con quella brevità ed energia un uomo dallo sdegno fortemente compreso. Ma qualora sento , che immerso ne’ più profondi pensieri mi vien fuori con questo paragone così circostanziato:
«Saggio guerriero anticoMai non ferisce in fretta?Esamina il nemicoIl suo vantaggio aspetta,E gl’impeti dell’ira,Cauto frenando va.Muove la destra e il piedeFinge, s’avanza, e cedeFinché il momento arrivaChe vincitor lo fa.»
allora io credo ascoltar un poeta, che vuol insegnarmi l’arte della
scherma, non già un personaggio occupato in pensieri di qualche importanza. Ciò che dico
della presente comparazione, dico di tutte le altre lavorate di simil gusto: potranno
esse prese separatamente considerarsi come squarci bellissimi di poesia, sulle quali un
gran musico potrà addattare una modulazione eccellente, ma sempre mancherà loro la
primaria bellezza, che consiste nella fedele espressione della natura, e nella relazione
col tutto. mi susurra all’orecchio
«pulcrum est, sed non erat hic locus»
. So che a difendere , il quale sovente inciampa in questo difetto,
s’adduce da alcuni l’esempio di , e
d’, che ne usarono talvolta nelle loro
tragedie; ma (dicasi con coraggio) né , né
, né hanno autorità che basti a distruggere i fermi ed inalterabili
principi della ragione.
[28] Se non che né comparazioni, né sentenze, né poesia fraseggiata dovranno aver luogo nei duetti, terzetti ecc. Ciò sarebbe lo stesso, che render affatto inverosimili tali componimenti, i quali hanno bisogno di tutta la magia della musica per esser probabili. Se si disamina con giusta critica niente v’ha di più stravagante a sentirsi, come ben riflette il marchese di nella sua bella lettera francese intorno al dramma intitolato l’Onfale, che due o tre personaggi, che parlano alla volta, e si confondono, dicendo le medesime parole, senza curarsi l’uno di quanto risponde quell’altro: ciò è contrario egualmente alla urbanità di chi parla, che alla sofferenza di chi ascolta, e però si sbandiscono a ragione dalla tragedia, dove hassi tanto riguardo al decoro. Nullameno considerando, che il duetto lavorato a dovere è il capo d’opera della musica imitativa, e che produce sul teatro un effetto grandissimo: riflettendo, che l’agitazion d’animo veemente, che ne’ personaggi si suppone, basta a rendere se non certa almeno possibile la simultanea confusione di parole, e d’accenti in qualche momento d’interesse, la quale possibilità basta a giustificar il poeta nella sua imitazione: ripensando, che lo sbandir dal dramma siffatti pezzi sia lo stesso, che chiuder una sorgente feconda di diletto alle anime gentili; il critico illuminato sarà costretto a commendarne l’uso non che a permetterlo, avvisandosi, che nelle belle arti l’astratta ragione debbe sottoporsi al gusto come questo si sottopone all’entusiasmo, e al vero genio. L’unico uffizio della critica è quello di perfezionarli, riducendoli alla maggiore semplicità e verosimiglianza. perché il poeta drammatico sceglierà per il duetto il punto più viva, ovvero sia la crisi della passione, userà il più che possa del dialogo nell’aria che lo precede, sarà ristretto ne’ periodi, conciso ed animato ne’ sentimenti.
[29] Che se pochi autori hanno osservate ne’ loro scritti siffatte distinzioni, se si leggono arie, recitativi, e duetti lavorati su principi diversi, ciò altro non prova se non che pochi autori hanno penetrato nello spirito dell’arte loro, e che appunto veggonsi tanti drammi noiosi e languidi perché non sono stati scritti secondo le regole, che prescrive una critica filosofica.
[30] Dall’esame dei cangiamenti, che dal suo accoppiamento colla musica nella poesia risultano, passiamo ora a vedere le mutazioni che induce la prospettiva, ovvero sia con vocabolo più esteso la decorazione. L’opera non è, o non dovrebbe essere, che un prestigio continuato dell’anima, a formare il quale tutte le belle arti concorrono, prendendo ciascuna a dilettare or l’uno l’altro dei sensi. E siccome dalla unione colla musica ne soffre alquanto la verosimiglianza poetica per la difficoltà, che v’ha nel concepire un aggregato di persone, che agiscono sempre cantando, e che siffatta difficoltà non si toglie via se non tenendo occupato lo spettatore in una perpetua illusione, la quale gli impedisca dal pensare al suo errore; così debbesi cercare per ogni verso di trattenerlovi, chiamando un senso in aiuto dell’altro, massimamente in que’ momenti d’ozio, dove non potendo la musica tutta la sua energia mostrare, lo spettatore in nulla occupato ha l’agio di riflettere a ciò ch’ei vede. A tal fine giovano la prospettiva, e la decorazione ora rivestendo i personaggi di quella pompa, che l’occhio invaghisce cotanto, ora spiegando tutte le bellezze della pittura, ora dando maggior risalto alla grandiosità coll’intenso e artifizialmente variato chiarore, ora offrendo alla vista oggetti sempre nuovi, e sempre vaghissimi nelle frequenti mutazioni della scena. Tutte le quali cose producono l’illusione, non solo come supplemento della musica, e della poesia, ma come un rinforzo eziandio dell’una e dell’altra, poiché assai chiaro egli è, che né l’azione più ben descritta dal poeta, né la composizione più bella del musico sortiranno perfettamente il loro effetto, se il luogo della scena non è preparato qual si conviene a’ personaggi che agiscono, e se il decoratore non mette tal corrispondenza fra gli occhi, e gli orecchi, che gli spettatori credano di essersi successivamente portati, e di veder in fatti que’ luogi ove sentono la melodia.
[31] Da quai prestigi eglino abbacinati, ed assaliti, a così dire nelle loro facoltà da tutte le bande veggonsi all’improvviso trasferiti, come Psiche, nel palazzo incantato d’amore. La loro immaginazione tutta occupandosi nel godimento, non lascia il tempo alla fredda ragione di riflettere se ciò che vede, sia vero o falso; l’immagine del luogo che si ha presente, seguita a mantener l’illusione quando più non s’ascoltano i suoni, e la grand’arte combinata della musica e della pittura consiste nel mantenerlo nell’errore costantemente. Guai se cade il velo dagli occhi! Guai se i critici vengono a destarlo dal sonno!
«Qu’il maudirait le jour, où son âme insenséePerdit l’heureuse erreur qui charmait sa pensée!»
[32] In una parola lo scopo del melodramma è di rappresentare le umane passioni per mezzo della melodia, e dello spettacolo, o ciò, che è lo stesso, l’interesse e l’illusione. Il buon gusto e la filosofia debbono tutto sagrificare a questi due fini, e siccome gli uomini radunati in società rinunziarono alla metà de’ suoi diritti per conservar illusa l’altra metà, così il poeta purché conservi ed accresca i dilicati piaceri del cuore, e della immaginazione, purché dia campo alla musica d’ottener compiutamente il suo fine, non dee imbarazzarsi gran fatto dei cicalecci dei critici, che gli si oppongono. La prima legge dell’opera superiore ad ogni critica è quella d’incantare, e di sedurre.
[33] Quindi, essendo necessaria per l’illusione la rapidità, e la prontezza dello spettacolo, (altrimenti colla lentezza lo spettatore s’accorgerebbe di essere stato ingannato) l’unità di scena, che s’opporrebbe all’una e all’altra, è bandita per sua natura dal dramma. Non è del tutto certo se sia ben fatto nella tragedia il mantener sempre la stessa scena, atteso che la premura di conservar la verosimiglianza in una cosa, è la cagione che venga violata in molte altre, mancandosi sovente al decoro, alla verità, ed al costume per far che tutti gli avvenimenti accadano nel medesimo luogo, siccome vedesi in alcune tragedie dei Greci, in quelle di , e più nei moderni grecisti dal fino al . Ma egli è fuor di dubbio nel melodramma, dove siffatta unità apporterebbe molti inconvenienti oltre gli accennati della tragedia. Abbiamo detto che la poesia debbe esser variata, che dee parimenti variarsi la musica in guisa che le situazioni si succedano rapidamente l’una all’altra, passando dall’affettuoso all’immaginativo, e dall’espressivo al pittoresco, cosicché tutto sia movimento, e azione. Ora cotal fine si distruggerebbe, se ciò che si vede, fosse in contradizione con ciò che si sente, se godendo l’orecchio della varietà successiva de’ suoni, l’occhio fosse condannato all’uniformità costante de’ medesimi oggetti, e se obbligassimo lo spettatore a sentire una musica di guerra negli appartamenti d’una fanciulla, o un’arietta d’amore in un campo di battaglia.
[34] E qui ci si affaccia un dubbio importante, che conviene dilucidare, il sapere cioè se alla interna costituzione del dramma convengano più gli argomenti tratti dal vero, oppure i maravigliosi cavati dalla mitologia o dalle favole moderne. Il motivo del dubbio sì è ch’essendo l’opera, siccome si è veduto, un componimento fatto per dilettare l’immaginazione e i sensi, pare che ad ottener un tal fine siano più acconci degli altri gli argomenti favolosi, ne’ quali il poeta, non essendo obbligato allo sviluppo storico de’ fatti, può variare a grado suo le situazioni, può essere più rapido ne’ passaggi, e può accrescere, e sostener meglio l’illusione, somministrando all’occhio maggior copia di decorazioni vaghe, nuove, e maravigliose. Inoltre, dovendosi escludere dalla musica tutto ciò che non commuove, e non dipinge, e dovendosi in essa sfuggire le situazioni, ove l’anima rimanga, per così dire, oziosa, sembra, che ciò non s’ottenga così bene negli argomenti di storia, ne’ quali la verosimiglianza seguitandosi principalmente, ci entrano per necessità discussioni, moralità, ed altre circostanze che legano un accidente coll’altro, e che sostituiscono la lentezza alla passione. O ci converrà dunque affrettar di troppo gli avvenimenti, o si cadrà nel languore. Tali sono a un dippresso le ragioni onde si sono mossi i Signori 6 e di 7 a dar la preferenza all’opera francese, dove regna il maraviglioso, sull’italiana, dove regna il vero comunemente.
[35] Ad onta della mia stima per così chiari scrittori ardisco di
slontanarmi dalla opinione loro, tanto più che la trovo appoggiata sulle false nozioni
ch’eglino ci danno dell’opera. «Presso di noi, dice il
primo, la commedia è lo spettacolo dello spirito: la
tragedia quello dell’anima: L’opera quello de
sensi.»
«L’opera, dice il secondo, non è che
il maraviglioso dell’epica trasferito al teatro»
.
Ma, se mal non m’appongo, in niuna delle anzidette cose è posta la natura del dramma in musica. Non nella prima, imperocché quantunque l’opera
debba parlare ai sensi, questo non è se non un fine secondario per arrivare al
principale, il quale consiste nel penetrare addentro nel cuore, e intenerirlo. Il fine
ultimo della tragedia e dell’opera è
dunque lo stesso, né si distinguono se non pei mezzi che vi conducono: quella per lo
sviluppo più circostanziato de’ caratteri e degli affetti, questa pei prestigi della
illusione, e della melodia.
[36] Altrimenti se l’opera non badasse che a dilettar i sensi, in che si distinguerebbe da una prospettiva, o da un concerto? A che gioverebbe la poesia piena di varietà, e d’interesse, che dee pur essere il principal fondamento? Si dirà forse, che l’Olimpiade, e il Demofoonte parlano meno all’anima di quello, che facciano la Fedra, o la Zaira? Ovvero altro non sono che lo spettacolo de’ sensi i caratteri di Tito, e di Temistocle?
[37] Non nella seconda, imperocché, essendo l’opera un componimento teatrale destinato alla mozione degli affetti, né distinguendosi dalla tragedia se non per le modificazioni che risultano dal suo accoppiamento colla musica, egli è chiaro che la sua essenza non è riposta nel maraviglioso dell’Epica, il quale ne distruggerebbe colla inverosimiglianza il principal interesse. Io prendo in questo luogo la parola “maraviglioso” come la prende il , vale a dire, per una serie di fatti che accadono senza l’intervento delle leggi fisiche dell’universo per la mediazione improvvisa di una qualche potenza superiore alla umana spezie. Ora in questo senso non si può dubitare, che il maraviglioso dell’Epica trasferito al dramma non faccia perdere il suo effetto a tutte le parti che lo compongono. Se riguardiamo la poesia, niun’artifiziale orditura si può aspettar dal poeta, quando i prodigi vengono a frastornare l’ordine degli avvenimenti, niun carattere, ben sostenuto, quando i personaggi sono chimerici, niuna passione ben maneggiata, quando chi si rallegra, o si rattrista sono le fate, i silfi, i geni ed altri esseri immaginari, de’ quali ignoro le proprietà e la natura, né la sorte loro sarà in alcun tempo la mia. Altrettanto varrebbe l’interessarmi per l’idee astratte di , o per l’ircocervo dei peripatetici8. Se riguardasi la musica, poca unità d’espressione vi può mettere il compositore, perché essa non si trova nell’argomento, poco interesse nella melodia, perché poco v’ha nell’azione, e perché la poesia non è che un tessuto di madrigali interrotti da stravaganze, la modulazione non è che un aggregato di motivi lavorati senza disegno. Se si pone mente alla esecuzione, niuna cosa più inverosimile, e insiem più difficile ad eseguirsi che codesti personaggi fantastici. Non vi par egli che l’atteggiamento, e le sembianze d’un fiume, dell’aquilone, del zeffiro, della paura, dei demoni e di tali nomi egualmente leggiadri siano facili ad imitarsi? È possibile trovar i gesti e il linguaggio, che s’appartiene ad essi. Un vestiario, una conciatura di testa, che divenga lor propria? Dove ne troveremo i modelli? Dov’è la regola di comparazione, onde possiam giudicare della convenienza, o disconvenienza?
[38] Essendo dunque gli argomenti maravigliosi sottoposti a tanti difetti, ragion vuole, che si debbano ad essi preferire gli storici. né non è già vero, come pretende il , che questi non somministrino al decoratore abbondanza di spettacoli nuovi e brillanti. Se non vi si vedrà sbuccar all’improvviso una furia, né si vedrà volar per l’aria una sfinge, un castello, che comparisce e poi si dilegua: se un sole non si prenderà il divertimento di ballar tra le nugole, con altre somiglianti strambezze solite ad usarsi nelle opere francesi, non è per questo, che non abbia in essi un gran luogo la prospettiva, rappresentando ameni giardini, mari tempestosi, combattimenti terrestri e navali, boscaglie, dirupi, tutto insomma il maestoso teatro della natura considerata nel mondo fisico: spettacolo assai più vario, più dilettevole e più fecondo di quello, che sia l’universo ideale fabbricato nel cervello de’ mitologi e de’ poeti. né ci è pericolo altresì che illanguidisca la musicale espressione, purché l’autore secondo le regole stabilite di sopra scelga nelle storie argomenti pieni d’affetto d’interesse sfuggendo le particolarità, che nulla significano: anzi il dover rappresentare gli umani eventi, che il musico ha tante volte veduti, o de’ quali almeno può formarsi una giusta idea, gli sarà di un aiuto grandissimo a vieppiù internarsi nella passione, e a penetrare più addentro nell’animo dell’uditore, come il dover dipingere eziandio gli oggetti naturali, che sono sotto gli occhi di tutti, gli darà più mossa e coraggio a destramente imitarli. Dal che si vede, che sebbene il pittore pochissimo, o niun giovamento ritragga dal musico, non è piccolo quello, che il musico può ritrar dal pittore. La veduta di una scena ben decorata, la vivacità e la forza degli oggetti espressi da lui riscalderanno maggiormente il genio del compositore. Non solo s’udirà sortir dalla orchestra più minaccioso il fragore della tempesta, che il decoratore avrà sul teatro maestrevolmente dipinta, non solo gli strumenti renderanno più spaventevole l’ingresso della grotta di Polifemo, ovvero i flutti d’un mare agitato, ma più dilettevole, e più grato apparirà coi suoni d’una bella sinfonia il solitario boschetto sacro al riposo, e alla felicità degli amanti: scorrerà più vivace, e più fresco il ruscello, dove Licida s’addormenta diverrà più vermiglia l’aurora, che presiede alle tenerezze di Mandane, e d’Arbace, e la volta de’ cieli pennelleggiata dalla mano d’Aiaccioli, o di Bibbiena parrà fregiarsi d’un azzuro più bello, e comparir più ridente dopo i suoni dolcissimi d’un .
[39] Che seppur qualche lentezza, o qualche momento ozioso, dove la musica non campeggi, si mischia ne’ drammi tratti dal vero, ciò prova soltanto che non tutte le situazioni sono egualmente suscettibili del medesimo grado di passione, che la musica dee talvolta piegarsi all’uopo della poesia in attenzione ai molti sagrifizi, che fa questa in grazia di quella, e che si ricchieggono degli intervalli, ne’ quali il poeta abbia luogo d’intrecciar fra loro gli avvenimenti, e l’uditore, e il musico di respirare, per così dire, dalla troppo viva commozione, che desterebbesi da una melodia continua. Le quali circostanze sono le stesse non solo per gli argomenti storici, ma pei favolosi eziandio, che: non vanno esenti da simili difetti, come si potrebbe far vedere coll’esame imparziale dei drammi di , se l’opportunità il richiedesse. Io convengo coll’illustre autore che non ogni argomento di storia è proprio dell’opera, siccome non è improprio ogni soggetto favoloso. Si dee schivar in quello il lungo raggiramento: si può ammetter questo qualora la favola mescolata di storica narrazione, e per lungo corso de’ secoli fino a noi tramandata, abbia acquistato una spezie di credibilità, che la spogli dell’inverosimile ributtante. Tali sarebbero a un dipresso Euridice ed Orfeo, la destruzione di Tebe o di Troia, Teseo ed Arianna, Ifigenia in Aulide con altre simili. Ma il voler bandire dal dramma musicale la verità per sostituirvi il piano adottato da , avvilir l’opera italiana per innalzar la francese, è lo stesso, che voler imitare il costume di que’ popoli della Guinea, che dipingono neri gli Angioli, perché stimano, che il sommo grado della bruttezza consista nel color bianco.
[40] Riandando le cose anzidetto possiamo a mio parere determinare in che consista il vero carattere dell’opera. Essa è la rappresentazione sul teatro di qualche azione diretta al gran fine di giovar dilettando: utile dulci. L’azione rappresentata può esser triviale come nella commedia, o grande come nella tragedia: quindi la distinzione dell’opera in seria, e in buffe. Ma quello, che non ha di comune né coll’una né coll’altra è il dover appagare non solo il cuore ma anche l’orecchio, e l’immaginazione; onde non può scompagnarsi dalla poesia i dal canto, dal suono, e dalla decorazione. Da tale accoppiamento risulta un tutto drammatico, che ha le sue leggi privative, e peculiari, come le hanno la tragedia, e la commedia. Cotali leggi in generale sono: Per il poeta: Primo: esaminare attentamente l’indole della musica: Secondo: conoscere le relazioni di questa colla lingua in cui scrive: Terzo: assoggettar alia musica la lingua e la poesia. Per il musico: Primo: conoscere il vero genio della lingua, e del verso. Secondo: saperne trar vantaggio dall’una, e dall’altro a pro della modulazione. Per il decoratore giovar alla illusione, disponendo la prospettiva secondo il piano stabilito dagli altri due. Ma dove la musica non vi si opponga, il poeta è tenuto a guardar i suoi diritti alla poesia, e al teatro, e l’abilità di lui consiste nel combinar le cose in maniera, che divenga il compagno, e non lo schiavo del compositore. Se questi il costringe talvolta a rimettere in alcuni punti della severità teatrale, non perciò vien egli dispensato dal badare alla verosimiglianza, al decoro, al costume, ai caratteri, all’unità d’azione, e di tempo, ed alle leggi universali a qualunque si voglia composizione drammatica, e la mancanza di queste non è men viziosa in lui di quello, che sia nel tragico, e nel comico. Anche in quelle occasioni, nelle quali gli si comanda, o gii si permette di piegarsi all’uopo della musica, non debbe portare il comando o la licenza fino all’eccesso, ma fin là soltanto dove il richiede il fine propostosi. Si vuol da lui che sfugga gli argomenti troppo lunghi o troppo complicati, ma non già che ne intrecci una serie di scene disunite, e senz’alcun disegno. Glissi permette l’uso delle comparazioni e della stile lirico drammatica, ma gli si raccomanda d’usarlo con sobrietà, e di consultar prima la verosimiglianza. Non dee star attaccato alla unità di scena, ma non dee trascurarla a segno, che ad ogni scena vi sia un cangiamento, o che gli spettatori vengano trasportati ad un tratto da Pechino a Madrid, o dall’Erebo all’Olimpo:
«In vitium ducit vitii fuga…»
[41] Insomma il poeta drammatico abbia pur fisso nell’animo, che il buon senso vuol essere da per tutto rispettato, e che gli squarci più vaghi d’immaginazione, e d’affetto non difendono un autore dalla censura quando va contro ai dettami della ragione. Chi fu più gran poeta di ? Chi più di lui tra i Francesi è ricco d’armonia, di numero, di colorito, di genio, d’immagini, insomma di vera poesia? Eppure per non aver consultato il buon senso nell’orditura de’ suoi drammi fu posto in ridicolo da 9.
[42] Dalle leggi generali stabilite di sopra relativamente alla interna costituzione del dramma si deducono molte altre in particolare spettanti alla natura delle parti che lo compongono. Ma molte di esse sono state di già accennate in passando, altre si ricavano facilmente da’ princicipi proposti, altre si toccheranno nel seguito di quest’opera. Basti per ora il sapere che dal complesso di tali regole nasce una differenza essenziale tra il melodramma, e gli altri componimenti teatrali assai diversa da quelle, che sono state assegnate finora dagli autori. Non consiste, siccome vogliono alcuni, nel numero degli atti, poiché può darsi un’opera bellissima divisa in cinque atti, come in tre o in due. Non nel carattere del protagonista, poiché non si vede qual diversità essenziale passi tra esso e quello della tragedia e della commedia, né come gli affetti, che svegliar mi debbe il primo, si differenzino dagli affetti che svegliar mi debbe il secondo. né tampoco nella scelta degli argomenti favolosi a preferenza dei veri, poiché, come abbiamo veduto di sopra, gli argomenti tratti dalla storia s’addattano egualmente bene, anzi meglio che i favolosi alla natura dell’opera. Non finalmente nell’esito tristo o lieto della favola, potendosi tanto nell’uno quanto nell’altro caso accoppiare una eccellente poesia ad una musica bellissima. Parlasi qui dell’opera seria non della buffa, nella quale vuolsi, come nella commedia, giocondo fine. né veggo perché il Catone in Utica sarebbe men pregievole se il protagonista s’uccidesse in presenza degli spettatori di quello che sia facendo altrimenti. Le ragioni che s’arrecano da alcuni, sono di poca o niuna conseguenza, oppure, s’hanno un qualche valore, l’avrebbero nella tragedia egualmente, dove però si vede praticato con evento felice dai più gran poeti l’uso di far morire i personaggi in teatro. Può addursi all’incontro l’esempio costante dello e del , i quali hanno terminato tutti i loro drammi con lieto fine. Ma siffatta usanza ebbe origine da tutt’altro che dalle leggi fondamentali del componimento. L’Imperatore Carlo VI cui l’Italia è debitrice in gran parte della sua gloria drammatica, era uno di que’ Signori a’ quali non aggradavano gli spettacoli sanguinari, non volendo che il popolo tornasse a casa scontento dal teatro10. Quindi il suo gusto particolare divenne una legge prima per lo , indi per , e ultimamente per , tutti poeti della corte. Supponghiamo che Carlo VI avesse avuto genio contrario, que’ poeti per secondarlo avrebbero fatto andare tutti i loro componimenti a tristo fine, e dall’esempio loro si sarebbe cavata una regola inviolabile pei suoi successori. I critici avrebbono allora cicalato altrettanto per provar che l’esito infelice era essenziale all’opera, quanto fanno ora per provare l’opposto. Così avverrà sempre che la critica anderà scompagnata dalla filosofia.
[43] Il lettore avrà riflettuto che in questo ragionamento si è parlato dell’unione della poesia, musica, e prospettiva, atteso lo stato in cui si trovano attualmente presso di noi queste facoltà, senza pretendere d’applicar le stesse osservazioni a qualunque unione possibile. Il diverso genio della musica, della lingua, e della poesia in una nazione, le costumanze, e i fini politici possono indurre cangiamenti tali che gli spettacoli abbisognino d’altre leggi e d’altra poetica. Quindi è che poco fondata mi è sembrata mai sempre la rassomiglianza, che alcuni hanno preteso di ritrovare fra il nostro sistema drammatico-lirico, e quello degli antichi.
Capitolo secondo §
Ricerche sull’attitudine della lingua italiana per la musica dedotte dalla sua formazione, e dal suo meccanismo. Cause politiche che hanno contribuito a renderla tale.
[1] Lascio da banda il quistionare intorno all’origine naturale delle lingue, ricerca importantissima nella storia dello spirito umano, ma come tutte le altre della metafisica, coperta di nebbia foltissima, ove la religione non ci aiuti a diradarla. Lascio le liti intorno all’origine particolare del linguaggio italiano, se si parlasse originariamente dal volgo a’ tempi de’ Latini, o se tutto debbasi al corrompimento della romana favella dopo le invasioni de’ barbari. Lascio finalmente agli altri le liti circa l’introduzione della rima nella poesia moderna, quantunque molte cose potrebbono forse in mezzo recarsi contro alle opinioni più ricevute degli eruditi, e mi restringo ad esaminare soltanto i vantaggi che ha la lingua italiana per la musica: circostanza che più d’ogni altra cosa ha contribuito all’incremento di essa, ai progressi della poesia drammatica, e allo splendore di codesto leggiadrissimo ramo della italiana letteratura. Il che tanto più volentieri eseguirò quanto più opportuna comprendo essere siffatta investigazione alla facile intelligenza di quanto dovrò in appresso narrare, e più scarsamente del bisogno veggo trattarsi dagli scrittori italiani un sì ampio e sì interessante argomento. Ma tale è la disgrazia di quelle facoltà, che chiamansi di genio, e particolarmente di questa. I professori, che hanno tutta l’anima nelle dita, stimano che altre cognizioni non vi siano d’apprendere nell’arte loro fuor di quella di prestar il cembalo, e di seguitare l’usanza. I filosofi paghi di signoreggiare fra le altissime teorie del mondo delle astrazioni appena si degnano di scendere all’esame di alcune quistioni, dallo scioglimento delle quali risulta la perfezione delle arti di gusto: come se l’innocente e sicuro diletto che può ritrarsi da esse, sia un troppo picciolo frutto per l’uomo, la di cui vita è sì breve, e i piaceri sì scarsi, ocome se fosse un miglior uso de’ propri talenti, l’applicarli all’investigazione di certi oggetti, i quali la natura ha bastevolmente mostrato di non voler che si cerchino, o togliendoci affatto la possibilità di conoscerli, o rendendoci inutile la cognizione di essi dopo che si sono saputi.
[2] Affinchè proceda con precisione il discorso d’uopo è scomporre la quistione ne’ suoi primi elementi, e risalire fino alla sorgente, esponendo onde tragga origine la maggior o minore attitudine delle lingue pel canto. La voce considerata in se stessa non è altro che l’aria sospinta in su dai polmoni, la quale introducendosi per canale, che si chiama trachea, indi assottigliandosi per la fessura della glottide, e nella cavità della bocca ripercuotendosi, esce poi dalle labbra formando un romore, o suono inarticolato. La parola non è che il suono medesimo quando nel sortir dalla bocca riceve due modificazioni di genere diverso, che articolato lo rendono. La prima modificazione è quella che forma le lettere vocali, e consiste nella maggiore o minore apertura della bocca nel proferir certi suoni, rimanendo le labbra, la lingua, e i denti in una situazione fissa e permanente senza toccarsi insieme: dalla qual permanenza ne siegue, che il riposo della voce ne’ detti suoni non meno die gli alzamenti, e gli abbassamenti di essa, possono essere più o meno durevoli, secondo che più o meno dura l’espirazione dell’aria, che esce dai polmoni. Attalchè tutte le regole che si danno per li accenti e per l’intonazioni appartengono principalmente alle vocali, anzi non cadono che sopra queste. L’altra modificazione, che forma le lettere consonanti, si fa, qualora passando gli organi della bocca dalla loro posizione fissa ad un’altra momentaneamente variata agiscono l’uno sopra l’altro con qualche movimento, battendo la lingua ne’ denti, o nelle labbra, o questi scambievolmente contro a quella. Le consonanti adunque non si pronunziano se non coll’aiuto delle vocali, laddove le vocali si proferiscono senza l’aiuto delle consonanti, ma accoppiate con esse servono a distinguere più esattamente le sillabe dalle parole, e dall’accoppiamento, ed ordine loro si forma poi la sintassi, e il discorso. I vari climi, diversificando le passioni, e i bisogni, e conseguentemente la maniera di significar le une e gli altri, rinserrando o sciogliendo gli organi destinati alla voce, e modificandoli a misura del caldo o del freddo, influiscono prodigiosamente sulla formazione delle lingue. Quindi la varietà, e l’indole di esse misurata, a così dire, secondo i gradi di latitudine, o di longitudine geografica. Ma di ciò, come ancora delle cagioni morali, che contribuiscono ad alterar i linguaggi, si farà di proposito più ampiamente discorso in un saggio filosofico sull’origine della espressione poetica, e musicale, che da chi scrive si conserva inedito.
[3] Dal primo semplicissimo riflesso intorno alla formazione delle vocali, e delle consonanti risulta che la lingua più a proposito per il canto sarà quella: primo, che conti maggior numero di vocali, perché facendosi in esse le permanenze della voce, sarà maggiore il numero delle intonazioni, e per conseguenza degli elementi del canto: secondo, che impieghi maggior numero d’inflessioni diverse nel proferirle, perché ogni inflessione diversa nella pronunzia apporta seco un nuovo tratto di espressione nella melodia: terzo, dove la pronunzia di essi suoni sia più decisiva, e marcata, perché ivi avrà più forza l’accento, e più sensibile renderassi il valor musicale delle note: quarto, che non usi nelle parole di troppo rincontro di lettere consonanti senza l’interruzione delle vocali, perché tardandosi troppo nel proferirle, la misura si renderebbe lesta ancor essa, ed imbarazzata, e perché costretto il compositore a escludere molte parole, come disadatte alla espressione, s’impoverirebbe di molto il linguaggio musicale: quinto, dove il passaggio di parola in parola sia più spedito, e corrente, perché ciò contribuisce non meno alla dolcezza della lingua, che all’agevole collocazione delle note.
[4] Ma i suoni della voce sono incommensurabili, vale a dire, non si distinguono fra loro per intervalli perfettamente armonici, né possono misurarsi per alcuna delle note, che entrano nei nostri sistemi di musica. Il canto è quello che li determina, dando loro un valore e una durazione esprimibile per alcuno dei segni musicali. Ma cosa è egli mai questo canto? In che si distingue dalla favella ordinaria? Quali mutazioni diverse da quelle del parlar comune induce negli organi fisici della voce? Io lascio volentieri agli altri questa ricerca, che non è strettamente ligata col mio argomento, e che apprendersi non potrebbe senza troppo apparato scientifico. Mi contenterò d’osservare che in qualunque sentenza a cui ci appigliamo (nè trovasi alcuna, che alla proposta quistione in ogni sua parte risponda) il canto si distingue specificamente dalla voce pei seguenti caratteri. Primo: per un certo ondeggiamento della laringe, ovvero sia della sommità dell’organo destinato alla respirazione, la cui posizione si muta, alzandosi, o abbassandosi ne’ diversi tuoni. Secondo: per le oscillazioni reciproche dei ligamenti della glottide, i quali or s’increspano, or si rallentano a guisa delle corde musicali ne’ diversi toni grave ed acuto. Terzo: per la volontaria dimora della voce nelle rispettive vocali del discorso secondo tali determinati intervalli, che sono quelli che s’esprimono nella musica coi nomi di seconda, terza, quarta, quinta, ecc.
[5] Da tali differenze introdotte dal canto si scorge ancora quali proprietà si richieggano oltre le accennate di sopra in un linguaggio acconcio a tal fine. Non debbe avere pronunzia gutturale nelle vocali, perché nascendo cotal difetto da troppo aspra percussione nell’apertura della glottide, siffatto percuotimento nuoce alla nettezza e leggiadria del suono, il quale non esce assottigliato nella guisa che si richiede. Non dee averla nasale, perché facendosi una risuonanza troppo confusa nella cavità della bocca, e delle narici, il suono s’offusca, e l’accento perde molto della sua chiarezza. Debbe altresì esser priva di sillabe, o vocali mute, sulle quali, non potendo la voce far le sue poggiature a cagione, che non si pronunziano, i passaggi s’intorbidano, e la misura musicale s’imbroglia, perché bisogna notarle quantunque scommettano nel discorso, dalche nasce che le note di rado o non mai vadano d’accordo coll’intonazione, come spesso adiviene nella musica francese. Non ha d’avere dittonghi di suono indeterminato, e confuso, perché non avendo essi un valore determinato nella pronunzia, non possono né meno riceverlo dalle note, le quali non hanno in tal caso che una espressione insignificante. Facili dovranno essere le articolazioni, le sillabe nettamente divise, le parole di lunghezza giusta, che non assorbiscano, a così dire, tutto il fiato al cantante, ma che gli lascino il tempo di proferirle intiere senz’esser costretto ad affrettar di troppo i riposi sulle vocali. Altre qualità dovrebbe avere eziandio, delle quali farò parola in appresso.
[6] Ora se alcuna lingua d’Europa riunisce tutte, o la maggior parte delle doti accennate, essa è l’italiana sicuramente. Per chiarirsene d’altro non abbisognasi che di farne l’applicazione. Il numero delle sue vocali è uguale a quello delle più belle lingue del mondo la greca, e la latina, e sebbene non le adegui nel numero de’ suoni adoperati nel profferirle, tuttavia è assai ricca anche in questi, distinguendo molto bene il suono che corrisponde all’“a” semplice, da quello che corrisponde all’“a” con aspirazione, l’“i” breve dall’“j” disteso, l’“e” e l’“o” aperto, ch’equivalgono all’eta, all’omega de’ Greci dall’“e”, ed “o” chiuso, che rassomigliano all’“e” breve, e all’omicron. né minore si è la varietà di proferire le lettere consonanti, poiché, secondo le osservazioni del 11, da venti soli caratteri che s’annoverano nel toscano alfabeto, si ricavano nella pronunzia più di trentaquattro elementi. Le quali diversità non vengono comunemente notate nella Lombardia, ma sono principalissime presso a’ toscani, come si vede negli autori loro, ed io ho non poche fiate osservato. E maggiore e più copiosa ricchezza in questo genere avrebbe il linguaggio italiano, se i nazionali da cieca venerazione sospinti verso i toscani, quantunque appoggiata su ragionevoli fondamenti, non si fossero lasciati imporre un despotico giogo di tribunale e di lingua, per cui vien tolta ad essi la facoltà di prevalersi di tanti modi leggiadri di profferire, di tanti suoni, ed accenti diversi che s’usano ne’ moltiplici e vari dialetti di questa penisola. né sono molto lontano dal credere, che se di comune consenso della nazione sene facesse una scelta giudiziosa di siffatte maniere, la quale poi avvalorata venisse dall’uso di scrittori egregi e di cantori bravissimi, la musica ne acquisterebbe un pregio maggiore assai di quello che attualmente possegga, udendosi ora l’accento molle de’ sanesi, che appena toccano a mezzo suono le vocali, e rendono alcune consonanti pressoché insensibili massimamente nel fine: ora l’intenso e veloce de’ napoletani, che squartano, a così dire, le sillabe colla loro larga pronunzia, che sarebbe perciò opportunissima a’ canti guerreschi, e vivaci: ora la soavità e la grazia del veneziano per la copia delle vocali, e per la prestezza nel profferirle atto all’espressione della voluttà: ora la chiarezza e sonorità del romano, che alle gravi e seriose melodìe mirabilmente si confarebbe. Il dialetto bolognese (checché ne pensi in contrario , o chiunque sia l’autore dell’antichissimo libro della volgare eloquenza) il genovese, il romagnuolo, il piemontese con pochi altri di niun giovamento sarebbero alla musica pel duro e frequente accozzamento delle consonanti, pei suoni oscuri, offuscati, ed ambigui delle vocali, per la sintassi mal definita, e per altre cause.
[7] La collocazione delle consonanti non può essere più opportuna, non essendoci alcuna sillaba, che ne contenga più di quattro, né trovandosi tre in seguito senza l’aiuto di qualche semivocale, che temperi la rozzezza del suono. E i passaggi da una parola in un’altra fansi con agevolezza grandissima, atteso che tutte le dizioni, siano nomi siano verbi, terminano in vocale, eccettuati alcuni monosillabi, come “sur, in, con”, o quando per accrescer forza al discorso, per ischivar le troppe elisioni, o per terminar più speditamente il periodo, in una cadenza si troncano infine alcune vocali, come “finor, fedel” da “finora fedele”. Siffatte desinenze in vocali, e l’abbondanza di esse, oltracchè spesseggiano le dizioni, moltiplicando le elisioni, rendono la lingua italiana molle e dolcissima sopra ogni credere. Non sò s’altra favella vi sia nella Europa, ove possano farsi otto versi paragonabili nella mollezza a questi del :
«Tentri sdegni, placide, e tranquilleRipulse, cari vezzi, e liete paci,Sorrisi, parolette, e dolci stilleDi pianto, e sospir tronchi, e molli baci:Fuse tai cose tutte, e poscia unille,Ed al fuoco temprò di lente faci,E ne formò quel sì mirabil cintoOnd’ella avea il bel fianco succinto».
[8] Inoltre la giusta misura e proporzione delle parole, che più acconci e le rende a ricever il valor delle note, a fissar con esattezza il tempo, e a seguitar il movimento, unita all’intervallo così proporzionato, che trovasi ne’ versi italiani tra parola e parola, tra sillaba e sillaba, tra vocale e vocale, tra articolazione ed articolazione, e alla felice mescolanza delle medesime fanno sì che la poesia italiana, ove maneggiata venga a dovere, abbia una certa evidenza d’armonia maravigliosa. Chi non sente subito il musicale nell’artifiziaìe combinazione de’ suoni, che compongono la seguente ottava?
«Sommessi accenti, e tacite parole,Rotti singulti, e flebili sospiriDella gente, che in un s’allegra, e duoleFan che per l’aria un mormorio s’aggiri,Qual nelle folte selve udir si suoleS’avvien che tra le frondi il vento spiri,O quale infra gli scogli, o presso ai lidiSibila il mar percosso in rauchi stridi».
[9] Nè dalla delicatezza, che scorgesi in questi e simili esempi si debbe argomentare, come fanno alcuni critici francesi, i quali si compiacciono di giudicare di ciò che mostrano di non intendere, che la lingua italiana sia troppo effemminata e cascante12. Tale sarebbe certamente se gl’Italiani non avessero a ciò provveduto ora col frequente raddoppiamento delle medesime consonanti, come “alloppiare, oggetto”, il quale, oltre il sostenere che fa la pronunzia, serve a dividere più esattamente i tempi nella musicale misura: ora battendo fortemente su alcune consonanti “b, ff, r” come “arruffa, vibrato”, sulle quali, principalmente sulla prima, i toscani formano un suono, ch’io assomiglierei volontieri al romore, che fanno le penne degli augelli nel tempo, che spiccano il volo: ora colle frequenti elisioni, che spesseggiano il rincontro delle consonanti, dando alle parole una certa asprezza e gravità, ora colla inversione della sintassi i della quale parleremo tra poco. Si paragoni colle precedenti questa ottava parimenti del :
«Chiama gli abitator dell’ombre eterneIl rauco suon della tartarea tromba,Treman le spaziose atre caverne,E l’aer cieco a quel romor rimbombaNè sì stridendo mai dalle superneRegioni del cielo il folgor piomba,Nè sì scossa giammai trema la terraQuando i vapori in sen gravida serra.»
[10] Si leggano inoltre alcuni pezzi scelti di e d’ come sono la morte d’Ugolino, e le prodezze di Rodomonte in Parigi, indi si giudichi se la lingua italiana ad altro non è buona che ad esprimere l’effemminatezza.
[11] Sebbene non ogni evidenza di stile, non ogni numero che alla
poesia si confà, sarebbe a proposito per la musica, come alcuni affermano
innavertentemente. L’armonia poetica e l’armonia musicale, quantunque convengano in
alcune circostanze generiche, hanno però delle differenze, alle quali bisogna far
avvertenza per non confonderle. Tanto l’una quanto l’altra consistono nella convenienza
delle parole e de’ suoni colla natura dell’oggetto, che esprimono: l’una e l’altra
dipende dalla prosodia della lingua non meno che dalla cadenza ritmica del periodo, e da
quella dimensione artifiziale, che cerca gli intervalli e i riposi. Ma nell’armonia
puramente poetica cercasi sopra tutto la forza de’ vocaboli, e l’eleganza del
fraseggiare: voglionsi parole scielte, grazie di lingua, torni d’espressione inusitati,
versi talora rotondi talora spezzati colla scelta di voci più ruvide, le quali composte
di maggior numero di consonanti elidano il suono troppo vivace e sonoro delle vocali,
rendendo così la poesia più sostenuta e robusta. Ne’ versi fatti per musica cercasi non
tsnto la forza determini quanto la relazione che hanno essi col canto: per lo che
voglionsi parole composte di vocali chiare ed aperte, vuolsi un tal collocamento
d’accenti, che affretti o rallenti in proporzione il movimento senza che abbia a
inceppare in articolazioni troppo difficili, o in suoni confusi, dal che ne risulti
sintassi più facile, e, a così dir, più scorrevole, che metta ne’ suoni una opportuna
distanza tra il piano, e il forte, e tra le variazioni, e le pause della voce. Le lingue
e le poesie più perfette sono quelle che sanno combinar meglio insieme codeste due
spezie d’armonia: onde un giudizio sicuro può ritrarsi eziandio circa lo stil de’ poeti,
e il vario loro carattere. Ed è siffatto carattere musicale, che distingue i versi di
da quelli di , e di , che fa comparir
sì gentile il dirimpetto al fiero e
rugginoso , che rende superiore a , e
, e che mette al di sopra di , e d’, i quali, e
principalmente l’ultimo, benché ricchi siano di poetico stile, benché forniti d’altre
qualità eccellenti, non sono in questa parte paragonabili all’autore della
Gerusalemme. Il vivace e pittoresco Signor Abate gran difensore del poeta ferrarese13 dimanda
perché invece del «Chiama gli abitator dell’ombre eterne»
del non recansi in mezzo a provare la robusta asprezza
della lingua italiana tante altre stanze dell’Ariosto ricche d’evidenza e di suono al
paro di quella. Io rispondo che la espressione che scorgesi nei versi del ferrarese, è
piuttosto poetica che musicale, che non percuote soltanto l’orecchio ma la pronunzia, e
che l’accozzamento de’ suoni fra le vocali e le consonanti, di cui fa egli uso
comunemente, è atta bensì a grandeggiare nell’epica declamazione, ma meno acconcia si
rende pel canto. Mettasi sotto le note il primo verso di quella stanza, che fra le altre
s’adduce in prova dal .
«D’alte querele, d’ululi, e di strida.»
[12] Qual vaghezza troverà il cantore arrivando al muggito sordo di quello sdrucciolo “ululi”? Quai riposi, o quai gorgheggi netti e chiari di voce nel cupo suono di quelle “uuu” replicate? Qual passaggio spedito e facile nell’unione non temperata di tre consonanti in “strida”? All’incontro la ruvidezza di quella del Tasso vien raddolcita dal concorso di vocali piene e sonanti, la disposizione dell’“a”, e dell’“o” oltre l’esprimer che fa mirabilmente la vacuità, e il silenzio delle caverne infernali, mitiga la pronunzia delle “rr”, e delle “tt” a bella posta replicate affine di rappresentare il suono grandioso di quella tromba: il chiaroscuro de’ colori vedesi a maraviglia osservato, onde ne risulta un tutto, che riunisce il colorito alla evidensa, e l’espressione poefica alla musicale armonia.
[13] Alla dolcezza, ed al collocamento delle parole succede nell’esame delle qualità proprie pel canto la maniera di misurarle, ovvero sia la prosodia. Ma siccome a sviluppar bene questo punto d’uopo sarebbe inoltrarmi in ricerche troppo scientifiche, e per conseguenza troppo moleste alla maggior parte de’ miei lettori intorno alla natura de’ tempi, e degli accenti; così stimo miglior consiglio il rimandar coloro che vorranno sapere più oltre, ai musici di professione, e ai matematici14. Basti per ora il sapere, che sebbene la prosodia italiana sia di gran lunga inferiore alla latina e alla greca, nelle quali la velocità, o lentezza de’ tempi impiegati nel proferire qualunque parola venivano determinate dal valore, e dalla quantità delle sillabe che formavano la parola stessa, laddove nella favella italiana i tempi del poetico ritmo non possono esattamente determinarsi a cagione, che la maggior parte delle sillabe non ha quantità fissa, e sensibile; nondimeno cotal difetto è minore in lei che nelle altre lingue viventi. Imperocché ha ella una variazione d’accento che la rende molto a proposito per la formazione de’ piedi: può, per esempio, in una parola di cinque sillabe, mettendo l’accento sulla seconda, far brievi le tre che le rimangono, come in “determinano”: può fare lo stesso in una parola di quattro sillabe, come in “spaventano”: abbonda moltissimo di piedi dattili come “florido, lucido”, piedi che molto giovano all’armonia a motivo dell’ultima, e penultima breve precedute danna sillaba lunga, circostanza, che più agevole rende la musicale misura: adatta l’accento ora sulla penultima, come in “bravura, sentenza”, ora sull’ultima, come in “morì, bontà, virtù”, dal che vario e differente suono risulta sì nelle rime che nei periodi, e più facile diviene la poggiatura nella cadenza. Misura altresì molte parole alla foggia de’ Greci, e de’ Latini, o almeno la pronunzia di esse è tale che facilmente potrebbero misurarsi, ond’è che può formare dei piedi il trocheo, come “venne fronde”, il giambo come “farò virtù”, l’anapesto, come “gradirò”, lo spondeo, come “sogno”, e il dattilo, come “timido”, dal vario accopiamento de’ quali può conseguentemente imitare dei versi l’esametro, il pentametro, l’asclepiadeo, il saffico, l’idonico, il faleucio, l’anapesto e il giambo15.
[14] Da ciò ne siegue che la melodia della lingua e del canto italiano è la più viva e sensibile di quante si conoscano, perocché traendo questa nobilisima parte della musica da sua origine, e la sua forza dalla imitazione trasferita al canto delle diverse successive inflessioni, che fa l’uomo nella voce ordinaria, allorché è agitato da qualche gran passione, ed essendo esse inflessioni tanto più variate, e moltiplici quanto maggiore è la varietà degli accenti nella sua pronunzia; egli è per conseguenza chiarissimo, che più espressiva sarà la melodia a misura, che la lingua sarà più abbondevole e varia in questo genere, perché l’imitazione della natura diverrà più perfetta. Che se alcun m’opponesse che i vantaggi di sopra indicati nella lingua italiana appartengono all’accento prosodiaco e non all’accento naturale, o per dir meglio, patetico, assai diverso da quello, e che in questo è riposto il principio ascoso della melodia, io rispondo che l’accento prosodiaco il naturale necessariamente conseguita, poiché le regole della pronunzia nel proferire le sillabe non si sono altronde ricavate, che dalla continua osservazione di ciò che succede in natura, e dai diversi alzamenti, o abbassamenti di voce, dalla diversa rapidità, o lentezza, con cui nell’uomo le passioni si esprimono: e l’asserire che tali regole niente hanno di comune coll’accento naturale, o patetico, sarebbe ugualmente assurdo, e ridicolo, che il dire che la musica strumentale ha fondamenti contrari o diversi della vocale. Ogni lingua dunque, la quale sarà doviziosa di accenti, sarà ricca parimenti d’espressione, e di melodia, come all’opposto, chi ne scarseggia avrà una melodia languida, fredda, e monotona. La francese si trova forse nel secondo caso, e l’italiana nel primo.
[15] Dal medesimo fonte deriva la bellezza musicale e poetica del recitativo italiano, poiché le moltiplici e variate poggiature della voce cagionate dagli accenti, siccome avvicinano il discorso ordinario alla natura del canto per la maggior facilità d’intuonazione, così accostano vieppiù il recitativo alla declamazion naturale, nel che la sua bellezza è a giudizio degli intendenti principalmente riposta. Il qual vantaggio non può avere la lingua francese, dove tutte le parole si pronunziano coll’accento sull’ultima sillaba; ond’è che i cantanti per rendere men monotono il recitativo loro, e più gradevole all’orecchio, si veggono costretti a discostarlo dal naturale, caricandolo di falsi ornamenti. Al che s’aggiugne eziandio l’indole de’ loro versi, i quali, essendo dappertutto rimati, e dovendo la musica fare su ogni rima una qualche pausa, l’andamento del recitativo divien tardo, noioso, e difficile. Al contrario nella poesia musicale italiana l’accento può liberamente per quasi ogni sillaba scorrere, e la natura del verso sciolto permette al poeta di far la cesura dove più gli torna: conseguentemente il periodo può secondo il bisogno slungarsi, o accorciarsi, e può dal compositore rapidità or maggiore, or minore ricevere. La lingua italiana ha dunque un discorso che facilmente divien poesia, ha poesia che s’avvicina alla natura del canto, ha finalmente il recitativo, che dalla declamazione poetica non molto si scosta: del che somministra una pruova il vedere, che i drammi dello , e del sono ugualmente acconci per recitarsi che per cantarsi. Il Signor pretende che siffatta indifferenza per la recita e per il canto sia un difetto nell’opera italiana16. Io lontano dall’acconsentire al suo parere porto anzi opinione che ciò sia un pregio grandissimo, e maggiore ancor lo sarebbe se la declamazione poetica potesse nel canto intieramente trasfondersi cosicché la poesia fosse dalla musica inseparabile, come avvenne alla lingua greca nel suo principio. L’illustre Geometra ha dovuto poco dopo convenir egli stesso, poiché tra i mezzi, che da gran maestro addita per migliorar il recitativo francese, il principale, sù cui si ferma, è quello d’italianizzarlo l’italianiser, avvicinandola alla declamazione17.
[16] Un altro vantaggio della lingua italiana per l’oratoria, la musica e la poesia è la trasposizione, cioè quando il collocamento delle parole si fa non secondo l’ordine naturale delle idee, ma come più torna a proposito per la bellezza del periodo, e per il piacere dell’orecchio. A conoscere quanta grazia aggiunga allo stile la sola inversione, quando si fa secondo i movimenti dell’armonia, basta osservare i periodi di , l’inesprimibile bellezza de’ quali diverrà un suono rozzo e insignificante, un cadavero senz’anima soltantochè si cangino dall’ordine loro le parole, mettendo sul principio quelle, che sono al fine, ovvero sul fine quelle, ch’erano in principio. né avviene altrimenti nella lingua italiana. Prendete per esempio i due primi versi dell’ così poeti ci:
«Le Donne, i Cavalier, l’armi, gli amoriLe cortesie, l’audaci imprese, io canto.»
ognun vede quanto accresca loro d’armonia quell’“io canto” messo infine. Si pongano le parole secondo l’ordine analitico
«Io canto i Cavalier, l’armi, gli amoriLe cortesie, le Donne, e imprese audaci.»
chi vi ravvisa più il pennello dell’immortal ferrarese? Non è per questo ch’io approvi l’inversione troppo intrelciata di alcuni cinquecentisti specialmente quando è affettata, e lunga, come adiviene fra gli altri nello , nel , e nel , i quali ti fanno sfiatare i polmoni prima che arrivi a terminar un periodo: né che non preferisca sì in verso che in prosa uno stile conciso, e pieno di cose all’abbindolato e pieno di parole massimamente nel genere filosofico, di cui la precisione, la chiarezza, e la disinvoltura sono i principali ornamenti. Ma dico bensì che la lingua che avrà il vantaggio della trasposizione farà in uguali circostanze progressi più sensibili nelle belle arti ora per la facilità maggiore d’accomodar le parole al sentimento, onde nasce l’evidenza dello stile: ora per la maggior attitudine a dipignere cagionata dal diverso giro, che può darsi alla frase, e dalla varietà, che da esso ne risulta, onde si sfugge la monotonia, e il troppo regolare andamento; ora schivando la cacofonia nel rincontro sgradevole delle vocali, o l’asprezza in quello delle consonanti inevitabili spesse fiate nelle lingue, che hanno sintassi sempre uniforme: ora questo medesimo accozzamento a bello studio cercando, come lo richiede la sostenutezza e gravità dell’oggetto: ora facendo opportuna scelta di quei suoni, che più alla mimetica armonia convengono: ora per la sospensione, che fa nascer nello spirito lo sviluppo successivo d’un pensiero, di cui non si sa il risultato sino alla fine del periodo. Nel che è da osservarsi che le lingue, le quali per conservar rigorosamente l’ordine analitico delle parole non sanno preparar cotal sospensione, mettono in certo modo la poesia in contradizion coll’orecchio, poiché mentre il sentimento dei versi è completo, quello della musica, che va poco a poco spiegandosi, non finisce se non colla cadenza.
[17] Se fosse mio avviso il diffondermi su questa materia, molto
ancora rimarrebbe adirsi intorno agli altri pregi dell’italiana favella, della evidenza
delle sue frasi imitative, delle quali si trovano esempi maravigliosi negl’autori,
della ricchezza determini cagionata dal gran numero di dialetti, che sono concorsi a
formarla, della sua varietà nata appunto dalla ricchezza e moltiplicità delle sue forme,
dell’abbondanza d’augmentativi e di diminutivi, che la rendono opportuna quelli per lo
stile ditirambico, questi per l’anacreontico, e della pieghevolezza che in lei nasce dal
concorso di queste e d’altre cause. Potrebbe ancora farsi vedere in qual guisa sappia
essa congiungere l’ordine colla vivacità e colla chiarezza la forza, imbrigliare
l’immaginazione senza rallentarne la possa, accomodarsi a tutte le inflessioni, e a tuti
gli stili, conservando, ciò nonostante, l’indole sua propria, e nativa: quanto vaglia a
esprimer tutte le passioni, e a dipinger tutti gli oggetti, e come divenghi lo strumento
egualmente dallo spirito della fantasia, e degli affetti. Ma assai si è detto onde si
conoscano le sue prerogative per la musica, e l’ingiustizia altresì con cui parlano di
essa alcuni scrittori francesi, tra quali il gesuita colla leggerezza sua solita nel giudicare non ebbe difficoltà di
dire: «Che è una lingua affatto giochevole, che altro non intende che di far
ridere coi suoi diminutivi»
, e notisi, che molti di quelli ch’ei nomina non si
trovano frale parole toscane: «Che le continue terminazioni in vocale fanno una
musica molto sgradevole»
, quando le principali bellezze della musica italiana
nascono appunto da queste: «Che la lingua italiana non può esprimere la natura, e
ch’essa non può dare alle cose l’aria, e vaghezza lor propria, e convenevole: Che le
metafore continue, e le allegorie sono le delizie degl’Italiani, e degli Spagnuoli
ancora: Che le loro lingue portano sempre le cose a qualche estremo: Che la maggior
parte delle parole italiane, e spagnuole è piena d’oscurità, di confusione, e di
gonfiezza»
, come se la gonfiezza, e l’oscurità fossero un vizio delle parole,
e non degli autori: «Che i Chinesi e quasi tutti i popoli dell’Asia cantano, i
tedeschi ragliano, gli Spagnuoli declamano, gli Inglesi fischiano, gli Italiani
sospirano, né ci ha propriamente che i Francesi, i quali parlino»
. Dopo i
quali spropositi non ci dobbiamo punto maravigliare dello spiritoso, e leggiadro
giudizio, che dà intorno alle tre lingue sorelle: «Cioè che la lingua spagnuola è
una superba di genio altiero, che vuol comparir grande, ama il fasto e l’eccesso in
ogni cosa, l’italiana è una fraschetta, e una vanerella sempre carica d’ornamenti e di
belletto, che altro non cerca che piacere ad altrui, e che ama molto le bagatelle. La
francese è una matrona ma una matrona avvenente, la quale, benché savia, e modesta,
nulla però ha dell’aspro né del fiero»
18. Chi così parla
intendeva egli la lingua italiana né la spagnuola? Oppure si credeva abbastanza
ricompensato dal dispregio, che meritano dagli stranieri le sue decisioni coll’applauso
di qualche scioperato parigino19?
[18] Che se alcun volesse filosofando ricercare onde abbiasi la lingua italiana acquistata quella dolcezza, che sì abile al canto la rende, e da quai fonti siano derivati i successivi cangiamenti ad essa avvenuti dai Romani in quà, potrà egli a mio giudizio rinvenirli nelle cagioni seguenti. La prima, che non essendo stata l’Italia né tutta intiera, né lungo tratto di tempo soggiogata dai barbari, la favella italiana ha potuto conservar i suoi primitivi caratteri meglio delle altre nazioni, dove la lingua, e i costumi non men che la religione, e le leggi hanno dovuto piegare sotto il furore delle conquiste, come si vede nella lingua francese, la quale altro non è, se crediamo a’ loro autori più illustri, che un antico dialetto celtico diversamente alterato, e nella spagnuola tutta impastata di latino, e di gotico idioma, cui s’aggiunse dell’arabo non piccola parte. Ora l’origine del moderno italiano non dee tutta ripetersi dal latino parlare o dal settentrionale, ma dai rottami ancora della lingua italica primitiva anteriore alla latina, e che formavasi dai dialetti etrusco, indigene, osco, greco, sabino, e tant’altri usati dai rispettivi popoli che abitavano questi paesi. Di ciò appaiono manifesti vestigi in molti vocaboli secondo le dotte e riflessive osservazioni di , e del assai cognite agli eruditi. Cotal lingua confusa poi colla latina, e notabilmente alterata in seguito da gotiche, e longobardiche mischianze ha conservato nondimeno nella volgare favella l’originaria dolcezza di suono in gran parte orientale, onde molti di essi popoli traevano principio, per quella ragione avverata in tutti i secoli e da tutte le genti, che l’accento naturale è più durevole delle leggi e dei governi. Quindi il pregio di soavità e di mollezza sopra gli altri popoli dato al canto italiano da fin dal secolo ottavo dell’era cristiana, e quindi parimenti l’accusa d’effemminatezza intentata contro ai cantori italiani da , che fioriva verso il 1170.
[19] La seconda, della immaginazione pronta e vivace, che tanto influisce sul naturale degli Italiani, la quale fra le molte modificazioni degli organi destinati all’esercizio della parola trova subito quelle, che alla maniera loro di concepire maggiormente si confanno. Avvegnaché il linguaggio delle passioni sia, generalmente parlando, lo stesso in tutti gli uomini, e che la natura si spieghi con certi segni comuni ad ogni nazione, egli è nondimeno certissimo, che la differenza de’ climi e de’ temperamenti, il maggior o minor grado di sensibilità e d’immaginazione siccome contribuiscono assaissimo alla formazion delle lingue, così ancora mettono gran divario nella maniera di esprimer gli affetti non meno tra popolo e popolo che tra individuo ed individuo. Bisogna scorticar un moscovita per far ch’ei senta, dice con molto spirito il . Lo svizzero nella collera grida egualmente e fortemente, mantenendo a un dipresso la voce nello stesso tuono. Non è così nell’italiano, cui somministrate venendo dalla pronta fantasia cento cose alla volta, percorre in fretta tutti i tuoni, e modifica in mille guise l’accento naturale. Perlochè è mirabile la vivacità, e l’evidenza, che osservasi non solo nella collera, ma anche nel discorso familiare, ovvero nella narrazione d’un fatto, per cui pigli qualche interesse. Allora il sembiante dell’italiano prende anima e vita: gli occhi, le mani, il portamento, tutto diviene eloquente: il suo linguaggio sentesi pieno d’interiezioni, d’esclamazioni, di suoni spiccati e sensibili: l’idioma degli accenti rinvigorisce quello delle parole, ed ecco il gran fonte onde scaturisce il modello, che il musico dee per ogni verso cercar d’imitare, e al quale la melodia è debitrice della sua possanza.
[20] Un’altra ragione potrebbe addursi per ultimo, ed è che essendosi vedute di buon ora in Italia signorie grandi, e possenti, come quella di Genova, Pisa, Firenze, Vinegia, Roma, Milano e Napoli, dove la magnificenza, il lusso, le arti, e il commercio contribuivano non meno ad ingentilir l’ozio che a fomentarlo, la tendenza al piacere, che da tai radici germoglia, e della quale la storia italiana ci somministra esempi sorprendenti, s’introdusse per entro a tutte le facoltà del gusto, che hanno per immediato strumento la parola. Le donne inoltre, dalle quali ogni civile socievolezza dipende, avendo per cagioni che non sono di questo luogo acquistata una influenza su i moderni costumi che mai non ebbero appresso gli antichi, giovarono al medesimo fine eziandio ora per l’agio, e morbidezza di vivere, che ispira il loro commercio, onde s’addolcì la guerresca ferocia di que’ secoli barbari: ora per l’innato piacere che le trasporta verso gli oggetti che parlano alla immaginazione ed al cuore: ora per lo studio di molte posto nelle belle lettere, e nelle arti più gentili, dal che nacque il desiderio d’imitarle ne’ letterati avidi di procacciarsi con questo mezzo la loro grazia, o la loro protezione, massimamente nel Cinquecento, secolo illustre quanto fosse altro mai per le donne italiane: ora per le fiamme che svegliano esse nei petti degli uomini, onde questi rivolgonsi poi a cantare la bellezza, e gli amori, piegando alla soavità lo stile, e la poesia. Così fecero , e , prime sorgenti della mollezza della loro lingua come fu il primo ad aggiugner la robustezza purgando la dizione dai Gotici e Latini avanzi che vi rimanevano nelle ruvide desinenze, nella sintassi poco ben istabilita, nelle articolazioni disagevoli, ne’ passaggi troppo confusi, e in altre cose. Lo che essi non avrebbero mai eseguito se il desiderio di celebrar la sua Laura nel primo, e di far leggere il suo Decamerone dalle femminette nel secondo, non avesse lor fatto nascere il pensiero di divenire scrittori.
[21] Se non che siffatto donnesco ascendente, come giova a far germogliar il gusto, e perfezionarlo, così serve non poche fiate a corromperlo. Ciò allora adiviene quando i licenziosi costumi d’un secolo, rallentando tutte le molle del vigore negli uomini, ripongono in mano alle donne quel freno che la natura avea ad esse negato: quando una gioventù frivola e degradata sagrifica alle insidiose tiranne della loro libertà insiem col tempo che perde anche i talenti, di cui ne abusa: quando gli autori veggonsi costretti a mendicar la loro approvazione se vogliono farsi applaudire da un pubblico ignorante o avvilito: quando i capricci della moda, della quale seggono esse giudici inappellabili, mescolandosi nelle regole del bello, fanno perder il gusto delle cose semplici, perché non si cercano se non le stravaganti: quando ci è d’uopo impicciolire gli oggetti e le idee per proporzionarle agli sguardi delle saccenti che regolano imperiosamente i giudizi e la critica di tanti uomini più femmine di loro: quando bisogna per non recar dispiacere ad esse, travisar in ricciutelli parigini i sublimi allievi di Licurgo, o impiegar il pennello grandioso d’un Michelagnolo a dipignere i voluttuosi atteggiamenti di qualche Taide: in una parola quando i geni fatti per illustrar il suo secolo e per sovrastarlo sono malgrado loro sforzati a preferire lo stile d’un giorno, che nasce e muore, come gli insetti efimeri, alle bellezze maschie e vigorose altrettanto durevoli quanto la natura, ch’esprimono. Tali furono a un dipresso le ascose cagioni, che fecero degenerare la poesia e la lingua dopo i secoli d’Alessandro e d’Augusto, e che corruppero ogni bella letteratura in Italia dopo il Cinquecento. Felici le arti e le lettere se di tal rimprovero potessero incolparsi soltanto i passati secoli, senza che nulla avessimo a rammaricarci pel nostro!
Capitolo terzo §
Perdita della musica antica. Origine della musica sacra in Italia. Pretese scoperte di , e di . Rappresentazioni de’ secoli barbari. Paralello fra esse, e quelle dei Greci. Progressi, e cangiamenti del Contrappunto.
[1] La universale ignoranza che oppresse l’Italia dopo la venuta de’ barbari, comechè danni gravissimi recasse a tutte le arti e le scienze, di niuna fece peggior governo che della musica. Le cagioni di cotal singolarità sono assai chiare. Avanti che la religione cristiana succedesse per divino consiglio agli errori del gentilesimo, il fior della musica antica si ritrovava o negli inni, che cantavansi a’ falsi numi ne’ loro templi, o nelle drammatiche rappresentazioni, che si facevano nei teatri. Ora in niuno di cotai luoghi potea impararsi dai primi cristiani la musica, perché l’uno, e l’altro erano a loro religiosamente vietati, siccome domicili di gentilesca superstizione, e di disonestà. De’ templi non vi può esser alcun dubbio circa la superstizione, e nemmeno lo sarà dei teatri per chiunque versato nella lettura degli antichi sappia ch’essi erano altrettante scuole, ove correva il popolo per imparare la loro religione, e la loro morale. Erano altresì l’albergo della dissolutezza, poiché vi si rappresentavano le arti pantomimiche, delle quali son troppo note le oscenità e le laidezze, e noto è l’infame letto su cui obbligavansi non poche fiate le donne a comparir ignude agli occhi del pubblico , e nota è parimenti la esecrabile costumanza di privar della virilità loro i fanciulli, acciò più agili, e più snelli divenissero ne’ pantomimici atteggiamenti. né potevano allora i cristiani una musica a lor modo inventare, perché essendo dai gentili ferocemente perseguitati, vedeansi astretti, se volevano celebrar gli uffizi divini, a ragunarsi nei sotterranei delle case, o nelle caverne, od in luoghi ermi, e selvaggi, dove usavano di canto sommesso, e timido senza strepito di strumenti, i quali il disagio loro, e la povertà mal comportavano, e che avrebbero col romore il solitario loro ritiro agevolmente scoperto. Attalchè, quando i cristiani divennero padroni de’ paesi dianzi posseduti dai gentili, si trovarono quasi affatto sprovveduti di musica, qualora non vogliamo con siffatto nome chiamare il canto de’ salmi, che poco differiva dalla pronunzia ordinaria, o quello degli inni, che eseguivasi a due cori da’ Terapeuti, spezie di monaci orientali, che da alcuni eruditi sono stati, non so se con tutta la ragione, confusi coi cristiani del primo secolo.
[2] La venuta delle nazioni settentrionali apportò in seguito totale rovina. Que’ popoli frammischiando i loro rozzi idiomi alla purità del latino discorso, alterando le terminazioni de’ vocaboli, togliendo ai nomi ed ai verbi la propria inflessione, aggiugnendo in sua vece frequenza d’articolazioni aspre, di consonanti ruvide profferite cori voci sorde e confuse, non potevano far ispiccare il canto loro in altra maniera, che rinforzando il suono delle vocali per nasconder alla meglio la durezza e l’abbondanza di esse consonanti. Cotal rinforzamento unito alla più lunga dimora della voce sulle rispettive sillabe, che ne era una conseguenza, fece rallentar tutti i’ tuoni, frapporre più lungo intervallo tra i passaggi non meno di sillaba a sillaba che di suono a suono, e alterar così la durata de’ tempi tanto nella poesia quanto nella musica. Si tolse conseguentemente alle sillabe il loro quantitativo valore, e alla prosodia i suoi piedi: si smarrì ogni idea di poetico ritmo, che aggiugnea cotanta forza alla melodia, e si perdette la misura musicale, che era colla prosodia, e col ritmo strettamente congiunta. Così rovinò il sistema poetico, e musico degli antichi invece del quale nuova poesia successe barbara, e rozza, che tutta la sua vaghezza traeva dal definito numero delle sillabe in ogni verso, e dall’accoppiamento delle desinenze simili da loro chiamate rime, e nuova musica parimenti, la quale fu ben tosto una serie noiosa, e lenta di passaggi spogliati d’ogni dolcezza, senz’altra melodia, che quella che poteva nascere dalla forza, e dalla durazione de’ suoni.
[3] L’Italia per particolar dolcezza
d’accento, e per essere stata la sede principale della musica antica ne’ paesi
dell’Occidente conservò una superiorità dichiarata in questo
genere sugli altri popoli dell’Europa. Infatti nelle lettere di
si legge, che Clodoveo conquistatore delle Gallie, desiderando
d’avere appo se musici pregievoli, i quali «sollazzassero la gloria della
possanza sua»
, come s’esprime l’originale, scrisse a Teodorico re d’Italia acciocché
gli mandasse alcuno di que’ musici ch’erano alla sua orte. Teodorico il compiacque, mandandogli uno de’ più valenti che vi fossero, e
soggiungendo che glielo spediva affinchè «temperasse colle soavi modulazioni i
feroci petti de’ gentili»
. I Latini, avendo perdute per un concorso di
circostanze, delle quali a me non s’appartiene il parlare, molte parti della musica
greca, aveano parimenti perduti molti segni musicali, ovvero siano note, che usavano i
Greci. ampliò il canto fermo, o
vogliamo dire canto ecclesiastico usato nella chiesa fin dai primi secoli: lo che ei
fece raccogliendo gli scarsi ma pregievoli frammenti della musica greca guasta e mal
concia, come era a suoi tempi, e trasferendoli al culto divino nella chiesa di
Milano. Così il canto fermo nella sua prima origine era il
perfetto genere chiamato diatonico degli antichi, il quale, o per la maggior divozion
de’ cristiani, o per la naturale sua semplicità era più atto a commuovere di quello che
sia la sfoggiata pompa della musica presente. Ne faccia testimonianza il pianto, che il
canto ambrogiano espresse dagli occhi di , come narra questi nelle sue confessioni. San Gregorio papa, rigettando molte cantilene parte
venute dai barbari, e parte licenziose che dalla musica effemminata
dell’Oriente s’erano propagate per
l’Italia, creando delle altre più degne, o traendole con
giudiziosa scelta dall’uso delle altre chiese greche e latine, compose e formò
l’antifonario per uso della musica sacra. Aggiunse a questa maggior pompa e magnificenza
San Vitaliano, istituendo un coro di mutici romani, che
italiani furono detti dall’istitutore loro, come fece anche Leone Secondo, e San Damaso
spagnuolo, a cui di molto fu debitrice a’ suoi tempi la musica. Qualche secolo dopo,
cioè a’ tempi di papa Adriano s’eccitò la tanto
celebre lite fra i cantori romani e francesi circa il primato del canto, volendo questi
introdurre in Italia la loro rozza maniera di modulare,
vantandosi quelli all’incontro di essere i soli e veri maestri della musica perché
seguitavano la scuola di San Gregorio, ed onorando i loro rivali
col modesto titolo d’ignoranti, zotici, e somiglianti ai bruti animali. La disputa
divenne sì viva che lo stesso Imperador Carlo
Magno dimorante allora in Roma, comecché poco
s’intendesse di tali affari, ebbe bisogno d’interporre la sua autorità per placargli,
sentenziando poscia a favor de’ Romani contro ai propri sudditi, anzi mettendo questi
sotto l’insegnamento dei primi. Pochi esempi ci somministra la storia di simili
decisioni date da un principe vittorioso nello stesso paese conquistato da lui, né può
attribuirsi la condotta di Carlo in tal
circostanza che a somma venerazione per le cose di Roma, e forse
anche al bisogno che aveva di amicarsi i Romani per assicurar maggiormente in
Italia la sua possanza. L’uso dell’organo introdotto in
Roma assai prima, obbliato per qualche secolo, e poi rinovato
verso la fine del secol nono accrebbe gran lustro alla musica ecclesiastica. L’antico
scrittore che racconta il dissidio tra Francesi e Romani, dice che Adriano Pontefice mandò in Francia
maestri i quali fra le altre cose gli istruissero nell’organare in arte
organandi. Il da tai parole pretende
ricavare che l’organo fosse molto tempo avanti conosciuto in
Italia20, e il Cavalier coll’Abate
strascinato da sì gran nome pronunzia anch’egli la medesima cosa. Mi si permetta scoprir
l’abbaglio di questi critici. “Organari” nello stile degli scrittori del basso secolo
non vuol dire suonar l’organo, né fabbricarlo, né cosa che s’assomigli: significa
inserire alcune terze nel progresso del canto fermo cantato all’unisono in maniera per
esempio che mentre una parte del coro cantava queste quattro note “ut, re, si, ut”,
l’altra parte cantava al medesimo tempo “ut, re, re, ut”21. Altre significazioni di quella
parola tutte diverse dal senso de’ citati autori possono vedersi presso 22.
[4] Per quasi i due secoli susseguenti, tempo, in cui, per valermi
della energica espressione d’un moderno scrittore, l’Europa
«restò come il gran corpo del ciclope privo dell’occhio»
, la musica
giacque nell’estremo avvilimento affidata a musici imperiti, che credevano di seguitar
senza comprenderlo, ed a cantori più
ignoranti ancora, i quali pronunziavano a caso delle parole non intese da loro
senz’altro aiuto che la memoria, né altra regola d’intuonazione che il loro rozzo ed
imbarbarito orecchio. monaco della
Pomposa, che fiorì dopo il mille, è in que’ tempi tenebrosi ciò
che nel mare agli occhi de’ naviganti smarriti è una torre, che veggasi biancheggiar da
lontano. Egli vien creduto comunemente il fondatore e il padre della moderna musica. I
suoi meriti principali sono d’aver migliorata l’arte del cantare, ampliata la
stromentale, gittati i fondamenti del contrappunto, e agevolata la via a imparar presto
la musica troppo per l’addietro spinosa e difficile. In contraccambio di tanti pregi
egli menò una vita infelice calunniato dalla ignoranza, perseguitato dalla invidia e
costretto a fuggirsene altrove da quei monaci stessi ch’egli onorava colte sue virtù ed
istruiva coi suoi rari talenti. Ma il favore del suo secolo e dei posteriori verso di
lui il ricompensò abbastanza delle vessazioni sofferte nel chiostro. La gran fama
acquistatasi, e la scarsezza dei monumenti hanno fatto sì che attribuite gli vengano
tutte le scoperte delle quali s’ignora l’autore, come già fecero gli Egiziani coi loro
Teutes, e col loro Mercurio. Niuno, cred’io, pretenderà che mi trattenga a
tutte narrarle minutamente, potendosi ciò ampiamente vedere in altri autori che ne
parlano più di proposito; aggiugnerò bensì, che gran parte di esse scoperte non hanno
altro fondamento se non quello appunto della comun tradizione. Si dice, per esempio, che
fosse il primo a inventar le righe, e a
collocarvi sopra i punti, affinchè colla diversa posizione di questi s’indicassero gli
alzamenti e gli abbassamenti della voce; ma ciò si niega a ragione dal nella Musurgia, poiché oltre il
parlar nel suo Micrologo di essi
punti e righe, come di cose note e non mai inventate da lui, egli è certo che si trovano
csempi dell’uno e dell’altro fin dai secoli nono e decimo,23 Si pretende ch’egli aggiugnendo al diagramma, ovvero sia scala musicale
degli antichi, che costava di quindici corde, la senaria maggiore, abbia accresciuta di
cinque corde di più la scala musicale, ed ampliato per consequenza il sistema. Ma
oltrachè una falsità è il dire che il sistema musicale dei Greci non avesse se non
quindici suoni, essendo chiaro che le pretese aggiunte del monaco italiano altro non
avrebber fatto che restituire il diagramma alla sua antica estensione o piuttosto non
giunsero neppure ad uguagliarlo, come dimostra evidentemente il 24, certo è che siffatta restituzione o
ritrovamento non è di , ma d’un altro autore
anteriore a lui di più secoli, le parole espresse del quale si rapportano
dall’eruditissimo 25. Si
tiene anche per sicuro comunemente ch’ei fosse il primo a ritrovare la gamma, ovvero sia
quella tavola, o scala, sulla quale s’impara a dar il lor nome, e a intuonar con
giustezza i gradi della ottava per le sei note di musica “ut, re, mi, fa, sol, la”
seguitando le diverse combinazioni in cui esse note possono collocarsi: ciò che
s’appella propriamente solfeggiare; ma per testimonianza del medesimo un siffatto metodo era stato di già inventato a’ suoi
tempi26. S’asserisce ch’ei precedesse a tutti nell’uso degli
strumenti musicali chiamati polipettri, quali sono il clavicembalo, la spinetta, il
clavicordio, e più altri di questo genere; ma da nessun monumento si ricava aver egli
fabbricato o inventato altro strumento che è una spezie di monocordo armonico, come egli
stesso ne fa fede nel suo Micrologo27.
[5] Ma chiunque sia stato il ritrovatore, le note a’ tempi di
e dopo lui non servivano ad altro che
a segnar colla posizione loro i gradi, e le differenze della intonazione. Tutt’erano
d’ugual valore in quanto alla durata, né ricevevano a questo riguardo altra diversità
che quella delle sillabe lunghe o brevi del linguaggio a cui s’applicavano. Ma tal
diversità era poco sicura, perché la distinzione delle sillabe in lunghe e brevi erasi
per le cagioni di sopra indicate pressoché smarrita, e molta più nella prosa de’ salmi e
delle antifone priva d’ogni prosodia e d’ogni ritmo. Fu dunque necessario trovar la
maniera di significar non solo la differenza del tono, ma anche la durazione dei tempo
in una nota rispetto all’altra, e ciò si fece colla diversa figura, che si diè ad esse
note, la quale segnava il loro rispettivo valore; dal che ebbero origine la massima, la
lunga, la breve, la semibreve, e la minima. Siffatta invenzione nacque dalla necessità
di dover leggere in lontananza su’libri posti in mezzo al coro delle chiese, onde era
d’uopo il rappresentar all’occhio l’alzamento e l’abbassamento de’ tuoni con segni
marcati e visibili. Se ne crede comunemente l’autore , o , canonico parigino, circa
il 1250, ma ciò è apertamente contrario all’asserzione del medesimo , il quale nel suo libro intitolato Speculum
musica, che si conserva inedito fra i manoscritti della Real
Biblioteca di Parigi, parla delle note e del loro
valore come di cose di già conosciute a’ suoi tempi. A chiunque sia versato nella teoria
musicale è ben noto che il modo suppone il valor delle note, poiché quella parola
riguarda la massima e la lunga. Ora il in una
copia del citato codice veduta da me, ci insegna che «gli antichi dicevano esser
cinque i modi»
, intorno alle quale parole , celebre musico padovano del secolo XIV, il quale fece un
lungo comento al libro del , che si conserva
inedito fra la raccolta di monumenti esistenti nella libreria dei RR. PP. conventuali di
Bologna, soggiugne che siffatta opinione circa il numero dei
modi era comune presso agli antichi, dicendo di averla ritrovata in un’opera di
, autore di cui ci converrà far menzione in
appresso. In altro luogo facendo menzione di Guglielmo
Mascardio cantore di grido a’ suoi tempi, ma le cui opere e le cui opinioni
sono state avvolte insiem con tanti altri depositi delle umane cognizioni nella
irreparabile dimenticanza dei secoli, attribuisce a lui l’usanza di lasciar ne canto
imperfette le brevi. O che dunque il valor delle note sia stato ritrovato dal , o che riconoscasi per inventore Guglielmo Mascardio, o che debbasi, come io fortemente
sospetto, risalir ancora a’ tempi più antichi, certo è che il non ebbe parte in così fatta scoperta. né fu altrimenti, come si
pretende, una sua invenzione la misura musicale, ch’era stata per secoli intieri
trascurata, ma senza la quale non può trovarsi né canto regolare né melodia, siccome
quella che serve a dividere i tempi esattamente, a far valere le intonazioni, a dar un
significato, un ordine a1 tutto, come fa la fintassi grammaticale nel discorso, e che
dal valor delle note principalmente deriva. Egli nella copia altre volte citata discorre
alla lunga dello stato, in cui si trovava a’ suoi tempi questa principalissima parte
della musica. «I moderni», dice, «usano presentemente di misura molto tarda». Lo che è
un indizio manifesto che avanti a lui si conosceva. Non sarebbe inverosimile che
gl’Italiani l’avesser trovata, sì perché non sembra probabile che avesser musica da
tanto tempo senza conoscer quelle cose, che sono indispensabili a ben regolarla, come
perché le invenzioni di a quelle altre
agevolmente conducono. Leggendo con attenzione il Micrologo di quel
monaco, vi si scorgono chiaramente i semi di tante scoperte che si riferiscono
comunemente a’ tempi più tardi.
[6] Ma onde, dimanderà qualcheduno, tanta incertezza nella storia della musica? Perché tal oscurità circa il tempo delle invenzioni, e degli inventori? Si risponde che ciò è provenuto dalla natura dei secoli dediti alla rustichezza e alla ferocia, dove nulla pregiavansi le opere dell’ingegno, perché neppur si sospettava della loro utilità: dal niun commercio tra popoli confinanti, non che tra i lontani, onde avveniva che i nuovi ritrovati nelle scienze e nelle arti, o si smarrivano nei viaggi disastrosi, e poco sicuri, o si chiudevano nella tomba per sempre insiem coi loro inventori, o si giacevano fra l’eterno silenzio delle monastiche biblioteche polverosi e negletti: dal considerarsi in allora la musica non come un’arte di genio, gli avanzamenti della quale dovessero interessare il lusso e la voluttà nazionale, ma come una spezie di liturgico rito, ovvero sia di pattuita ecclesiastica cerimonia, cui bastava aggiugnerne quello soltanto, e non più, che richiedevasi per soddisfar al bisogno: dalla mancanza insomma di scritture, e di libri, la quale vietava di poter ad altri luoghi trasmettere, e di render note le proprie invenzioni. Talmente che nulla v’ha di più comune in quei tempi quanto l’attribuire ad un autore delle scoperte che poi con più diligente ricerca si ritrova esser di molto a lui anteriori. Io paragonerei volentieri la storia dei secoli barbari all’orizzonte. Lo spettatore, che vede da lontano unirsi la terra col cielo, crede che colà siano posti i limiti del mondo, ma a misura ch’egli avanza il passo, l’illusione sparisce, e più non vi si trova il confine.
[7] Che che sia di ciò, quantunque siffatto ritrovato incontrasse qualche contraddizione dalla parte d’alcuni, nullameno i più celebri musici d’Italia , , , con più altri l’abbracciarono avidamente, onde gran incremento ne prese l’arte del contrappunto. Altre varietà s’introdussero prima, e poi, che non a breve saggio come questo è, ma a più lunga storia si convengono. Cominciossi allora ad applicar la musica ai funerali, alle nozze, e ad altre solennità, come ancora a’ Ludi o misteri della Passione, de’ quali, per essere stati in certa guisa i primi abbozzi del dramma musicale, ci convien fare più distinta menzione affinchè si vegga la rassomiglianza d’origine nella poesia drammatica di tutti i tempi.
[8] Gli spettacoli, siccome altro non sono stati giammai se non se l’espressione de’ pubblici costumi, così hanno dovuto in ogni secolo aggirarsi intorno ad argomenti conformi al genio ed al pensare attuale de’ popoli, per cui furono fatti. Senza questa massima non è possibile dar un passo nella storia filosofica delle lettere. Ora ne’ tempi e nelle nazioni che chiamansi rozze, i principi della religione agiscono con maggior forza sugli spiriti, che ne’ tempi e nelle nazioni che diconsi illuminate, sì perché venendo per lo più la coltura delle arti e delle scienze in un popolo congiunta coi progressi del commercio, del lusso, e delle altre cose, le quali necessariamente corrompono i costumi, non è facile che i motivi religiosi abbiano gran potere, ove i vizi han troppa licenza, come perché, essendo il carattere generale della filosofia quello di render probabili le cose più dubbiose, e di sparger dubbi sulle verità più evidenti28 non è possibile ottenere che siffatto scetticismo non si stenda anche agli oggetti più rispettabili, i quali appunto perché sono tali, e perché mettono a disagio le nostre passioni, si vorrebbe pure che non esistessero. La storia di tutti i tempi non è che una riprova continuati di questa verità incontrastabile. Però gli spettacoli nel loro nascere, ovunque si formano dipersè, e non per pura imitazione degli altri (nel qual caso la faccenda procede altrimenti) impresero a trattar argomenti propri della religione di quel dato paese, come cel dimostra l’esempio di molti popoli selvaggi, degli Scandinavi, de’ Messicani, de’ Peruviani, de’ Chinesi, e de’ Greci principalmente. Così dovea accadere eziandio nella prima origine delle moderne rappresentazioni, e così accadde in fatti ne’ secoli barbari. I pellegrini, che spinti dalla divozione erano andati a visitar i luoghi ove nacque e morì il comun Redentore, a San Giacomo di Galizia, alla Madonna di Puy e tali altri santuari, cominciarono i primi nel ritorno loro a farsi sentire or soli, or molti insieme cantando sulle pubbliche strade cogli abiti coperti di conchiglie, di medaglie e di croci la Passione del nostro Signore, le gesta di Maria Vergine, di San Lazzaro, degli Apostoli, ed altri argomenti sacri tratti dalla Divina Scrittura, o dalle Leggende de’ Santi. Piacque al popolo cotal usanza per la novità, e per la maggior divozione d’allora, ed ecco introdotti in Germania, in Francia, in Ispagna, e in Italia i ludi, ovvero siano i misteri detti della Passione. Sul principio non furono se non rozzi spettacoli presentati agli occhi del popolo su i cimiteri delle chiese, sulle piazze e sulle campagne, la qual circostanza ebber essi comune ancora colla tragedia greca, che nacque, a ciò che si dice, nelle feste di Bacco fra il tripudio e l’allegrezza degli agricoltori. Giudicandosi poscia cotai luoghi men degni, si celebrarono dentro alle stesse chiese in teatri a bella posta inalzati, e s’accompagnarono spesso colla danza, col canto, e col suono nelle gran solennità, o nelle nozze, o ingressi de’ principi. Un’altra particolarità onde s’assomigliavano agli antichi spettacoli è quella d’esser eseguiti e d’aver per autori persone consecrate al servigio della religione. Ognun sà che i primi poeti greci furono insiem sacerdoti, e che eglino medesimi recitavano al popolo i loro componimenti, il qual costume durò sul teatro costantemente fino ai tempi di , il primo fra i tragici antichi che cominciasse ad abbandonarlo. Similmente fra noi le persone di chiesa s’applicarono a siffatto esercizio, come sappiamo di molti, tra quali vanno attorno stampate le sei commedie sacre di canonichessa di Gandersheim scritte prima del mille: si sa parimenti da un antico storico citato dal Muratori, che vi si usò dal clero recitar in pubblico i ludi, come fanno in oggi gli attori, e (ciò che dilegua affatto ogni dubbio) nel decretale di Gregorio nono si asserisce espressamente che i preti diaconi e suddiaconi comparivano mascherati in chiesa a divertir il popolo con simili spettacoli29 autorizzati qualche volta colla presenza del Vescovo.
[9] Ma le diverse circostanze de’ tempi e de’ luoghi non permisero che le rappresentazioni sacre avessero presso a noi lo splendore e la durata ch’ebbero presso a loro quelle dei Greci. Di ciò due ne veggo esser state le cagioni. La prima la differenza degli autori di esse rappresentazioni nei diversi paesi. L’impiego di poeta fra i primi Greci era di somma importanza, e consideravasi come una delle cariche più rispettabili dello Stato. Quindi è che la esercitavano persone scelte, le quali congiugnevano con un sommo ingegno una perfetta cognizione degli affari politici, e delle opinioni che conveniva istillare negli animi del popolo. Sapevano essi non pertanto trovar i mezzi più acconci a perfezionar il teatro, e a renderlo ognor più conforme alle mire che si proponeva il governo. All’incontro i poeti italiani de’ secoli barbari erano, come quelli di tutta l’Europa, una truppa d’uomini ignoranti, e senza educazione. I Preti, che per lo più erano gli autori e i direttori degli spettacoli, non venivano eccettuati. Si riputava dotto fra essi chi sapeva leggere, e molti ignoravano persin la maniera di scriver il proprio nome. Se alcun talora si distingueva dagli altri il suo sapere consisteva in una scienza di tenebre, che non aveva altro valore intrinseco se non quello che le veniva dato dall’altrui ignoranza, in un gergo inintelligibile, in una serie di cavillazoni egualmente oscure che inutili alla sublime religione, che e’ pretendevano rischiarare. Alla dimenticanza de’ veri principi di questa, tenne dietro anche quella della morale. Giunsero non pochi fra loro a scordarsi, che la simonia, la venere sciolta e l’adulterio fossero peccati, e vi si trovano parecchi canoni de’ concili a que’ tempi destinati unicamente a rammentar ai preti quelle verità, che mai non ebber bisogno di pruova presso le nazioni più incolte. Lascio pensare qual influenza dovesse avere tanta, e sì universale ignoranza sulla formazione degli spettacoli.
[10] La seconda cagione più sottile, e più ascosa è riposta nella natura, ed indole d’entrambe le religioni. Il gentilesimo, almeno come si credeva dal popolo, era un sistema d’opinioni assurdo ne’ principi, difettoso nei mezzi, incoerente nelle conseguenze, indifferente per la morale, con cui niuna avea o pochissima relazione, e ingiurioso alla divinità, la quale bisognava sfigurare per accomodarla ai capricci degli uomini. Da tanti errori le belle arti ritraevano gran vantaggio per la loro perfezione, e progressi: merito assai tristo per una religione, l’oggetto della quale debbe esser quello d’assicurar all’uomo la felicità della vita presente, e della futura, e non di regolare lo scalpello dello scultore, o di porger materia alle bizzarro fantasie d’un bello spirito. L’immaginazione madre dell’entusiasmo avea nella Grecia fabbricato tra il cielo e la terra un palazzo di splendente cristallo, ove trasparivano idoleggiati sotto le forme più fidenti la natura, gli uomini e i numi. Ove il culto religioso fomentava le passioni invece di reprimerle, gli oggetti di esse passioni doveano deificarsi: conseguentemente leggiamo, che la bellezza de’ fanciulli e delle donne riscuoteva onori divini; che Venere, Ganimede, Ebe, Adone, e le Grazie furono posti ne’ seggi celesti, e che le meretrici perfino ebbero altari, e feste a lor nome. Ove gli dei lasciando ai filosofi la cura d’ammaestrar gli uomini nella morale, si prendevano soltanto il pensiero di divertirli, inventando i balli, i suoni, i versi e la maniera di coltamente parlare, la poesia, la musica, il ballo, l’eloquenza, e tutte le belle arti dovevano riguardarsi come oggetti celesti da pregiarsi sopra qualunque cosa terrena. Perciò mentre s’andava a prender le regole di vivere costumatamente da povero e dispregiato ateniese: mentre le leggi politiche si sforzavano di riparare colla saviezza loro ai danni cagionati dalla religione: mentre la filosofia s’opponeva con man vigorosa alla influenza de’ vizi protetti dal cielo; in questo mentre, io dico, si vedeva Giove padre degli dei dipinto ne’ pubblici templi della medesima città colla lira in mano, s’adoravano Castore e Polluce per aver i primi istituita la danza, veniva onorato Mercurio come inventore della eloquenza, e si dava a nove vergini deità la singolar incombenza di presiedere alle canzoni. Ove le passioni avevano in cielo la loro difesa, e le arti il loro modello, ben si vede qual entusiasmo dovea accendersi in terra per coltivar queste, e ingentilir quelle favoreggiato poi dagli usi politici, e ravvivato dalla possente influenza della bellezza, principio comune delle une e delle altre.
[11] Di più: in una religione che parlava molto ai sensi e
pochissimo alla ragione, e che rappresentava l’essere supremo sotto velami corporei,
gl’iddi non si distinguevano molto dagli uomini: anzi, ponendo mente alle assurdità e ai
vizi attribuiti a loro dai poeti , chiunque avea fior di senno dovea pregiare assai più
un vile schiavo virtuoso, che non gli oggetti della pubblica venerazione. colla sua gamba fracassata faceva arrossire tutti
gli dei d’, e giustificava pienamente il preteso
paradosso degli Stoici: «che il Saggio è superiore a Giove»
. Perciò la
divinità, come veniva considerata dal volgo, nulla perdeva del suo esposta sulle scene.
Gli spettatori non vedevano tra essa e loro quella distanza infinita, la quale,
togliendo ogni proporzion fra gli estremi, rende inapplicabile qualunque teatrale
imitazione. Sapevano essi dalla pubblica tradizione, che la natura loro non liberava gli
dei né i Semidei dagli affetti perversi, e dalle inclinazioni, onde vien tante volte
l’umana debolezza agitata e sconvolta, cosicché potevano prender interesse nelle vicende
loro, come noi lo prendiamo nelle sciagure di Zenobia, e di Mitridate. né troppo
era strano anche il deriderli sulle scene, come vediamo pur qualche volta aver fatto
. Basta leggere nel primo atto d’una
delle sue commedie intitolata le Rane il burlesco e licenzioso dialogo
tra Ercole e Bacco per conoscere qual conto facessero degli dei tanto il poeta, che
metteva in bocca loro simili oscenità, quanto il popolo, che ne applaudiva. né minori
prove d’irreverenza si trovano ne’ poeti tragici. Era le altre sentasi le bestemmie, che
fa dir Euripide ad un suo personaggio:
«Ah! di sicuroNulla è quaggiù. Non della gloria il lampo,Non la fortuna toglieran, che l’uomoMisero infine non divenga. i numiTurban le cose, negli umani eventiConfusion, disordine mischiandoPerché dell’avvenir nulla sapendoSiamo costretti a venerarli…»30
[12] Al che s’aggiugne che, avendo il gentilesimo presi i suoi fondamenti nella storia greca, il rappresentar sul teatro le opinioni religiose era lo stesso che richiamar il popolo alla ricordanza e all’ammirazione de’ fatti patriotici, e conseguentemente risvegliar in esso l’amore della libertà, e della patria, virtù delle più utili per tutto altrove, ma necessarissime nella costituzione de’ Greci, i quali aveano scacciati i re per divenir repubblicani. Così gli spettacoli, le belle arti, la politica e la religione erano talmente legati fra loro, e, per così dire, innestati, che non poteva alcuno di tali oggetti cangiarsi senza che tutti gli altri non se ne risentissero. Ed ecco il perché le rappresentazioni sacre ebbero in Grecia sì lunga durata, e di tal importanza furono considerate.
[13] Tutto l’opposto avviene fra noi. Il cristianesimo, quella religion santa, che trae dal cielo la sua origine, ci dà della natura divina, e delle cose che le appartengono, una idea troppo rispettabile, perché possano servir sulla scena di spettacolo agli uomini. Incomprensibile ne’ suoi misteri, perché le operazioni dell’Esser infinito oltrepassano la debole potenza della finita ragione, esso ricava maggior motivo di venerazione della sua medesima oscurità.
«Profonda e chiara, tenebrosa e vera.»
[14] Legato intimamente colla morale, cui serve di sostegno e di guida, ha per iscopo principale il reprimere le ribellanti passioni, atterrando l’idolo dell’amor proprio. Unicamente occupato nel procurar all’uomo la felicità eterna, per cui la vita temporale non è che un breve e fuggitivo passaggio, raccomanda la pratica delle virtù, che a tal fine conducono. La rinunzia a tutti i piaceri del secolo, l’annientamento di se medesimo, il timore d’un Dio, che ovunque è presente per esaminare le più ascose rivolte dei cuore, la perpetua ricordanza della morte, e del suo futuro destino, in una parola la sublime, e salutare tristezza di questa vita per guidare all’altra ad un’allegrezza interminabile; ecco il vero spirito del cristianesimo. Beati coloro che sanno sparger lagrime in questa valle di pianto!31 Basta la semplice esposizione dei fatti per capire quanto la rappresentazione di essi divenga impropria sul teatro, ove la libertà degenera sì spesso in licenza, e l’allegrezza in tripudio. Non potendo sollevar gli sguardi del volgo fino alla grandezza delle cose rappresentate, egli è d’uopo abbassar queste per avvicinarle agli occhi suoi, accomodar la natura divina alle passioni degli uomini, e far un materiale spettacolo della più spirituale fra tutte le religioni. Perciò gli argomenti sacri debbono degenerare in assurdità ovunque la religione, e il teatro formano due oggetti separati, come avviene presso di noi, poiché il dissipamento dell’uno si oppone incessantemente alla santità dell’altra.
[15] Le notizie rimasteci di cosiffatti ludi, o misteri, la mia osservazione mirabilmente confermano. Giova fermarsi alquanto sopra di essi per conoscere i vari costumi de’ secoli, e fin dove possa giugner l’abuso che fa talvolta l’uomo degli oggetti più rispettabili.
[16] Memoranda sarà mai sempre la festa detta “dei Pazzi”
celebrata per molti secoli in quasi tutta l’Europa, dove le più
ridicole rappresentazioni si framischiavano a delle cerimonie cotanto licenziose che
sarebbero affatto incredibili se attestate non venissero da un gran numero di scrittori
saggi ed accreditati. Nelle chiese cattedrali si sceglieva ogni anno colui che dovea
presiedere alla festa col titolo d’“arcivescovo dei pazzi” e in qualche luogo gli si
conferiva il nome di “papa”. La consecrazione si faceva colle formole più ridicole.
L’eletto si metteva indosso le insegne proprie del personaggio cui rappresentava, e si
vedeva il venerabile corifeo benedire pubblicamente il popolo ora colla mitra in capo e
la croce davanti, ora colla tiara. Nel giorno in cui si presentava in pubblico per la
prima volta, il suo elemosiniere conferiva agli ascoltanti le indulgenze a nome del
padrone pronunziando in tuono grave e serioso certi versi, il cui senso era il seguente:
«Da parte di Monsignor Arcivescovo che Domenedio mandi a tutti voi un malanno
al fegato con un paniere colmo di perdoni, e due dita di rogna sotto il
mento»
. La rubrica del secondo giorno era questa: «Monsignore ch’è
presente, vi dona venti panieri pieni di dolori ai denti, e aggiugne agli altri
donativi già fatti quello della coda d’una carogna»
. Un siffatto pontefice
doveva tenere presso di sé dei ministri non dissimili a lui, e questi erano i preti
della stessa chiesa. Ne’ giorni che durava la festa (cioè dal Natale insino
all’Epifania) tutti assistevano all’uffizio divino in abito di maschera o di commedia.
Alcuni si vestivano da Pulcinella, altri da pantomimo, altri da
donna, e parecchi si lordavano il viso con varie sozzure affine di movere il riso, o di
far paura agli spettatori. Non contenti di cantare nel coro delle poesie disoneste
invece dei salmi, si pigliavano ancora il trattenimento di giuocar ai dadi sopra
l’altare, di mangiare e bere presso al sacerdote che celebrava la messa, di mettere
degli escrementi negli incensari, e di profumare il popolo con siffatta odorosa
gentilezza. Terminati i divini uffizi, correvano pel tempio come forsenati, o si
mettevano a saltare e ballare con tale impudenza che alcuni restavano ignudi in presenza
di tutti. Talvolta i secolari si mischiavano fra il clero per averne anch’essi l’onore
di rappresentare un qualche personaggio nella commedia. La
farsa per il comune si recitava nell’atrio o cimeterio della
chiesa. Ivi si tosavano i capegli e si radeva la barba al prete che più si fosse
distinto nella festa. Si faceva dopo apparire in iscena un asino abbigliato con una gran
cappa che arrivava fino in terra, d’intorno la quale gli attori cantavano “hè messer
asino hè” replicando più volte la stessa cantilena a due cori, e imitando negli
intercalari il raglio di quel vezzoso animale. Il resto consisteva in dialoghi pieni di
laidezze insipide e grossolane. Uno scandalo così enorme durò più d’ottocent’anni in
Francia in Ispagna, in
Inghilterra, in Germania e in
Italia, e prese voga persino nei monisteri dei frati e delle
monache. E ciò che dovrebbe recare stupore (se pur v’ha qualche cosa che debba recarlo a
chi conosce la natura dell’uomo, e la debolezza inconcepibile delle sue facoltà) si è
che cotali stravaganti follie sembravano agli occhi di quella gente tanto conformi allo
spirito del cristianesimo che chiunque osava vituperarle, era tenuto eretico e degno di
scomunica. Non vi mancavan nemmeno degli apologisti, che in aria posata e ragionatrice
ne istituissero le difese. Si può credere che i loro argomenti erano egualmente sensati
che la loro causa. Un Francese dottore in teologia giunse a sostenere in una pubblica
tesi che la surriferita festa era non meno grata al nostro Signore di quello che fosse
alla Madonna la festa della sua Concezione. «Diffatti (dicevano essi, appigliandosi a quella ragione, ch’è stata mai sempre lo scudo
della ignoranza, e il baloardo del fanatismo) i nostri Maggiori persone
illibate e santissime, la celebravano, perché non dovremo celebrarla ancor noi? Tutti
gli uomini abbiamo una dose di pazzia che ha bisogno di svaporarsi; non è forse
meglio, che si fermenti nel tempio, e sotto gli occhi dell’Altissimo che fra le
domestiche mura? Il liquore della saviezza è troppo forte, noi siamo dei vasi troppo
gracili per contenerlo, e però fa di mestieri dar un pò d’aria a cotesto vino a fine
di scemarne il vigore, perché non si renda nuocevole, come fanno i cantinieri nelle
cantine.»
32
[17] Ma venendo ai ludi propriamente detti, la prima
rappresentazione di cotal genere che sappiamo esser stata fatta in
Germania, intitolata Ludo Pascale della venuta, e morte
dell’Anticristo altro non era, se crediamo all’elegante e dotto Cavalier
, se non se un drammatico guazzabuglio,
ove «veggonsi apparire nella scena il papa e l’Imperadore con più altri sovrani
d’Europa e d’Asia, e l’Anticristo
accompagnato dall’Eresia, e dalla Ipocrisia, e persino la Sinagoga col gentilesimo,
che anche essi ragionano»
33. Tale fu ancora un altro spettacolo rappresentato in
Firenze, da quei del Borgo San Friano
l’anno 1304, ove fece comparire l’inferno con uomini contraffatti a guisa di demoni, ed
altri che avevano la figura d’anime ignude, le quali erano tormentate dai primi con
fuochi, ed altre pene orribili a sentirsi, come si racconta più alla distesa dallo
storico 34. Il Quadrio fa menzione d’un altro
intitolato il Costantino, dove si leggeva una pistola di San Paolo, e
alla fine si cantava il Te Deum. Nel secolo decimoquinto si recitò nel
Delfinato
l’Epulone dove Asmodeo, diavolo della lussuria, e
Pluto, diavolo delle ricchezze, compariscono
avanti il tribunale del Padre Eterno per accusar il ricco
Epulone, che si sta in ginocchione innanzi al giudice.
L’Angelo Custode è il difensore, e quasi era sul punto d’ottener
la liberazione, allorché giugne San Lazzaro, il quale informandosi
del giudizio, si volta dicendo:
«Che! Messer Padre Eterno,35Voi tu dunque salvareDi Belzebutte un germe, un mascalzone,Spilorcio, e crapulone,Che va per le cucineLe pentole fiutando, e del ProfetaSe qualchedun gli parla, o della legge,La pancia Ei si tasteggia, e poi risponde:Che legge? Che Mosè?Il Pentateuco mio questo è alla fè.»
[18] Conseguentemente a tante accuse il Padre Eterno comanda ai diavoli, che sel portino in gehennam ignis, ond’essi partono via pieni di giubbilo. Si cangia la scena, e comparisce Satanasso in trono con gran forcone in mano invece di scettro, avanti al quale Asmodeo presenta Epulone, intuonando certi versi i più ridicoli del mondo.
[19] Un’altra si rappresentò in Milano, dove compariscono in iscena Annibale, San Giorgio e Gedeone, altercando insieme per sapere chi fosse il più bravo fra di loro. Sopragiugne Sansone con una gran mascella scarnata sotto il braccio, e sfida tutti tre a duello. Dalila, che arriva, sviene per la paura, e i colpi finiscono ballando insieme una pavaniglia.
[20] La Tentazione fu il titolo di un’altra che si recitò in Siviglia l’anno 1498, nella quale il diavolo vestito da zoccolante va per tentare un eremita per nome Floriano. Disputa con lui sull’astinenza, e sull’Incarnazione, sul qual proposito il diavolo cita ed . Vuol poi dargli a mangiare del pane e del cacio, che porta nella manica per fargli rompere il digiuno, ma Santa Melania comparisce a Floriano in forma d’una vecchia, e gli fa vedere le piccole corna che il frate porta sotto il cappuccio. L’eremita allora cava fuori una gran croce, veggendo la quale il diavolo piglia la figura di porco, e va via grugnendo.
[21] In una rappresentazione francese intitolatala Resurrezione s’introduceva il Padre Eterno dormendo, e un angelo che viene a destarlo con queste parole:
«Ang.: Eterno Padre, voi avete il torto, e dovete vergognavene. Il vostro dilettissimo Figlio è morto, e voi dormite come un ubbriaco.
P. E.: Come! Egli è morto?
Ang.: Da uomo d’onore.
P. E.: S’io sapeva niente, che il diavolo mi porti.»36
[22] Tali furono insomma quasi tutte le rappresentazioni delle quali la storia ne somministra memoria in Europa ripiene, cioè, di bizzarre allusioni, d’allegorie grossolane, di spettacoli sconci che meritarono replicate volte le censure della chiesa e nominatamente del papa Innocenzo III, che le proibì. Ma ripullularono esse di nuovo col medesimo carattere di stravaganza e d’assurdità anche ne’ più colti secoli e in quelle nazioni altresì che si distinguevano nelle utili cognizioni, ed ottimo gusto. Un esempio ci fornisce l’Italia, nella quale in mezzo alla luce del Cinquecento fu istituita in Roma la Compagnia detta del Gonfalone col solo fine di rappresentarvi annualmente i Misteri della Passione. In Ispagna, dove le antiche usanze durano più lungo tempo che per tutto altrove, si conservò fino a’ nostri giorni il costume di eseguire siffatte rappresentazioni benché trasferite dalla chiesa in teatro col titolo di Autos sacramentales, ed abbellite coi più vaghi colori della poesia, e di superbe decorazioni. Il fecondissimo, e pressoché subitaneo ingegno del ne compose fino a quattrocento. Molti tomi ne scrisse anche il poeta drammatico, cui l’Europa non avrebbe forse avuto l’eguale se la regolarità corrispondesse in lui alla invenzione, la delicatezza all’intreccio, la sensatezza del gusto alla forza e fecondità dei caratteri. Il progresso dei lumi ha finalmente da qualche tempo fatto andar in disuso simili divertimenti.
[23] Ritornando al nostro proposito, e raccogliendo in breve quanto a noi s’appartiene, quattro furono i gradi o l’epoche dell’accrescimento della musica sacra. Il primo quel semplicissimo, il quale altro non comprendeva se non se le prime rozze melodie degl’inni e de’ salmi. Il secondo, in cui s’inventarono parecchie sorta di canto, che durano fino al presente, come sarebbe a dire l’antifone, gli introiti, le sequenze, i responsori, le prefazioni e tai cose, che s’alterarono coll’andar del tempo considerabilmente. I1 terzo, ove s’inventò il contrappunto chiamato “a mente” nato fra il duodecimo secolo e il decimoterzo, cioè quando sopra le sillabe e le antifone principalmente di quelle che appartengono agl’introiti, i compositori si fermavano saltellando con moltiplicità di consonanze secondo le parti di ciascuno con piacere bensì dell’orecchio, ma colla rovina e lo sterminio delle parole. Cotal abuso di consonanze e di dissonanze introdotte nella musica ecclesiastica servì a infrascarla a segno, che papa Giovanni XXII si vide astretto a proibirne la maggior parte, e a determinar il numero e la qualità di quelle che potevano usarsi, come fece con bolla espressa che trovasi fra le stravaganti. Il quarto, ove s’introdusse il contrappunto “fugato”, cioè, una serie di suoni più difficili e più carichi di fughe ed altri artifizi. Imperocché appena cominciò a rilasciarsi la modestia, per così dire, dell’antica musica o per troppa indulgenza di coloro che presiedevano alle cose sacre, o per ismodata licenza dei musici, non vi fu argine o regola alcuna, ma mille nuove spezie s’introdussero di modulazioni, di echi, di repetizioni, e di troncamenti di parole: pei quali mezzi la musica ecclesiastica degenerò in isconvenevolezza e in licenza incredibile, accelerata maggiormente coll’uso di applicar l’armonia ad una lingua morta, il cui significato non comprendendosi dal volgo con poteva lasciar nell’animo quelle traccie profonde d’affetto, che visi dovrebbono imprimere. E come spesso accadeva che neppur i maestri di cappella intendessero il latino, così non poche fiate scambiavano il motivo adattando una musica sciolta e vivace ad un sentimento grave e patetico, ovvero esprimendo con movimenti tardi parole, che indicavano celerità e brio. L’ignoranza di quei tempi fece altresì che i poeti destinati a comporre i motteti o gli inni li lavorassero senza la menoma idea di buon gusto, ond’è che ricercavansi da loro le parole più barbare, s’usavano i metri più esotici mai non ricevuti nell’idioma latino, e si riempivano di sentimenti inettissimi, o incompatibili fra di loro37. Da ciò ne risultava altresì che il popolo da una banda, e i migliori spiriti dall’altra disgustati dal misero strazio che si faceva della poesia, della musica, e del buon senso, preferivano all’armonia destinata al culto dell’Altissimo le voluttose cantilene del secolo, le quali a poco a poco ebbero in chiesa la preferenza. Allora pervenuti al colmo gli abusi, se ne avvidero i supremi regolatori delle cose sacre del danno che poteva risentirne la religione, contro cui nessun colpo si può scagliar più funesto di quello, che le viene indirizzato dalla corruzion del costume. Però il Pontefice Marcello Secondo avrebbe scacciata vergognosamente dai templi la musica come cosa profana, se il celebre trattenuta non avesse l’imminente proscrizione, componendo la sua Messa, ove si vede adombrata la decenza e maestà che conviensi ad una musica sacra. Se non che l’esempio di questo grande armonista non ha avuta alcuna influenza nell’Italia dove la musica ecclesiastica con discapito della religione, con iscandalo degli esteri, e con irreparabile iattura del buon gusto dura sul medesimo piede dopo due secoli, nonostanti alcune rispettabili eccezioni che, per esser poche, non bastano a derogare al costume generale. Le insinuanti e vivaci modulazioni destinate a preparar sul teatro gli animi alle tenerezze di Cleonice e d’Alceste sono quelle che dispongono in oggi i fedeli nelle pubbliche solennità ad assistere al più augusto di tutti i sagrifizi, e i maestosi sentimenti cantati un tempo sull’arpa di Davide seguitano a replicarsi fra noi da quelle bocche avvilite, cui meglio assai converrebbe intuonar l’inno della ebrietà fra gli evirati sacerdoti di Cibele.
Capitolo quarto §
Origine della musica profana. Stranieri venuti in Italia ad illustrarla. Suo primo accoppiamento colla poesia volgare. Intermezzi musicali. Abbozzi del melodramma.
[1] Ma se la musica sacra ebbe la sua origine, ed accrescimento in Italia, non così avvenne della profana. La religione e il desiderio di render visibile insieme e magnifico il culto divino, che bastarono a promuover quella, non erano sufficienti a far nascer questa. Acciò si coltivino in un paese le arti che parlano al sentimento e alla immaginazione, e che acquistino quella delicatezza di gusto, che le rende stimabili, oltre l’influenza del clima dolce e fervido insieme, il quale, gli organi in certa guisa modificando, disponga gli animi alla vivacità ed allegrezza, vuolsi eziandio un particolar assortimento di cause politiche, vuolsi un ozio agiato ne’ cittadini e magnificenza ne’ principi, voglionsi costumi che inchinino alla morbidezza, in una parola vuolsi piacere, tranquillità ed abbondanza. Queste ultime circostanze mancarono per lungo tempo all’Italia ora inondata da diverse piene di barbari, ora da contrasti fra il Sacerdozio e l’Impero frequentemente sconvolta, ora lacerata da potenti e rabbiose fazioni tra Guelfi e Ghibellini, ora disunita, e fra le sue membra disciolta per la gelosia di piccoli principati che la dividevano, ora da locali e fisici sconvolgimenti, che la convertirono qualche volta in palude e in deserto, miseramente sformata. Occupati non per tanto gl’Italiani nel provvedere agli sconcerti cagionati dalla guerra, dalla politica, e dalla natura non pensavano a coltivar le arti più gentili, e molto meno la musica.
[2] Toccò in sorte agli stranieri il dar la prima mossa del gusto a codesta nazione, che dovea superarli nell’avvenire, e nelle cose musicali così gloriosamente distinguersi. Questi stranieri furono i Provenzali, popolo celebre nella storia pella piacevolezza del suo temperamento sempre vivace, alla giocondità, e al riso inchinevole che abbonda di vini spiritosi e di donne galanti, e ch’educato sotto un cielo per lo più sereno e ridente, e in un paese amenissimo sembra fatto a bella posta dalla natura per non aver altro impiego che quello di cantare e ballare. Gli odierni abitatori di quelle contrade hanno tuttora lo stesso pendio verso l’ilarità, lo che ha dato luogo in Francia ad un proverbio che corre comunemente: «Che il Provenzale sdegnato minaccia un suo nimico con una canzonetta, come l’Italiano con una stilettata». Le disposizioni locali congiunte alla pace, che godevano quelle provincie sotto il lungo e felice governo de’ loro sovrani, e alla galanteria, e il lusso di alcune corti della Francia meridionale diedero origine a certe tribù, o compagnie d’uomini chiamati genericamente “Mnestrels”, i quali senz’aver soggiorno fìsso sen givano errando da castello in castello, da città in città, accompagnati dalle loro moglie e dai loro figliuoli, a imitazione degli antichi Rapsodi della Grecia, o (ciò che sembra più verosimile) come una reliquia dei commedianti latini, i quali, dopo varie trasformazioni e vicende accadute nel giro dei secoli, formarono quella genia di persone di cui si fa presentemente discorso. Si distinguevano essi con vari nomi secondo i vari mestieri. Quelli che poetavano all’improvviso si chiamavano “Troubadores”, o “Trovatori”, “Canterres” quelli che cantavano i versi composti dai primi, e “Giullares” ovvero siano “Giocolieri” coloro che suonavano un qualche strumento, o intertenevano il popolo con varie buffonerie. L’impiego loro principale era lo stesso che sempre hanno avuto i poeti , ovunque la poesia non è il veicolo della morale né lo strumento della legislazione, ma un passatempo ozioso, che non conduce agli onori, né alle ricchezze. Questo è di avvilir la dignità delle muse, adulando i potenti degni talvolta d’essere incoronati dalle mani del genio, ma per lo più stimatori ingiusti del vero merito, e che avvezzi a non pregiare altro fuorché le distinzioni della fortuna, riguardano l’uomo di talento come un pappagallo, una scimia, o qualche strano animale, cui si dà volentieri da mangiare purché divertano il padrone. Più comune dovea essere siffatto costume a que’ tempi, ove i gran signori ignoranti per educazione e orgogliosi per sistema non conoscevano altro merito al mondo se non quello della nobiltà, né altro mestiere fuorché la guerra. Senza spirito di socievolezza, senza spettacoli, e senza radunanze il solo tempo, ch’essi destinavano al pubblico divertimento era quello delle nozze, oppur delle gran fiere, che tratto a tratto s’aprivano nelle città pel mantenimento del commercio. Allora si presentavano in truppa i giullari a fine di sollazzar i conviti con canti, suoni, e balli, celebrando le gesta de’ paladini e le bellezze delle donne, sfidandosi scambievolmente a pubbliche tenzoni poeti che e musicali, e vantandosi ciascuna di superar il suo rivale non meno nella gentilezza e lealtà dell’amore, che nella prontezza dell’ingegno. Le donne, presso alle quali l’elogio fatto alla bellezza fu sempre l’omaggio più caro, e la più spedita via di guadagnarsi il lor cuore; le donne che riguardano la costanza dell’uomo come il mezzo più sicuro di mantenere ed accrescere la loro influenza sul nostro sesso; le donne finalmente in cui la vanità è la passione per eccellenza fomentata dagli usi politici per nasconder agli occhi loro il sentimento della propria dipendenza, non poteano far a meno di non compiacersi del volontario tributo che pagavano ad esse i poeti . La gratitudine, virtù facile a praticarsi, ove ci entra di mezzo l’inclinazione, le sollecitava spesso alla corrispondenza, onde nascevano quelli amori scambievoli, cagion delle tante e sì strane avventure che si leggono nelle vite de’ trovatori. Se già esse non furono bizzarre fantasie prodotte dalla calda immaginazion de’ poeti, la quale non contenta d’ingannare se stessa vuol per fino tramandare le sue illusioni ai secoli futuri. Per altro non mancavan tra loro quei macchiavellisti in amore, i quali noi credevamo non potersi trovare fuorché nei secoli della corruzione. Testimon ne sia la crudele massima enunciata nei seguenti versi da , poeta che fioriva nel 1206:
«Nus ne se puet avancierEn amor, fors par mentir,Et qui melz sen set aidierPlustost en a son plesir.Qui fame justiferaJa ne l’aimeraPar conventLoiaument.Et pour ce je me repentD’aimer cela.Où il n’a point de merci. ecc.»
Cioè: «Nessuno può far progressi in amore se non a forza di
menzogne, e chi sa meglio impiegarle ottiene prima d’ogni altro il suo piacere.
Chiunque vorrà render giustizia alle donne non dovrà amarle giammai di buona fede, e
con lealtà. Ed e perciò ch’io mi pento di amare costei, cui non si può aspettare
veruna ricompensa.»
Se in ogni tempo vi sono stati degli amanti che hanno
divinizzate le loro belle, anche in ogni tempo vi sono stati degli spiriti forti che
hanno bestemmiato contro alla loro divinità. «Tutto il mondo è fatto come la mia
famiglia»
diceva quell’altro.
[3] Ora allorché Raimondo Berengario Conte di Barcellona e di Provenza venne in Italia a fine di visitare l’Imperadore Federico Primo dimorante a quel tempo nella Lombardia, e più allorché Carlo d’Angiò discese di nuovo per impadronirsi di Napoli e di Sicilia, molte truppe di Menestrieri, che venivano a loro servigio, cominciarono a farsi conoscere di qua dai monti, ove insieme colla maniera loro di poetare e colle prime rozze idee della drammatica e del ballo in azione introdussero anche presso al popolo la musica sì vocale che strumentale o la resero più comune. Dico più comune, perché da un verso latino del monaco :
«Timpana cum citharis, stivisque, lyrisque sonant haec»
apparisce, che gli Italiani facevano uso della musica strumentale profana fin dai tempi della famosa Contessa Matilde. Ma la gloria d’avere i primi accoppiata la musica alla poesia volgare può con tanto minor ragione negarsi ai Provenzali quanto che niuna delle moderne nazioni Europee ci presenta monumenti di poesia profana posta sotto le note che gareggino nell’Antichità con quelli presentati da loro. Molti codici, dove si contengono le poesie loro, vengono citati dagli eruditi, i quali, benché siano antichi, non salgono però ad un’epoca cotanto rimota, che conceda ad essi il diritto di primeggiare sugli altri popoli. Nullameno vi sono delle ripruove, che fanno vedere la musica applicata alla poesia volgare non molto dopo a’ tempi di . Tra le altre bastine recar in mezzo la seguente, che mi è avvenuto di ritrovare, e che certamente non è stata da chi che sia pubblicata finora. Nell’Ambrogiana di Milano si conserva un antichissimo codice, del quale ho avuta alle mani e riletta una esattissima copia. Esso ha per titolo: Trattato del canto misurato. L’autore è un certo monaco benedettino normanno di nazione, o secondo alcuni parigino. Egli fu abate del monistero d’Afflighem nella Contea di Brabante. Fiorì sul fine dell’undecimo secolo, e sul principio del duodecimo. Di lui fanno menzione fra gli altri il , , e il , i quali l’annoverano anche fra gli scrittori ecclesiastici a motivo di dodici libri composti da lui sulla Grazia. Nel mentovato codice, vien riferito, anzi proposto per esempio il primo versetto d’una canzone provenzale posta sotto le note secondo la musica di que’ tempi.
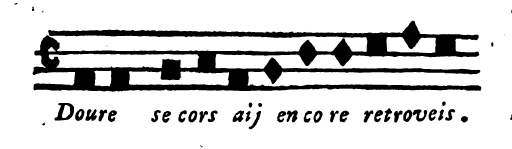
[4] Supponendo adunque che scrivesse il suo trattato verso il 1100, o anche verso il 1106, e trovandosi di già citate poesie musicali, hassi ogni ragione di credere che siffatta usanza conosciuta fosse dai provenzali anche prima del 1100, sino alla qual epoca non trovandosi alcun monumento che risalga nelle altre nazioni europee, ad essi pure incontrastabil rimane la gloria di averla i primi adoperata.
[5] Cade non per tanto da se medesima l’asserzione della massima parte degli scrittori francesi, i quali dicono che l’epoca delle prime poesie composte nella loro lingua volgare (comprendendo sotto questo nome anche la provenzale quantunque fosse differente dalla francese) debba fissarsi sul fine del secolo duodecimo. Prima dell’età di le canzonette musicali, siccome ogni altro genere di poesia, si componevano in latino. Il più antico monumento di cotal genere che abbiano i Francesi vien reputato un componimento cantato al re Clotario secondo in occasione d’una celebre vittoria riportata contro ai Sassoni. Eccone per saggio due sole strofi:
«De Clotario est canere Rege FrancorumQui ivit pugnare cum gente SaxonumQuàm graviter provenisset missis SaxonumSi non fuisset inclitus Faro de gente Burgundiorum.Quando veniunt in terram FrancorumFaro ubi erat Princeps missi Saxonum,Instinctu dei transeunt per urbem MeldorumNe interficiantur a Rege Francorum.»
[6] Piena di tenerezza benché barbaramente espressa è altresì una canzonetta flebile di , sassone morto prima del 900, dove si lamenta del suo esiglio:
«Ut quid jubes, pusiole?Quare mandas, filiole,Carmen dulce me cantareCum sim longè exul valdeIntra mare;O cur jubes canereMagis mihi miseraleFlere libet pueralePlus plorare quam cantare;Carmen tale jubes quare,Amor care,O cur jubes canere?»
ecco i , e i dei secoli barbari.
[7] Se poi i provenzali siano stati eglino medesimi gl’inventori di quella sorta di musica e di poesia, oppure s’abbiano l’una e l’altra ricevuta dagli arabi per mezzo dei catalani, io non mi affretterò punto a deciderlo. Sebbene l’influenza letteraria e scientifica di que’ conquistatori sul restante della Europa sia stata con gran corredo d’erudizione da un dotto spagnuolo38 oltre modo magnificata; sebbene il sistema poetico e musicale d’entrambe le nazioni araba e provenzale concorra in alcuni punti di somiglianza, ciò nonostante io non mi crederei in istato di poterne cavar conseguenza in favor della prima. Rispetto alla musica, l’Italia nel suo , la Germania in e in , e la Francia nel suo vantano scrittori fondamentali di quella scienza, trattata da essi (in quanto lo permetteva la rozzezza de’ secoli) con regole giuste e con sodi principi senza che alcun ragionevole indizio vi sia onde poter sospettare aver quelli autori ricavati i propri lumi dalla lettura, o dal commercio coi saraceni. Noi ignoriamo se gli arabi conoscessero le note figurate, o per dir meglio, abbiamo non poca ragione di credere che fossero affatto sconosciute ad essi. Gli esempi, che s’adducono non sono tratti da loro, ma dagli Spagnuoli, e quelli non sono anteriori alla metà del secolo decimoterzo; laddove da ciò che si è finora indicato in questo capitolo e nell’antecedente, apparisce che le note colla codetta all’insù o all’ingiù erano di già conosciute in Provenza e in Italia fin dal secolo undecimo, e forse anche prima. Noi vediamo la musica sortir bambina in Europa da mezzo al culto ecclesiastico, crescer fanciulla ne’ monisteri che la promossero, pigliare stabile consistenza e vigore colla invenzion delle note, abbellirsi insieme e corrompersi coll’uso del contrappunto, senza che sappiamo qual influenza avesser gli arabi in cotai cangiamenti. Rispetto alla poesia, l’indole della provenzale tutta fievole e cascante di vezzi è tanto diversa dall’arabica sparsa di pompose figure, e fraseggiata alla foggia orientale; la natura degli argomenti è così differente; così ne è lontano l’andamento dell’una e dell’altra, che il menomo vestigio non si scorge d’imitazione. Niuna favola arabica posta in versi dai provenzali, niuna question filosofica, delle quali in singoiar modo si compiacevano i saraceni poeti , trattata da questi, niuna allusione a’ loro scritti, alla lor religione, a’ loro costumi. S’udivano bensì frequentemente nelle canzoni de’ provenzali i nomi d’Arturo, di Merlino, di Carlo Magno, d’Oliviero, e d’Orlando; quelli d’Abderramen, d’Omaro, di Abdalla, di Mirza, de’ sultani, delle sultane o dei califfi non mai. L’uso della rima, la tessitura de’ versi, la proporzione fra gl’intervalli e i riposi nel metro erano conosciute egualmente da’ normanni, da’ goti, e da più altre nazioni, che dagli arabi dominatori. Ora se non è possibile imitar un quadro senza che si ravvisino nella copia i lineamenti dell’originale; se le facoltà appartenenti al gusto hanno i loro principi comuni a tuti i popoli e a tutti gli spiriti, ne’ quali convengon gli uomini per puro istinto senza che ci sia d’uopo la comunicazion vicendevole; se il genio che riscaldò gli abitatori della fervida Arabia, presso ai quali la vita umana si chiamava l’«istmo della eternità»; dove la candidezza di un seno sprigionato dal carcere, dove lo nasconde il pudore, si paragonava al chiaror della luna, allorché per metà si mostra fuori dalle nuvole, il bacio d’un’amante ad un sorso dell’idromele, che gli eletti gustano in Paradiso, l’alitto voluttuoso d’una bella quando sospira alla fragranza aromatica, che dai boschi della Idumea schiude il vento Imperador dei deserti, l’arco iride ad un ponte levatoio fabbricato dai numi per mantener il commercio fra il cielo e la terra con simili altre gigantesche espressioni, nulla ha di analogo col timido e freddo poetare de’ provenzali; se finalmente negli usi, nel clima, nelle politiche vicende, nelle lingue e nella storia delle nazioni europee si trova la ragion sufficiente dell’origine e progressi della musica e della poesia moderna, io dimando perdono ai fautori degli arabi se non ravviso abbastanza quella prodigiosa influenza che si pretende aver essi acquistata sul gusto degli altri popoli.
[8] Chiunque vorrà prendersi il pensiero d’esaminare la poesia provenzale troverà ch’essa non era affatto priva d’una certa mollezza, né di certi piccoli vezzi propri di quella lingua, ma troverà nel tempo stesso che il suo gran difetto era quello d’essere troppo uniforme, e di sembrar fatta dai poeti sopra un unico getto. Gli argomenti delle loro canzoni sono meschini per lo più, né mai s’inalzano alla sublimità degna del linguaggio dei numi. Le gesta dei paladini, le lodi del loro poetare, qualche sarcasmo contro ai loro rivali in poesia e l’esposizione poco dilicata dei propri amori, ecco il ricinto che comprende pressoché tutto il parnaso provenzale. Altri oggetti non sanno comunemente descrivere fuorché la primavera, i ruscelli, i fiori, la verzura delle campagne, e le penne variopinte degli uccelli. Nelle loro egloghe o “pastorelle” v’era, a così dire, stabilito il suo cerimoniale amatorio. Il poeta dovea sortire per accidente fuori della città, dovea per accidente scontrarsi in un amabile foro setta ch’errava solitaria ne’ boschetti, per accidente doveva entrar seco lei in dichiarazioni amorose, e per accidente altresì dovea prima di tornarsene a casa ultimar la poetico-amatoria faccenda. Il disgusto procurato da cotale uniformità si risentiva fin da loro stessi. , celebre trovatore che fiorì verso il 1235, si burla di cosiffatti poeti nei seguenti versi:
«Feville ne flors ne vaut rien en chantantFors ke por defaute sans plus de rimoier»
«Le frondi e i fiori non servono a nulla nel canto fuorché a
coloro che non sanno poetare altrimenti.»
Un altro difetto dei loro versi era
la mancanza d’immagini e di colorito poetico. Per lo più gli amanti esponevano la loro
passione alle innamorate in istile di gazzetta, e si direbbe quasi che volessero
presentare il manuale dei loro sintomi amorosi come i piloti presentano al capitano il
diario della navigazione. La delicatezza non per tanto che scorgesi in alcuni tratti è
piuttosto d’arguzia che di sentimento, più epigrammatica che appassionata; stile, che
necessariamente nascer dovea dalla loro foggia di poetar tenzonando, altro non
cercandosi per vincere in simili giostre che i giuochi dell’ingegno, non la spontaneità,
né la verace espressione della natura.
[9] D’un genere non molto diverso era la loro musica. In una canzone composta dall’antico menestriero nell’idioma provenzale e ridotta al moderno francese da un colto letterato vien lodato quel poeta per aver saputo suonare un gran numero di stromenti. Ecco la strofa, che tutti gli annovera:
«Il chant avec flutte ou trompette,Guitarre, harpe, flageolet,Grande corne, petit cornet,Tambourin, violon, clochette,Il fait la basse et le fausset,Il inventa vielle et musette;Pour la manivelle ou l’archetNul n’egale .»
[10] Da ciò si vede che la musica strumentale era abbastanza numerosa e variata. Intorno al canto diverse furono le mutazioni. Da principio si cantavano le loro canzonette a orecchio senza la composizion musicale. Indi cominciarono a lavorar le arie sulle parole, ma siffatte arie altro non erano che un semplice canto gregoriano, o, per dir meglio, altrettante parodie del canto ecclesiastico. In moltissime loro canzoni si trova alla fine il primo versetto o la prima parola dell’inno latino sulla cui composizione furono esse modellate. In seguito alcuni bravi musici fra loro composero a bella posta delle arie profane diverse da quelle di Chiesa. L’abuso di modulazioni molli ed effemminate introdotte nel canto ecclesiastico, di cui sì altamente si lagnava , ci farebbe credere che la musica profana non andasse esente da simile difetto; tanto più che le poesie amorose e gentili, alle quali s’applicava comunemente, ne rendevano la mollezza assai più scusabile. Pure volendo giudicare dai frammenti che ci restano, essi ci fanno vedere tutto il contrario. La musica delle canzoni provenzali non solo nell’esempio di citato di sopra, ma anche ne’ versi di , e in altri non pochi da me veduti e disaminati è tanto semplice e povera che niuno si ravvisa di quei difetti attribuiti dal Sarisberiense alla musica ecclesiastica. Non modulazioni lussureggianti, non vana ostentazion d’inflessioni, non soverchio tritume di note, ma sobrietà bensì, e gastigatezza, e proporzione esattissima tra le parole e i suoni, cosicché ad ogni sillaba non più corrisponde che una sola nota. Cotal diversità fra la musica profana e la sacra dee, secondo il mio avviso, ritrarsi dal costume usato in chiesa di cantar a più voci, ciascuna delle quali cantando a modo suo, era più facile che degenerasse in confusione e in abuso, laddove le canzonette profane figlie dell’istinto e del sentimento, e cantate per lo più da una sola voce potevano più a lungo conservare la loro semplicità primitiva. Dico più a lungo e non sempre, perché appena prese voga il contrappunto, la musica provenzale restò anch’essa infettata dalle solite stravaganze39.
[11] Ritornando ai menestrieri, quei che si sparsero per l’Italia venivano conosciuti dal volgo sotto il nome ora d’“uomini di corte”, ora di “ciarlatani”, denominazione che presero non dalla parola “circulus” né da “carola”, ma, come ben osserva il , dalla parola “ciarle”, maniera italiana di pronunziare il vocabolo “charles” francese, a motivo che i trovatori cantavano spesso le azioni di Carlo Magno. E da “ciarle” venne in seguito “ciarlare”. Le storie di que’ tempi sono piene delle singolari azioni di questi uomini, del favore che ottenevano presso ai signori italiani, e de’ grandi e sontuosi regali, onde veniva rimunerata l’abilità loro. I Malatesti di Rimini, gli Scaligeri di Verona, gli Estensi di Ferrara, e Visconti di Milano si distinsero principalmente nel proteggerli. In contraccambio il clero sovente li perseguitò fino a proibire con frequenti scomuniche i loro congressi, o perché temeva che portando gli uomini al dissipamento servissero ad alienarli dall’utile e salutare tristezza che esige la religione, o perchè vedeva colar in mani profane quei doni, che potevano più utilmente convertirsi in limosine a servigio dell’Altare, o perché mescolandosi poscia cogl’istrioni, e coi mimi, erano divenuti infami al paro di loro per pubblica scostumatezza. Ma i principi sdegnati col clero per veder frastornati da esso i pubblici divertimenti, condannavano talvolta i preti a dover pagare ai giocolieri la loro mercede, il qual abuso fu poi corretto da un Concilio tenuto in Ravenna all’anno 1286 con severi decreti, che possono leggersi nella raccolta del .
[12] Anche i governi secolari fecero qualche volta lo stesso, fra i quali si trova nella storia del all’anno 1288, che la Repubblica di Bologna spedisce un Decreto col quale si vietava che i cantori francesi potessero fermarsi sulle pubbliche piazze del comune a cantare. A imitazione de’ trovatori molti e celebri Italiani fiorirono in Milano, Mantua, Vinegia e in Sicilia principalmente per la dominazione de’ provenzali ivi stabilita.
[13] A imitazione de’ Provenzali molti Italiani distinti per nascita, dignità e sapere fiorirono in Milano, Mantua, Vinegia e in Sicilia principalmente pella dominazione degli Angiovini ivi stabilita, dei quali non mi fermerò a fare particolar menzione dappoiché il , il , e meglio di loro il hanno sparsa cotanta luce su quella parte di storia. Farò bensì una osservazione più confaccente allo spirito di quest’opera, e che ridonda insomma gloria dell’Italia. Questa si è che la poesia provenzale povera nella sua origine e di piccol pregio, finché rimase nel suo nativo terreno, tosto che fu traspiantata sotto il cielo italiano divenne non solo bella e gentile, ma capace di gareggiare colla lirica più squisita de’ Latini e de’ Greci. Anzi se vero è, come molti scrittori affermano, che il trovasse fra i provenzali l’incitamento e l’esempio al suo poetare, e che il canzoniere di questo poeta debba considerarsi quale compimento e perfezione di quel genere di poesia, converrà dire che il ramo della ragione poetica coltivata dai provenzali, indi trasferito in Italia ne producesse frutti d’un sapore sconosciuto perfettamente agli antichi, e che che ne dicano in contrario gli idolatri dell’antichità, e gli armenti della filosofia che si pascolano negli orti d’Epicuro, superiore altrettanto a ciò che lasciarono in quel genere la Grecia e il Lazio quanto il purificar la natura è preferibile al dipignerla schiava de’ sensi, e quanto le idee dell’amor razionale sono più poeti che e più sublimi che non quelle dell’amor sensitivo o meccanico.
[14] Ma le cause che fecero coltivare a quei tempi la lirica amatoria, cioè i famosi parlamenti d’amore, la mollezza licenziosa che dalla corte papale d’Avignone e dalle altre città della Francia, erasi rapidamente propagata pell’Italia, e l’influenza che fin d’allora ebber le donne sulle produzioni dell’ingegno trattennero il volo all’altra spezie di lirica eroica, che tanto imperio acquistò sulle menti dei Greci. Quindi è che se l’Italia ebbe in , in , e nel i suoi , i suoi , e i suoi d’un genere più dilicato, ella non ebbe mai né potè avere degli , dei , dei , e degli . Perché ciò? Perché una general corruttela avea tarpate le ali dell’entusiasmo, come quelle della virtù; perché la poesia fu riguardata soltanto come ministra di divertimento e di piacere, non mai come strumento di morale o di legislazione; perché essendo disgiunta dalla musica aver non poteva un vigore che non fosse effimero, né una energia che non fosse fattizia; perché trar non si seppe alla unione di quelle due arti il vantaggio che sarebbe stato facile il ricavare in favore della religione, mal potendosi eccitar l’entusiasmo religioso nelle cerimonie ecclesiastiche colla musica semibarbara, che allora regnava, applicata ad una lingua, cui il popolo non intendeva, onde mancò la poesia innale, e con essa uno dei fonti più copiosi del sublime poetico; perché i governi non pensarono a dar all’impiego di poeta e di musico l’importanza che gli davano i Greci, giacché invece degli e dei , che in altri tempi erano i legislatori e i generali delle nazioni, si sostituirono ne’ secoli barbari i monaci e i frati che convocavano a grado loro il popolo, intimavano la guerra e la pace, si mettevano alla testa delle armate, ed erano non poche fiate l’anima de’ pubblici affari; perché finalmente, non potendo la lirica eroica giugnere alla perfezione, di cui è suscettibile, se non quando vien considerata come un oggetto d’interesse, e di generai entusiasmo, i poeti italiani d’allora non potevano eccitar né l’uno né l’altro per l’indole della loro lingua troppo fiacca per inalzarsi alla sublimità de’ Greci e degli orientali, e per le circostanze altresì della loro nazione troppo divisa perché lo spirito di patriotismo vi si potesse vivamente accendere, e troppo agitata da intestine discordie, e dalla inquieta politica di certe corti, perché vi si potesse sviluppare quell’interesse generale, che fu mai sempre il motore delle grandi azioni. Però se un qualche si fosse presentato nella piazza di Firenze col disegno di voler conciliare fra loro con un’oda i guelfi e i ghibellini, o se un Orfeo fosse venuto colla lira in mano in mezzo agli abitatori della moderna Roma per richiamare al loro spirito le spente idee di libertà e di gloria, il primo avrebbe fatta la figura di cantambanco o di giullare da piazza, e il secondo avrebbe corso rischio d’esser di nuovo messo a morte, ma non dalle baccanti.
[15] Rinunziando non per tanto alla speranza di trovar in quei tempi l’unione della musica e della poesia diretta al gran fine legislativo e politico, contentiamoci d’esaminare le varie forme che prese dalle circostanze, dalla voluttà, dai costumi. Cresciuta la lingua italiana, crebbe parimenti l’usanza d’accoppiar qualche volta la musica alla poesia per quel segreto vincolo, che l’una all’altre tutte le belle Arti avvicina. Quel medesimo istinto che porta gli uomini ad esprimere coi particolari movimenti del corpo l’allegrezza dell’animo, onde ebbe origine il Ballo, gli porta eziandio ad accompagnar i propri gesti con certe particolari inflessioni di voce, onde ebbe origine il canto. Quella seducente e inespribile simpatia, che mille moti diversi ridesta in loro alla presenza d’un amabile oggetto, quella medesima, infiammando l’immaginazione, gli sollecita poscia a significar i lor sentimenti in versi armoniosi e gradevoli. L’allegrezza dunque e l’amore, gemelli figli della fisica sensibilità, dovettero essere le primitive cagioni della unione di codeste arti gentili. Così i più antichi componimenti musicali fatti nella volgare favella, di cui si conservi memoria in Italia furono secondo il , il , e il le ballate e le intuonate, ovvero siano canzonette che intuonavano gli amanti per dimostrar la loro passione alle donne amate. Abbiamo l’esempio sul principio del secolo decimoterzo nel celebre Imperadore Federigo Secondo gran protettore dei poeti , e de’ musici richiamati da tutte le parti per ornare, e illeggiadrir la sua Corte, il quale non si sdegnò di poetare in lingua non ancor ben purgata dalle siciliane maniere, e di far cantare dagli altri, e cantar egli stesso i suoi componimenti. Ecco i primi versi d’una sua canzone pubblicata dall’:
«Poiché ti piace, Amore,Ch’eo deggia trovareFaronde mia possanzaCh’eo vegna a compimento,Dato haggio lo mio cuoreIn voi, Madonna, amare.40»
[16] Circa le canzoni a ballo, è da osservarsi però ch’esse non ebbero in Italia un principio cotanto naturale e filosofico quanto ne sembra a prima vista, poiché dagli esempi rimastici chiaramente si scorge essere stati cotai componimenti un prodotto piuttosto della imitazione, che una libera ed espontanea emanazion del talento. Ciò si vede dai nomi che diedero i primi Italiani alle stanze di siffate canzoni somiglianti a quelle de’ provenzali, e dalla poca filosofia con cui le accomodavano ai rispettivi argomenti. Serva di pruova la seguente ballata di , la quale a preferenza delle altre ho voluto trascegliere e per la celebrità dell’autore, e perché ottiene un luogo distinto fra le composizioni di questo genere:
«Morte villana, e di pietà nemicaDi dolor madre antica,Giudizio incontrastabile gravoso:Poiché hai dato materia al cor doglioso,Onde io vado pensoso,Di te biasmar la lingua s’affatica.E se di grazia ti vuò far mendica,Convenesi, ch’io dicaLo tuo fallir d’ogni torto tortoso.Non però che alle genti sia nascoso:Ma per farne cruccioso,Chi d’amor per innanzi si nudrica.Dal secolo hai partita cortesia,E ciò che ’n donna è da pregiar virtute,In gaia gioventuteDistratta hai l’amorosa leggiadria.Più non vò discovrir qual donna sia;Che per le proprietà sue conosciute,Chi non merta saluteNon speri mai d’aver sua compagnia.»
[17] Il lavorar una canzone a ballo in occasione di tale e sì profonda tristezza qual è quella che dee opprimere un amante per la morte dell’oggetto che ama, è ugualmente contrario alla imitazion naturale di quello che sarebbe in un pittore il dipigner agghiacciati i fiumi posti sotto la linea equinoziale, o un bosco di cannella nel Settentrione.
[18] Indi a non molto s’introdussero le “maggiolate”, spezie di canto usato in Italia come in molti altri paesi d’Europa, e privativo dei primi giorni di maggio, tempo in cui per celebrar il ritorno della primavera erano soliti gli amanti a piantare in faccia alle finestre delle loro innamorate un piccolo arboscello verde di nuova fronda, e abbellito con festoni a più colori, intorno al quale ballando e ripiegandosi in sollazzevol foggia diverse truppe di giovani cantavano certe poesie che presero il nome dalla circostanza. Vennero poscia i canti chiamati “carnascialeschi” a motivo d’eseguirsi in tempo di Carnovale fra le brillanti mascherate, onde tanto si compiaceva la gioventù fiorentina. Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico era l’anima di cotali feste dove rappresentavansi sovra pomposi carri trionfali guidati per le strade di Firenze fra gli applausi del popolo parecchie ingegnose allegorie allusive per lo più a soggetti amorosi. Alle volte i trionfi del servivano d’argomento, e si cantavano posti in musica i sonetti e le canzoni di questo poeta, come in oggi si cantano le arie di . Alle volte si lavoravano a bella posta componimenti poetici che tuttora si leggono raccolti in due volumi, e ne faceva fra gli altri la musica un certo , di cui ci restano fra le carti musicali alcune piccole canzoni poste sotto le note a tre voci. Succedettero in seguito i madrigali, dei quali abbiamo fra i primi l’esempio in quelli di pistoiese posti in musica dal compositore di cui ne fa menzione il , e nelle tante madrigalesse, ballate, villanelle, serenate, villotte alla napoletana, ed alla siciliana, e in altri componimenti cantati per tutta l’Italia, e posti in musica persin da celebri donne, che gareggiavano coi più gran compositori. L’ romana, la , la e l’ milanesi, la dama perugina, la e l’ bolognesi, l’ e la napoletane senza far menzione di molte altre misero sotto le note parecchie composizioni, che divennero alla moda presso alle radunanze più colte e più gentili. Furono ancora molto in uso le villotte, delle quali eccone per saggio due strofi, affinchè il lettore avverta di mano in mano ai progressi della poesia musicale:
«Trinke got è Malvasia:Mi non trinker altro vin.Ch’altro vin star pisinin,Si mi far doler la panza.Fà venir il mio voltinDi color di melaranza.Volentier mi sta far danzaPiste trinke Romania.Trinke got è MalvasiaMi non trinker altro vin.Mi levar da mezza notteQuand’è il dì di San Martin:Vo spinar tutte le botte:Mi vuol biber da mattin.Vin è car, il mio cusin,Si mi fa ballar per via.Trink got è Malvasia.»
[19] Nel secolo XV cominciò a rosseggiar sull’orizzonte italiano l’aurora del miglior gusto nella musica, il novello raggio della quale si spiccò da un popolo che faceva profession di distruggere le arti e le scienze, come gli altri facevano di coltivarle. L’ignorante e conseguentemente feroce musulmano, sbuccando dalle gole del Caucaso, indi a guisa di turbine tutta l’Asia scorrendo, rivolse alla fine i suoi vittoriosi stendardi verso Costantinopoli, capitale d’un vasto impero ammorbidito dal lusso, snervato dalla mollezza, addormentato fra le più ridicole superstizioni. La Grecia tutta fu una picciola parte delle sue immense conquiste, a motivo delle quali i pacifici coltivatori delle lettere che abitavano quel paese tanto caro alle muse si ricoverarono nella Italia portando seco i preziosi frammenti della greca letteratura. La prosperità figlia della pace e dell’abbondanza, il desiderio d’ogni sorta di gloria proprio di quelle nazioni che hanno conosciuto la libertà, e quel segreto bisogno che ne’ tranquilli governi sprona lo spirito alla ricerca di nuovi piaceri aveano anticipatamente disposti gl’Italiani al risorgimento delle Lettere. I Greci l’accelerarono pei codici degli antichi, che fecero maggiormente conoscere, e per altri disotterrati dalle biblioteche, ove si giacevano d’ignobil polvere ricoperti. I trattati appartenenti alla musica di , , , , , , , , , , e furono letti, copiati, ricorretti, e alcuni fra essi interpretati, e tradotti dal , da , da , da con altri Italiani imitati poscia nel secolo decimosettimo, e da lungo tratto avanzati da valentissimi oltramontani.
[20] Luce più chiara si sparse dappoi colle accademie di musica e di poesia istituite a promuovere per ogni dove l’una e l’altra. lodigiano con tre altri stranieri , , e chiamati dal re Ferdinando di Napoli, gran protettore delle lettere e de’ letterati, fondarono ivi un’accademia musicale, la quale divenne col tempo il seminario de’ più gran geni che siansi veduti in Italia in cotal genere. Siena ebbe la congrega de’ Rozzi, utile quanto fosse altra mai a’ progressi del teatro italiano non men che alla musica per gl’intermezzi di canto e di suono, che si frapponevano alle loro farse o commedie. In alcune di esse ho veduto nel principio d’ogni atto una ottava d’argomento diverso da quello della farsa la quale poi si cantava al suono di lira da un personaggio incaricato di questa sola incombenza, cui si dava il nome d’Orfeo. In Verona divennero celebri verso la metà del Cinquecento i Filarmonici istituiti o promossi da a fine di migliorar la musica, come si vede fra le altre cose dalla bizzarra legge che costrigneva gli accademici a sortir qualche volta in pubblico a cantar versi colla lira in mano. Si fondarono ancora in Milano, in Bologna e altrove cattedre di musica teorica, donde incominciossi a scrivere intorno ai principi specolativi di essa, e vennero tra gli altri illustrandola il citato , il , , , , , , , , il , il , l’, il bolognese con altri molti, ma sopra tutti scrittore insigne, che divenne colle sue istituzioni armoniche maestro fondamentale nel genere pratico.
[21] Nondimeno bisogna dir chel’Italia non
avesse a que’ tempi presso alle altre nazioni acquistata quella celebrità nella musica,
che ha poi nel passato secolo e nel presente ottenuta, poichè le corti straniere, anzi i
principi italiani stessi ricercavano con gran premura e con grosse paghe musici e
cantori oltramontani. Se la mia asserzione sembrasse alquanto dura agli orecchi di que’
pregiudicati italiani che stimano se soli esser stati in ogni tempo gli arbitri del
gusto nelle materie musicali, non hanno a far altro che consultar la testimonianza
irrefragabile della Storia. Potrei citare , che lo dice, potrei aggiugnere l’Abate , che di proposito lo pruova, autori entrambi di sommo grido e di sicura
critica; ma essendo eglino stranieri, come son io, non debbono chimarsi in giudizio
contro all’Italia, essendo tale la debolezza degli uomini, alla
quale gl’Italiani al paro degli altri, e forse più degli altri partecipano, che chiunque
di patria e di linguaggio è diverso si stima, qualora non parla a grado nostro, che
debba esser acciecato dall’odio o dall’ignoranza. Non incorrerà in questa taccia il
celebre nipote di Francesco, del
quale non posso ommettere un lungo testo, che conferma mirabilmente il mio assunto. Si
trova questo nella sua descrizione de’ Paesi Bassi stampata in
Anversa l’anno 1567. «Questi sono (dice, parlando de’ Fiaminghi) i veri maestri della musica, e quelli che
l’hanno restaurata e ridotta a perfezione, perché l’anno tanto propria, naturale, che
uomini e donne cantan naturalmente a misura con grandissima grazia e melodia, onde
avendo poi congiunta l’arte alla natura fanno e di voce e di tutti gli strumenti
quella pruova ed harmonia, che si vede ed ode, talché se ne truova sempre per tutte le
corti de’ principi Cristiani. Di questa nazione, ragionando de’ tempi più moderni,
furono di
Nivelle menzionato più avanti nella sua terra, , , , , , , , ,
, , , , e i quali tutti sono morti, e di presente vivono , e , , , , , , , , , , , , vicino
d’Anversa, e molti altri tutti maestri di musica celeberrimi,
o sparsi con onore, e gradi per il mondo.»
41 E che fra le corti straniere debbano annoverarsi quelle
d’Italia, si pruova da ciò che molti di que’ Fiaminghi nominati
dallo storico, cioè , , ,
, , 42, ed altri soggiornarono lungo tempo in
Italia appresso ai principi, e tanta autorità ne acquistarono
di qua dai monti massimamente nel perfezionar il contrappunto, che il gusto loro
nazionale nella musica italiana trasfusero.
[22] Non sarà tenuto nimico delle glorie italiane il gran
, il quale, parlando di Leonello d’Este Duca di Ferrara,
che successe al suo padre nel 1441,
dice «che fece venir da Francia i cantori»
43, anzi i più bei madrigali di alcuni di essi
francesi dimoranti allora in Italia si trovano raccolti da
, udinese, e proposti per
modello d’imitazione nel suo rarissimo libro, che ha per titolo Il vero modo di
diminuire con tutte le torti di stromenti.
[23] Italiano è pure il , e interessato nelle lodi della sua patria, del quale però eccone le
parole tratte dal suo libro assai noto della nobiltà milanese, ove parla di Galeazzo Sforza Duca di Milano,
che vivea nel 1470. «Teneva questo raro principe trenta musici tutti
oltramontani, e tutti scelti, che da esso erano benissimo pagati, ed al maestro di
Cappella nominato dava cento scudi al
mese (ch’ora sarebbero più di dugento) posciachè molto si compiaceva della musica,
nella quali era intelligentissimo.»
44 Questo testo viene falsamente attribuito dall’Abate al celebre .
[24] Nè soltanto Fiaminghi e Francesi furono avidamente cercati
dalle corti italiane, ma gli Spagnuoli eziandio, e gran riputazione acquistarono questi
in Roma presso ai papi, e grande autorità presero nella Cappella
Pontificia, i soprani della quale fino a’ tempi di Girolamo
Rosini, perugino, erano stati tutti spagnuoli, secondo che rapporta
l’italiano nelle osservazioni per ben
regolar il canto nella Cappella Pontificia45. I vantaggi che recarono essi alla musica non meno pratica che
teorica sono tanto riguardevoli, che ommettendoli, farei torto alla scienza, alla storia
e alla mia patria. Bartolomeo Ramos Pereira o
Pereia, che venne l’anno 1482 chiamato fin da
Salamanca ad occupar la cattedra di musica eretta dianzi in
Bologna da Niccolò V,
sarà sempre dalla memore posterità annoverato fra i più grand’inventori. Egli ebbe il
coraggio di svelar all’Italia gli errori di , e di scoprir le debolezze del suo sistema, e
le inconseguenze. Il temperamento ch’egli propose nel suo trattato della musica divenuto
rarissimo, comechè a fiera tenzone spingesse e gli altri partigiani di , fu alla perfine abbracciato dai più valenti Italiani46. Frate dimorante anch’esso in Italia verso
il 1520 merita esser cavato dalla oscurità, ove indebitamente giaceva sin’ora. Se l’aver
aggiunto una nota di più all’“ut re mi fa sol la” inventato, come si pretende, da
è di gran vantaggio per la musica, e
se questa può dirsi una gran scoperta, che meriti, che si scriva un libro a bella posta
per risaperne l’autore, come pur si fece da un musico chiamato De Nivers sul principio del nostro secolo; cotal onore è
certamente dovuto a questo religioso spagnuolo, poich’egli ne fu l’inventore. Siffatta
scoperta sconosciuta non meno al pubblico che al citato scrittore che ne ha ricercata
l’origine, si ritruova nel compendio del sistema di esso fatto, e pubblicato in Roma in lingua
spagnuola l’anno 166947 così per un destino che sembra proprio della nostra
nazione, mentre si cerca vanamente in Germania, in
Francia, e in Italia a chi debba
attribuirsi la gloria di cotal ritrovamento, giace polveroso e dimenticato in qualche
biblioteca il vero inventore. Di
non farò che un sol cenno, non potendo ignorarsi da chiunque ha l’erudizion musicale
assaggiata a fior d’acqua, ch’egli fu il principe de’ teorici del suo tempo, come
ampiamente il confessano i più illustri scrittori italiani di tali materie ,
e . nativo d’Avila illustrò anch’egli moltissimo la musica
italiana non solo con opere assai pregiate a’ suoi tempi, le quali furono stampate in
Roma l’anno 1585, ma con belle composizioni di pratica, per cui
divenne rivale e socio del celebre nel
riformare e migliorare la musica ecclesiastica. Compagno nel merito, e non forse minor
nella gloria, gli andò dal paro ,
intorno a cui il dottissimo Padre citato
dall’erudito Signor Abate Don si
spiega in questi termini: «fu autore stimatissimo, e di gran grido»
48. Oltre a’ mentovati che possono
chiamarsi di prima classe, molti vi furono di qua dai monti peritissimi nell’uno e
nell’altro genere. Eccovene alcuni de’ più celebri in Roma e
altrove: , nominato dal con grande elogio, , del quale fa menzione nel suo Fronimo come di bravo compositore, , , , , , , , , ,
, , , , , ,
, , ,
, , , , , e tanti altri che più assai ne
troverrebbe chi con diligenza svolgesse gli autori italiani di quel secolo. Veggansi tra
gli altri il , , e le opere di , e di .
[25] Fu dunque l’eccedente amor della patria (il più lodevole fra
gli eccessi quando non vien disgiunto dalla giustizia) che mosse il Cavaglier a dire, parlando della musica, che «agli
Italiani del secolo decimosesto dovette il giugnere ch’ella fece a perfezione maggiore
assai, che mai non avesse in addietro»
49. Se l’illustre storico della letteratura
Italiana, che tant’onore ha recato alla sua nazione, ignorò il gran numero e il valore
dei mentovati stranieri, i quali si portarono in Italia ad
illustrar sì distintamente e sì gloriosamente la musica, noi non sapremmo se non
istupire di tal negligenza meno scusabile trattandosi d’un’arte onde gl’Italiani vanno a
ragione così superbi di quello che sarebbe stata in tanti altri punti poco interessanti,
ne’ quali però ha egli avuta la compiacenza di fermarsi a lungo. Se non ignorandoli, ha
giudicato meglio di passarli sotto silenzio, che altri chiamerebbe ingiurioso, noi non
sapremmo che rispondere a chiunque l’accusasse di parzialità manifesta. Ma gli
Spagnuoli, i Francesi e i Fiaminghi, che si veggono privi di testimonianza così
autorevole, si consoleranno nella perdita loro ripensando a tanti altri illustri
scrittori suoi nazionali, i quali hanno siffatta gloria tra essi e gl’Italiani
meritevolmente divisa50.
[26] Il rinascimento della poesia teatrale e la perfezione ove giunsero le arti del disegno furono un’altra epoca dell’incremento che prese la musica italiana. Appena comparvero le commedie d’, di , del Cardinal , e le tragedie del , del , e del ; appena la pittura cominciò a gareggiar coi Greci originali sotto il pennello di Raffaello d’Urbino, del Negroni, di Baldassare Peruzzi, e d’altri, che i principi italiani bramosi d’accrescer lustro e magnificenza alle feste loro si prevalsero a ciò della unione delle tre arti. Allora si sentì sulla scena la musica accompagnar le tragedie nei cori, e le commedie nei prologhi e negli intermezzi che si framettevano. Quest’intermezzi sul principio erano madrigali cantati a più voci ora allusivi all’argomento della favola, ora di sentimento diverso. Ben presto perfezionandosi, azioni musicali divennero da rappresentarsi ne’ tempi di pubblica allegrezza.
[27] Merita particolar menzione sì bel componimento pregievole pieno di greco spirito, come per ritogliere dalla ingiusta dimenticanza, nella quale i critici italiani hanno lasciato cadere il nome d’uno de’ più illustri mecenati delle cose musicali quello fatto da a imitazione degli antichi Peani, o nomi Pitici, che si celebravano nella Grecia in onore d’Apolline. Si rappresentò in Firenze nelle nozze di Ferdinando de’ Medici con Cristiana di Lorena col titolo: Combattimento d’Appolline col Serpente.
[28] La scena s’apriva facendo vedere ampia foresta, in mezzo alla quale si scorgeva la grotta del Serpente. Le vicine piante erano abbattute dei replicati colpi della tortuosa coda, e macchiate da livida schiuma all’intorno. Gruppi d’uomini e donne alla greca foggia vestiti vedeansi sbuccare da diverse parti del bosco, i quali, credendosi sicuri per non veder il serpente fuori della grotta, cantavano alternativamente al suono de’ vari stromenti i seguenti versi:
«Una parte: Ebbra di sangue in quest’oscuro boscoGiacea pur dianzi la terribil fera,E l’aria fosca e neraRendea col fiato e col maligno tosco.Altra parte: Qui di carne si sfamaLo spaventoso serpe: in questo locoVomita fiamma e fuoco, e fischia, e rugge;Qui l’erbe e i fior distrugge.Ma dov’è il fiero mostro?Forse avrà Giove udito il pianto nostro.»
[29] Finito ch’ebbero il canto, ecco verso l’orlo della caverna il serpente apparire, alla vista del quale i Greci da subito terrore compresi s’inginocchiano, indirizzando al cielo in piagnente e maninconico suono la seguente supplica:
«Oh sfortunati noi!Dunque a saziar la fameNati sarem di questo mostro infame?O Padre! O re del Cielo!Volgi pietosi gli occhiAll’infelice Delo,Che a te sospira, a te piega i ginocchi,A te dimanda aita, e piagne, e plora:Muovi lampi, e saettaA far di te vendettaContro il mostro crudel che la divora.»
[30] Il Serpente allo strepito delle voci esce fuori dalla caverna, e guatandoli da lontano, con orrendi sibili s’avventa contro; ma scendendo Apollo all’improvviso dal cielo, incomincia con esso un sanguinoso combattimento, il quale dura lungo tempo or fuggendo il Serpente, ora spezzando coi denti le saette scagliategli contro dal Dio, ora staccandole colle zanne dal tergo, donde fiumi di nero sangue sgorgavano, finché rimane ucciso e calpestato ai piedi del nume. I Greci, ch’erano fuggiti, ritornano, e coronando Apollo di fiori intuonano il seguente ringraziamento:
«O valoroso Dio!O dio chiaro e Sovrano!Ecco il Serpente rioSpoglia giacer della tua invita mano:Morta è l’orribil fera.Venite a schiera a schiera,Venite: Apollo e DeloCantando alzate, o belle Ninfe, al Cielo.»51
[31] Nelle pastorali poi la musica fece gran via, e noto è l’apparato musicale con cui Don Garcia di Toledo vicere delle Sicilie fece rappresentare quella del , e nota è altresì la magnificenza con cui fu posta in teatro l’Aminta del cogl’intermedi lavorati dal poeta, e posti in musica dal gesuita , come ancora il Pastor fido con tante altre, delle quali parlano a lungo gli eruditi. Dagl’intermedi, e dai cori passò la musica ad accompagnar qualche scena eziandio del componimento, del che abbiamo una pruova nella pastorale intitolata il Sacrificio d’ recitata in Ferrara verso il 1550, dove il sacerdote si mostra colla lira in mano suonando e cantando la sua parte sul teatro, e similmente si fece nello Sfortunato dell’, e nell’Aretusa d’ rappresentate alla medesima corte.
[32] Così di mano in mano crescendo dalle ballate alle canzoni, dalle canzoni alle maggiolate, canti carnascialeschi e madrigali, dai madrigali ai cori e agl’intermezzi, e da questi fino alle scene drammatiche, il lettore ha potuto vedere per quai gradi la musica sia finalmente pervenuta a costituire il pomposo spettacolo dell’opera.
[33] Pei medesimi passi presso a poco vennesi formando la decorazione. Gli spettacoli fatti per parlare agli occhi nelle pubbliche feste portavano sul principio il carattere dei loro tempi. Consistevano per lo più in cavalcate di convenzione, in fuochi accesi nelle pubbliche piazze o innanzi alle case dei particolari, in anfiteatri o monumenti inalzati con cose mangiative, in fontane di vino che zampillavano nelle strade, in mascherate romorose e grotesche, in musica di tamburi e in tali altri divertimenti fatti più per la plebagia che per uomini cui la coltura avesse ringentilito lo spirito. Il risorgimento benché lento della pittura, il commercio che vivifica le arti, onde viene alimentato a vicenda il lusso che rende squisite le sensazioni nell’atto che le moltiplica, e la connessione che hanno fra loro tutti gli oggetti del gusto fecero avvertiti gli uomini di genio che l’immaginazione dei popoli civilizzati avea bisogno d’un pascolo men grossolano, che la novità e la dilicatezza ne doveano essere i principali ingredienti, che la favola da una banda e l’allegoria dall’altra potevano somministrare agli occhi una folla di piaceri sconosciuti, e che toccava a lui solo prevalersi del vero e del finto, della natura e dell’arte, degli esseri animati e degli inerti per dar una nuova mossa alla fantasia e un vigore novello alla prospettiva. Si conobbe altresì che l’influenza di questa sullo spirito era assai debole e passeggiera ove rinforzata non venisse dall’aiuto delle arti compagne, ed ecco la prima origine di quelli spettacoli frammezzati di poesia, di ballo, di musica e di decorazione che si trovano ne’ tempi più remoti, e che ponno considerarsi come altrettanti sbozzi del melodramma. Fa di mestieri confessare a gloria dell’Italia, che appunto in questa nazione troviamo i primi fonti del buon gusto in così fatto genere, come apparirebbe ad evidenza s’io presentar volessi un quadro storico delle ingegnose feste eseguite nelle antiche corti italiane in occasione di pubblica allegrezza. Ma tale non essendo il mio assunto, mi contenterò di recar in mezzo la descrizione d’un solo di cotali abbozzi drammatici, che fa epoca nella storia delle Arti, che divenne allora la maraviglia d’Europa, e che servì non meno di stimolo che di modello a quante feste se ne fecero in seguito nelle altre corti. Fu dato il surriferito spettacolo da nobile tortonese verso la fine del mille e quattrocento in occasione di festeggiarsi le nozze di Galeazzo duca di Milano con Isabella d’Aragona. Ne parla alla distesa lo storico 52 da cui ne verrò raccogliendo quelle circostanze soltanto che possano giovare all’istruzione non meno che al divertimento dei lettori.
[34] In mezzo ad un magnifico salone circondato da una superba
galleria, dov’era distribuito un gran numero di suonatori di diversi strumenti, si
vedeva una gran tavola, ma senza apparecchio di sorta alcuna. Tosto che il duca e la
duchessa comparvero, incominciò la festa aprendo Giasone la scena cogli Argonauti,
i quali s’avanzarono in aria minacciosa al suono d’una sinfonia guerresca portando seco
il famoso vello d’oro, il quale lasciarono in dono sulla tavola dopo avec eseguito un
ballo figurato, che rappresentava l’ammirazione loro alla vista d’una principessa
cotanto gentile, e d’un principe così degno di possederla. Indi venne Mercurio seguito da tre quadriglie di danzatori, e
cantò a solo una spezie di recitativo che conteneva il racconto della sua avventura con
Apolline pastore allora del re Admeto nei campi di Tessaglia, e
l’accortezza usata da lui nel rubbargli il più bello e il più grasso fra tutti i vitelli
dell’armento, cui egli offriva in dono agli sposi. Dopo Mercurio comparve Diana vestita
da cacciatrice e accompagnata dalle sue ninfe, le quali al suono di boscherecchi
strumenti portavano sovra una barella indorata e coperta di frondi un bellissimo cervo.
La Dea nel presentarlo ai sovrani disse cantando essere quel cervo l’incauto Atteone trasformato in simil guisa, ma che dovea nella
sua disavventura reputarsi fortunato abbastanza, poiché dopo aver cessato di vivere
meritava essere offerto a così saggia e così amabile sposa. Appena fu partita Diana, ecco messa in silenzio l’orchestra per dar luogo
ai suoni dolcissimi d’una lira che percossa dalle dita d’Orfeo svegliava ne’ petti degli ascoltanti l’ammirazione e l’allegrezza.
«Io piangeva (disse avanzandosi il
in mezzo all’udienza) sulle cime
dell’Appenino la morte immatura della mia Euridice. La fama m’ha fatto intendere l’avventurosa
unione di due amanti così degni di vivere l’uno per e altro, e il mio cuore,
rammentandosi le sue passate gioie, ha per la prima volta sentito un movimento di
piacere. I miei canti hanno cangiato di natura, come s’è cangiata la disposizione del
mio spirito. Ho diffusa l’allegrezza per tutti gli Esseri. Una truppa d’uccelli si è
fermata ad ascoltarmi; gli ho presi senza la menoma resistenza, e ne fo copia di essi
ad una principessa la più amabile del mondo dacché Euridice non è più fra i viventi.»
Questa cantilena fu
all’improvviso interrotta da suoni romorosi. Atalanta e Teseo comparvero in
iscena scortati da varie truppe di cacciatori che con danze vive e brillanti
rappresentarono una caccia di gran fracasso, la quale si terminò colla uccisione del
famoso cinghiale di Caledonia offerto anch’esso in dono fra
replicati balletti di trionfo al giovine sposo.
[35] La seconda parte della festa conteneva uno spettacolo non meno singolare. Da una banda comparve l’Iride sovra un carro tirato da superbi variopinti pavoni, e seguitata da un coro di ninfe coperte da un trasparente leggierissimo velo che portavano bacili d’argento pieni di siffatti uccelli. Dall’altra si vedeva Ebe, Dea della giovinezza, che in preciose bottiglie recava il nettare ch’ella versa agli dei nell’Olimpo; accompagnavala un coro di pastori d’Arcadia carichi d’ogni sorta di legumi, e Pomona e Vertunno che dispensavano i frutti più saporiti. Perché nulla mancasse a cotanta lautezza, ecco aprirsi il pavimento, e sortir da terra l’ombra d’Apicio, la quale annunziò cantando esser venuta colà dagli abissi affine di condir le vivande e d’illeggiadrir il convito facendo gustar al palato degli sposi le squisitezze inventate da lui, e che acquistar gli fecero in altri tempi la riputazione del più dilicato e più voluttuoso fra i Romani. I donativi terminarono con un gran ballo composto di dei marittimi e di tutti i fiumi della Lombardia, che portavano i pesci più squisiti, eseguendo nell’atto di esibirli ingegnose danze di diverso carattere.
[36] Cominciò allora un’altra spezie di dramma non meno ingegnoso. Orfeo di bel nuovo si fece avanti menando seco Imeneo con una truppa di amorini. Tenevano dietro le Grazie, e in mezzo a loro la fede coniugale, ch’elleno presentarono alla principessa, ed ella le si offrì per servente e compagna indivisa. Nel mentre che la fede coniugale parlava Semiramide, Elena, Medea e Cleopatra vennero fuori per interromperla cantando ciascuna i traviamenti della sua passione, e le seduzioni dell’amore. Sdegnata quella nel sentire che le ree femmine osassero contaminare con infami racconti la purità di quel giorno, dà ordine che vengano scacciate dalla sua presenza, al cui commando i pronti amorini, intrecciando una danza rapida e viva, si slanciano contro di esse, le perseguitano colle fiaccole accese e attaccano fuoco ai nastri ed ai veli, onde aveano fregiate le teste. Invece loro ecco sortire Lucrezia, Artemisia, Giuditta, Porcia, Tomiri, Sulpizia e Penelope portando nelle mani le palme del pudore che aveano meritate nella loro vita. Dopo averle offerte alla principessa, ed eseguito un ballo modesto e nobile, Bacco scortato da vari cori di satiri, sileni ed egipani, diè come pimento con una danza animata e grottesca ad uno dei più magnifici e sorprendenti spettacoli che abbia mai veduto l’Italia.
[37] Oltre la festa descritta pur ora altri abbozzi appariscono dell’opera in musica nel dramma intitolato la Conversion di San Paolo messo, non sò il perché, dal Cavalier tra i componimenti profani53, rappresentato in Roma verso l’anno 1480 d’ordine del Cardinal Riario, e nella farsa che Alfonso Duca di Calabria fece recitare in Castel Capoano nel 1492, opera di . In una serie cronologica de’ drammi rappresentati sui pubblici teatri di Bologna dall’anno 1600 fino al 1737 fatta per opera de’ Soci filopatri si pretende sulla fede d’un manoscritto del celebre , che fin dall’anno 1564 si cantasse nel palazzo della nobilissima Casa Bentivoglio un dramma intitolato l’Incostanza della fortuna. Ma l’autore di questo libricciuolo, il quale, benché comparisca anonimo, fu lavoro d’un certo Avvocato Macchiavelli celebre nella sua patria per le sue letterarie imposture, ci vieta di contar molto sulla sua asserzione. Anche il , inglese, nella sua dissertazione sull’unione della musica e della poesia, citando la storia del teatro italiano di , parla di non so qual dramma fatto rappresentare dal Senato di Venezia fin dall’anno 1574 per divertimento d’Arrigo Terzo re di Francia54.
[38] Che che ne sia di ciò, cotali spettacoli altro non furono appunto che abbozzi, né alcuno di essi ci dà l’idea d’un dramma eroico cantato dal principio fino alla fine. La maggior parte degli eruditi italiani , , , e attribuiscono giustamente l’invenzione a , fiorentino, circa il 1600. Ma contenti di dirlo, niuno ha voluto prendersi la briga di spiegarci partitamente le circostanze, dalle quali però, siccome dipende sovente la formazion delle cose così non si può senza risaperle formar intorno ad esse cose un diritto giudizio. Dal che nascono in seguito le idee storte, le decisioni arbitrarie, l’abbuiamento insomma con cui si giudica generalmente delle arti, e in particolare del dramma in musica: tutto per colpa di coloro che s’addossano l’incombenza di scrivere la storia delle lettere, i quali agguisa de’ commentatori sono per lo più diffusi in ciò che niuno ricerca, e mancanti in quello che altri avrebbe vaghezza d’esaminare con occhio filosofico. Fermiamoci noi non per tanto un poco più di quello, che non è stato fatto finora a maggior lume di questa materia, sperando che le nostre ricerche non siano per riuscire ingrate o inopportune a chi vorrà approfittarsene.
Capitolo quinto §
Difetti della musica italiana verso il fine del Cinquecento, e mezzi presi per migliorarla. Stato della poesia volgare. Firenze inventrice del melodramma. Prima opera seria, e suo giudizio. Comparse. Arie. Cori. Prima opera buffa, e suo carattere.
[1] Il metodo progressivo dell’umano ingegno nelle sue investigazioni, gli avanzamenti fatti nell’armonia e nella poesia, il favore largamente concesso da Leon X alla musica, della quale fu intendentissimo, e lo studio dell’antichità da tre secoli pertinacemente coltivato doveano in un secolo d’attività e d’imitazione sollicitar la fantasia pronta e vivace degl’Italiani a rinovare tutto ciò che aveano fatto gli antichi. E siccome credevasi comunemente ch’eglino avessero le azioni drammatiche intieramente cantato, così s’avvisarono d’imitarli.
[2] romano musico celebre di quel tempo fu il primo a tentar l’impresa nel genere più semplice della pastorale, e due componimenti di questa spezie intitolati la Disperazione di Sileno, e il Satiro lavorati da dama lucchese mise sotto le note fin dall’anno 1590. Ma non essendo fornito abbastanza di quel talento, né di quella cognizione della musica antica, che abbisognavasi per così gran novità, e ignorando l’arte d’accomodar la musicabile parole nel recitativo, altro non fece che trasferir alle sue composizioni gli echi, i rovesci, le ripetizioni, i passaggi lunghissimi, e mille altri pesanti artifizi che allora nella musica madrigalesca italiana fiorivano. E però mal a proposito è stato annoverato fra gl’inventori del melodramma da quegli eruditi che non avendo mai vedute le opere sue, hanno creduto che bastasse a dargli questo titolo l’aver in qualunque maniera messo sotto le note alcune poesie teatrali.
[3] Ma nella carriera delle arti e delle scienze gli errori stessi conducono talvolta alla verità. Il grido che questo musico avea levato fece parlar molto di lui, e del suo tentativo massimamente in Firenze in casa di , cavaliere virtuoso e liberale, di gran cuore, d’ottimo gusto, di gentilezza somma, di molta cognizione in ogni genere di lettere e conseguentemente stimatore giusto, e amante de’ letterati, a’ quali ogni aiuto e favore somministrava: qualità tutte che per la difficoltà di trovarsi riunite in una sola persona rendono egualmente stimabili ma forse più rari i veri mecenati che i veri geni. Da lui perciò concorrevano i primi uomini della città tra quali si distinguevano , padre del Colombo della filosofia, e gentiluomo romano per passar le ore non, come è il costume de’ nostri tempi, in oziose ciccalate, in giuoco rovinoso o in occupazioni più vergognose frutto della trascurata educazione e della pubblica scostumatezza, ma in dilettevoli e virtuose adunanze, ove la coltura dell’ingegno, il non frivolo spirito e l’attica urbanità vedeansi rifiorire insiem col sincero amor delle lettere e delle utili cognizioni. I loro ragionamenti cadevano per lo più sugli abusi introdotti nella musica moderna, e sulla maniera di restituire l’antica sepolta da tanto tempo sotto le rovine dell’Impero Romano. A riuscir bene in così nobile divisamento due furono i mezzi stimati opportuni.
[4] Il primo di rischiarare le tenebre ond’era avvolta la musica antica, la quale da e da fino a que’ tempi non ebbe alcuno scrittore che presa l’avesse ad illustrare; e di toccar principalmente que’ punti ne’ quali consistendo a giudizio degli uomini saggi la sua maravigliosa possanza, potevano trasferiti alla musica moderna contribuir a migliorarla, cioè la dottrina dei generi e dei modi. A cotal impegno s’accinse prima il componendo un libro che diè poscia alla luce intitolato Della musica antica, e moderna con un altro De Modis Musica inedito finora, i quali quantunque abbondino di errori rispetto alla musica antica a motivo che gli autori greci appartenenti a siffatte materie non erano tanto illustrati in allora quanto lo sono al presente dopo le interpretazioni eccellenti del e del , dopo le diligenti ricerche del , d’, e soprattutto dell’Abbate nella sua per ogni riguardo maravigliosa dissertazione intorno alla musica degli Antichi; pure sono molto pregievoli per quella età. Indi corse il medesimo arringo pubblicando il Fronimo cogli altri dialoghi sopra la musica, opere piene di erudite notizie, di riflessioni interessanti, e nonostante gli abbagli a cui dava luogo l’imperfetta idea che allora s’avea del vero sistema musicale, delle migliori che ci rimangono di quel secolo fortunato. Avanti a loro , scrittore svizzero, e , tentarono d’accomodar alla pratica moderna essi generi e modi, ma con evento poco felice, imperocché non compresero che la nostra musica appoggiata su fondamenti troppo diversi non ammettea il severo andamento di quella dei Greci. Ma di ciò a me non s’appartiene il parlare; basterà dire soltanto che la disputa su tali oggetti fra il e scrittore di musica anch’egli, che fioriva verso la metà del secolo decimosesto, divenne così interessante che divise la maggior parte dei letterati italiani, e si sostenne dai due campioni una spezie di pubblica tesi nella cappella del papa alla presenza del Cardinale di Ferrara, e di tutti gli intelligenti nelle scienze armoniche che allora si trovavano in Roma. Il , che difendeva altro non essere stata la musica greca se non se una confusione de’ nostri tre generi cromatico, diatonico ed enarmonico fu riputato aver il torto in paragone del , che sosteneva non comprendere l’antica musica fuorché il solo e schietto diatonico55.
[5] Il secondo mezzo più utile, e che bisognava di maggior talento era quello di simplificar l’armonia, e di promuover l’espressione troppo ingombrata da arzigogoli ed arabeschi ridicoli. A far conoscer meglio lo stato in cui si trovava allora la musica, e per conseguenza le fatiche e i meriti di que’ valentuomini italiani che intrapresero di correggerla, fa di mestieri ripigliar da più alto la trattazione.
[6] La consonanza, cioè quell’intervallo armonico, nel quale i due toni grave ed acuto s’uniscono senza confondersi in maniera che l’orecchio percepisce facilmente la differenza e la conformità, l’unione e la distinzione, fu, al mio avviso, trovata per mero accidente, e introdotta in seguito nella musica a cagion di piacere. La natura donando agli oggetti de’ nostri sensi corporei le qualità necessarie per dilettarli, ha voluto che ogni suono principale venga accompagnato da altri suoni gradevoli all’udito, come ogni raggio sensibile di luce porta seco parecchi altri raggi colorati acconci ad invaghir l’occhio degli esseri animati. L’osservazione replicata di tal fenomeno fece considerar essi suoni come parti costitutive dell’armonia. Questo è quanto può dirsi rispetto al piacere che arreca l’accordo perfetto nelle consonanze, e il voler sapere più oltre è lo stesso che perdersi in un labirinto di metafisica più oscuro che non è il caos dipinto dal nel Paradiso perduto. Ma avendo la natura limitate le consonanze ad un numero scarso, s’avvidero i musici che il ritorno frequente de’ medesimi tuoni quantunque gradevoli potrebbe alla fine degenerar in noia e fastidio per troppa monotonia. Bisognava per tanto o moltiplicar le consonanze, o trovar il modo di renderle con qualche novità più piccanti e più vive. La prima cosa non poteva farsi, perché cangiarsi non potevano gl’inalterabili rapporti messi dalla natura fra i suoni e l’orecchio, e però convenne appigliarsi alla seconda. Questo fu d’introdurre le dissonanze, cioè quell’intervallo ove l’accordo di due suoni si trova così differente e sproporzionato che l’orecchio non può determinare se non difficilmente il rapporto loro, lo che essendo cagione all’anima di qualche pena, a motivo che essa appetisce l’ordine fin nella varietà stessa56, rende cotal rapporto de’ suoni spiacevole. Se v’ha cosa mirabile nelle belle arti questa è il vedere in qual guisa la spiacevolezza medesima delle dissonanze contribuisca all’armonia. Il musico, servendosi di esse come di passaggio d’un accordo all’altro, preparandole prima che arrivino con suoni dilettevoli che cuoprano l’asprezza loro, facendo dopo succedere modulazioni vive e brillanti, che cancellino l’impressione sgradevole, giugne per fino a rendersele, a così dire, amiche, impiegandole in favore delle consonanze, le quali mescolate con quel poco d’amaro arrivano più gradite all’orecchio: nella maniera appunto che i nostri Apici sogliono pizzicar più vivamente il palato coll’uso degli aromati nelle vivande, o per valermi d’un’altra comparazione, come i pittori fanno servire le ombre a dar maggior risalto ai lumi nelle figure.
[7] Finché i musici si fermarono in queste prime nozioni l’uso delle consonanze e delle dissonanze fu di gran giovamento alla musica, quelle per la varietà e vaghezza degli accordi che introdussero, queste pel campo che aprirono al talento dei musici onde ritrovar nuove bellezze, e ravvivar in certe occasioni l’espressione con tratti irregolari ed arditi. Ma ben tosto, come porta il pendio naturale dell’umano ingegno e per l’ignoranza dei tempi, la cosa degenerò in abusi grandissimi. La dolcezza delle consonanze, che dovea riferirsi alia espressione de’ concetti dell’animo, fu presaper se sola senz’alcun riguardo a quel fine. L’orecchio s’avvezzò a poco a poco a compiacersi del puro diletto meccanico de’ suoni senza cercar oggetto più nobile. Le dissonanze, che doveano soltanto usarsi con sobrietà a tempo e luogo, furono prodigalizzate fuor di proposito; si moltiplicarono all’infinito le preparazioni, le risoluzioni, e i passaggi; s’inventarono mille sorta di fioretti e d’ornamenti posticci senz’altra legge che il desiderio strabocchevole di novità, e il capriccio dei musici. Quindi s’introdusse nell’armonia un bello puramente di convenzione, un gusto arbitrario, il quale consisteva nel rivolgere verso ciò ch’era stravagante e artifizioso l’attenzione, che dovea unicamente prestarsi a ciò che è semplice e naturale.
[8] Da che crebbe e si perfezionò il contrappunto formando un’arte di per se, i contrappuntisti presero ferma opinione che le parole e la grazia nel profferirle non entrassero per niente nella natura della musica, la quale secondo loro consisteva nell’armonia complicatissima. Così era indifferente per essi qualunque cosa si mettesse sotto le note: prosa o verso, rozzo o gentile tutto era buono, e si giunse per fino a modular a più voci, e cantare il primo capitolo di San Matteo pieno, come sa ognuno, di nomi ebraici. Un altro argomento, onde si vede ch’essi non curavano punto le parole, si è l’usanza che aveano di lavorar un canto, e sopra esso accomodar poscia l’argomento prosaico o poetico che ne sceglievano, facendo in guisa di quei meschini poeti, i quali dopo aversi formato in testa il piano d’una tragedia vanno attorno cercando nella storia il soggetto cui poterlo applicare. Ciò si vede eziandio dal costume introdotto in que’ tempi assai frequente nelle carte musicali che ne rimangono, di nominar solamente il musico senza far menzion del poeta, come s’egli neppur fosse stato al mondo. Così si legge nei titoli “le Vergini di ”, “il Trionfo dell’Amore dell’” invece di dire “le Vergini del poste in musica dal ”, “il Trionfo d’amore del medesimo modulato dall’”. Dal che ne veniva in conseguenza che i cantori, nel pronunziar le parole, le storpiassero in così fatto modo che né il significato loro si capiva dagli ascoltanti, né quelli si curavano di esprimere la differenza delle vocali in lunghe, e brevi.
[9] Nulla meno crudele era il governo che si faceva con quel sistema armonico della espressione, ovvero sia dell’arte di muovere gli affetti, che scopo è della musica fondamentale e primario. Il soverchio uso delle dissonanze e delle consonanze esigeva necessariamente varietà di voci, e varietà di suoni. Il concento che indi ne risultava era bensì atto a rappresentar le cose romorose, come sarebbe il fracasso d’una battaglia o d’una tempesta, o qualche altro oggetto composto di parti diverse, di che si vedono tuttora esempi bellissimi ne’ contrappuntisti, ma nulla affatto giovava a esprimere i movimenti della passione. Imperocché confondendosi spesso per cotal mezzo i suoni d’indole opposta, come sono il grave e l’acuto, non solo in due parti che cantassero ad una, ma anche in quattro, in sei, e in più insieme; sovente accadeva che la commozione che potea destarsi nell’animo da una serie di suoni, veniva incontanente distrutta da un’altra di contraria natura. Da ciò anche nasceva l’irregolarità ed ineguaglianza di movimento nelle parti e nel tutto; poiché molte volte mentre la parte del basso a mala pena si muoveva per la pigrizia delle sue note, quella del soprano volava colle sue, il tenore e il contralto sen givano passeggiando con lento passo, e mentre alcun di questi volava, sen giva l’altro passeggiando senza farne quasi alcun movimento; la quale contrarietà e disordine quanto nuoca alla espression musicale non occorre altramente ragionare. Aggiungasi ancora il frequente uso delle pause introdotte da loro, per cui molte volte avveniva che mentre l’una di esse parti cantava la metà o il fine d’un versetto scritturale o d’un ritmo poetico, l’altra le prendeva la mano, o restava indietro cantando il principio del medesimo verso, e talvolta anche il fine d’un altro. Per non dir nulla delle tante difficili inezie onde la musica era allor caricata, da paragonarsi agli anagrammi, logogrifi, acrostici, paranomasie, equivoci, e simili sciocchezze ch’erano in voga presso a’ poeti nel secolo scorso: come sarebbe a dire di far cantare una o più parti delle composizioni musicali attorno alle imprese o armi di qualche personaggio, ovvero su per le dita delle mani, o sopra uno specchio: o facendo tacer le note, e cantar le pause, o cantando qualche volta senza linee sulle parole, e indicando il valor delle note con alcune ziffere stravaganti, o inventate a capriccio, o tolte dalle figure simboliche degli egizi, con più altre fantasie chiamate da essi “enimmi del canto” con vocabolo assai bene appropriato, delle quali ho veduto non pochi esempi. Chi volesse sapere più alla distesa a quali strani ghiribizzi si conducessero in que’ tempi i musici vegga il libro XXII della dottissima benché prolissa opera di intitolata Maestro y Melopeo scritta in linguaggio spagnuolo quantunque l’autore fosse bergamasco.
[10] A tale stato avea il gotico contrappunto ridotta la musica, allorché i soppralodati Italiani intrapresero la riforma. Si credette da loro che ad ottener questo fine bisognava lasciar da banda la moltiplicità delle parti, coltivar la monodia, simplificar le modulazioni e studiar con ogni accuratezza le relazioni poste dalla natura fra le parole e il canto, entrò coraggiosamente nell’arringo col suo dialogo sulla musica antica e moderna, ove in persona del citato venne alle prese coi contrappuntisti, esponendo in modo luminoso gli errori loro, e combattendoli. L’invidia, quell’arma velenosa della bassezza e della ignoranza insiem combinate, non tralasciò di metter in opera le solite cabale contro il merito di codesto illustre ristauratore dell’arte, giugnendo fino a tentar di sopprimere l’incominciata edizione, trafugando il manoscritto originale. E ciò che fa la vergogna delle Lettere, e l’indignazione d’un filosofo, ella prese per istrumento il celebre , uomo per altro che godendo d’altissima riputazione e fornito di somma dottrina non avea bisogno di scendere a così vili maneggi. Ma sovente le passioni più basse rodono con acuto morso gl’ingegni più elevati, come i vermi al dire di , consumavano le membra di Filottete uno de’ più forti guerrieri dell’esercito greco.
[11] Nè contento di questo il tanto vi si affaticò coll’ingegno, che trovò nuova maniera di
cantar melodìe ad una voce sola, poiché sebbene avanti a lui scusasse di farle
coll’accompagnamento degli strumenti, esse altro non erano che volgari cantilene
intuonate da gente idiota senz’arte o grazia: nel qual modo pose sotto le note quello
squarcio sublime e patetico di , ove parla del
Conte Ugolino, che incomincia «La bocca
sollevò dal fiero pasto»
, e in seguito le lamentazioni di Geremia, che grande applauso trovarono allora presso
agl’intendenti.
[12] La musica madrigralesca, ch’era a un dipresso carica de’ medesimi raffinamenti, ricevette allo stesso tempo nuovo lustro in Italia da , che la spogliò dell’antica ruvidezza e la fece camminar in maniera più ariosa e leggiadra, da romano, da maestro di , da musico celebre nella corte di Ferrara, dall’, da , da , da , da musico d’Alfonso II di Ferrara, dal , dal , da sanese, e da altri valenti compositori, ma sopra tutti dal uno de’ maggiori musici, che avresse avuti l’Italia, se all’ingegno mirabile concessogli dalla natura eguale studio accoppiato né tvesse. Gli scrittori di quel tempo ci fanno sapere, che i madrigali suoi erano ammirati dai maestri e cantati da tutte le belle: circostanza che dovea assicurar loro una rapida e universale celebrità. La musica strumentale venne anch’essa perfezionandosi di mano in mano se non in quanto alla fabbrica più esatta di essi almeno nella maggior destrezza nel suonarli. La storia ci ha consevati con lode i nomi di inventore del cembalo onnicordo, di D. ritrovatore d’un altro strumento chiamato “archicembalo”, del inventore della tiorba, di , del , del , del , del , di parecchi altri suonatori.
[13] Da tali e tanti stimoli incitato uno de’ mentovati nella letteraria adunanza, prese, siccome era di vivo e pronto ingegno fornito, a perfezionare la maniera inventata dal , e molte belle cose introdusse del suo nella musica, che contribuirono non poco a migliorarla. Uno de’ principali mezzi fu quello d’applicar l’armonia a parole cantabili, cioè a poesie appassionate ed affettuose.
[14] Avvegnaché l’Italia sortisse allora del secolo più glorioso della sua letteratura, e che tanti scrittori bravissimi avessero di già arricchita, e fissatta la più dolce e la più bella delle lingue europee, nullameno per le differenze che corrono fra l’armonia musicale e la poetica, delle quali parlai nel capitolo secondo, la poesia non avea per anco aperti alla musica fonti copiosi d’espressione. I poeti, scrivendo unicamente per esser letti non pensarono al canto già mai. Il , genio rozzo e sublime, atteggiator robusto ma irregolare, nelle bellezze e nei diffetti egualmente intrattabile, offriva ai musici uno stile somigliante alle miniere del Brasile, ove fra la terra e la scoria veggonsi a tratto a tratto strisciare alcune vette d’oro finissimo. , il de’ poeti, fu nel parnaso italiano inventore d’un nuovo genere, ch’egli stesso esaurì. La sua lira di tempra affatto originale avea bisogno delle dita del proprio artefice per vibrar que’ suoni celesti. Però i musici, quantunque gareggiassero insieme per illustrarlo, non poterono mai, affastellati com’erano sotto l’imbarazzo d’un sistema complicatissimo, afferrar la dilicatezza di que’ sentimenti semplici insieme e sublimi. Nell’osservar sulle carte musicali i sospiri dolcissimi del rivestiti di note dal o dal ti par proprio di vedere il satiro introdotto dal nell’Aminta, il quale violar vorrebbe con ispida mano le ignude bellezze di Silvia. Maggiormente si scostarono da quel sentiero i freddi rimatori del Cinquecento. , che prendendo a imitar il cantore di Laura altro non ritrasse da lui che la spoglia; celebre per robustezza de’ concetti, e per unità di pensiero benché sovente privo di colorito, e qualche volta prosaico; ricco nella frase, lavorato nello stile, abbindolato ne’ periodi, autore più di parole che di cose; più vicino ai Latini nel suo poema che scrittor felice nella propria lingua; , , , e mille altri versificatori stitici e insipidi benché puri e regolari non poteano somministrar gran materia alla musica. L’ e il , ancorché avessero in qualche luogo fatto maestrevolmente parlare la passione, erano, ciò nonostante, nel medesimo caso per l’indole de’ poemi loro nella maggior parte narrativi, per la lunghezza dei canti, e pel ritorno troppo frequente e simmetrico delle rime nelle ottave. I cori che nelle tragedie italiane erano i soli destinati al canto, non giovavano molto ai progressi dell’arte, e perché comprendevano per lo più lunghe riflessioni morali incapaci di bella modulazione, e perché cantandosi a molte voci, erano più idonei a far risaltare la pienezza e varietà degli accordi che la soavità della melodia. Restavano i soli madrigali, che servivano allora di materia alle musiche di camera, e molti e bellissimi furono a questo fine composti dal , dal , dal , e dallo principalmente. Ma la brevità ch’esigevano cotai componimenti, e la chiusa spiritosa che incominciò a introdursi circa que’ tempi, onde simili divennero agli epigrammi di , non permisero ai poeti trattar argomenti fecondi di passione.
[15] Perciò il sollecitò per ogni dove gli autori a lavorar a bella posta poesie pel canto, tra i quali D. scrisse a sua richiesta i Pietosi affetti, e il compose l’intermezzo mentovato di sopra. né tralasciò di concorrer anch’egli poetando al medesimo fine, di che può far testimonianza la seguente canzonetta, ch’io qui ho voluto trascrivere dalle carte musicali dove si trova, a fine di render più noto a’ suoi nazionali codesto valentuomo ignorato in oggi dai poeti e dai musici, ma che merita un luogo distinto fra gli uni e fra gli altri:
«Udite, udite, amanti,Udite, o fere erranti,O Cielo! O Stelle!O Luna! O Sole!Donne e Donzelle!Le mie parole:E se a ragion mi doglioPiangete al mio cordoglio.La bella Donna miaGià sì cortese e pia,Non so perché,So ben che maiNon volge a meQuei dolci reti:Ed io pur vivo e spiro!Sentite che martiro.Care, amorose Stelle,Voi pur cortesi e belleCon dolci sguardiTenesti in vitaDa mille dardiL’alma ferita.Ed or più non vi miro!Sentite che martiro.Ohimè! Che tristo e soloSol’io piango il mio duolo,L’alma lo senteSentilo il cuore,E lo consenteL’ingiusto amore:Amor sel vede e tace,Ed ha pur arco e face.»
[16] Soprattutto egli attesta nella prefazione alle sue Nuove musiche che più vantaggio ne trasse dal commercio e suggerimenti degli uomini letterati che da trentanni spesi nelle scuole musicali, e nell’arte del contrappunto, il quale secondo lui poco o nulla giova a perfezionare la musica57.
[18] Dopo la dipartenza per Roma del , ove poi divenne maestro di Camera a’ servigi del papa Clemente Ottavo, la letteraria adunanza si trasferì alla casa di altro gentiluomo fiorentino, non meno fautore delle belle arti, né meno intelligente nella musica massimamente teorica. Ha l’Italia da lui, oltre qualche canzonetta messa sotto le note, un discorso della musica degli antichi e del cantar bene indirizzato al . Di esso erano amicissimi gentiluomo fiorentino e bravo poeta, avvegnacchè poco egli sia noto in Italia a motivo di aver la maggior parte della sua vita menato in Francia, e musico valentissimo, i quali d’accordo col e col tanto studiarono sulla maniera d’accomodar bene la musica alle parole che finalmente trovarono, o credettero d’aver trovato, il vero antico recitativo de’ Greci, ch’era stato da lungo tempo il principale scopo delle loro ricerche. Per veder come riusciva in pratica il nuovo ritrovato fu dagli altri spinto a comporre una qualche poesia drammatica, lo che egli fece colla Dafne, favola boscherecchia che si rappresentò in casa del l’anno 1594, e fu messa sotto le note dal e dal sotto la direzione di esso , il quale comecché non avesse studiata la musica, era nondimeno dotato d’orecchio finissimo,e d’acuto discernimento, che gli aveano conciliato la stima e il rispetto de’ musici.
[19] Molto maggior fortuna sortì in appresso un altra sua pastorale intitolata L’Euridice Tragedia per musica, la quale fu con più accuratezza modulata nella maggior parte dal fuori d’alcune arie bellissime che furono composte da , e quelle del personaggio d’Euridice e dei cori, nelle quali ebbe mano il . Tutte le circostanze concorsero a render quello spettacolo uno de’ più compiti che d’allora in poi siano stati fatti in Italia. La novità dell’invenzione, che gli animi de’ fiorentini di forte maraviglia comprese; la fama dei compositori, dell’adunanza tenuta a ragione il fiore della toscana letteratura; l’occasione in cui fu rappresentata, cioè nello sposalizio di Maria Medici col re di Francia Arrigo Quarto; la scelta udienza, di cui fu decorata non meno di tanti principi e signori nazionali e francesi oltre la presenza del Gran Duca e del Legato del papa, che de’ più virtuosi uomini d’Italia chiamati a bella posta dal Sovrano in Firenze, tra quali assistettero , , , , , e il tutti o pratici eccellenti, o peritissimi nell’arte; l’esattezza nella esecuzione, essendo da bravissimi e coltissimi personaggi rappresentata sotto la dipendenza del poeta, ch’era l’anima e il regolatore dello spettacolo; finalmente il merito poetico del dramma il quale benché non vada esente d’ogni difetto è tuttavia e per naturalezza musicale, e per istile patetico il migliore scritto in Italia fino a’ tempi del . Alcuni squarci di esso posti sotto gli occhi dei lettere giustificheranno la mia asserzione. Sentasi la narrazione, che fa Dafne della morte d’Euridice.
«Orf. Ninfa, deh! Sii contentaRidir perché t’affanni,Che tacciuto martir troppo tormenta.Daf. Com’esser può giammaiCh’io narri e ch’io riveliSì miserabil caso? O fato! O Cielo!Deh! Lasciami tacer, troppo il saprai.Coro. Dì pur: sovente del timor l’affannoÈ dell’istesso mal più grave assai.Daf. Troppo più del timor fia grave il danno.Orf. Ah! Non sospender più l’alma dubbiosa.Daf. Per quel vago boschetto,Ove rigando i fioriLento trascorre il fonte degli allori,Prendea dolce dilettoCon le compagne sue la bella Sposa.Chi violetta, o rosaPer far ghirlanda al crineTogliea dal prato, e dall’acute spine,E qual, posando il fiancoSulla fiorita sponda,Dolce cantava al mormorar dell’onda.Ma la bella EuridiceMovea, danzando, il piè sul verde pratoQuando (ria sorte acerba!)Angue crudo e spietato,Che celato giacea tra fiori, e l’erba,Punsele il piè con sì maligno dente,Ch’impallidì repente,Come raggio di Sol, che nube adombri.E dal profondo cuoreCon un sospir mortale,Sì spaventoso ohimè! Sospinse fuore,Che quasi avesse l’aleGiunse ogni Nifa al doloroso suono;Ed ella in abbandonoTutta lasciossi allor nelle altrui braccia.Un sudor via più freddo assai che giaccioSpargea il bel volto, e le dorate chiome.Indi s’udio il tuo nomeFra le labbra suonar fredde e tremanti:E volti gli occhi al CieloScolorito il bel viso, e i bei sembiantiRestò tanta bellezza immobil gelo.»
[20] Non è men bella la scena dove Orfeo prega Plutone che gli restituisca la perduta sposa, della quale per esser troppo lunga non riferirò se non le stanze che canta Orfeo prima d’arrivar innanzi al re dell’Inferno:
«Funeste piaggie, ombrosi, orridi campi,Che di stelle o di SoleNon vedeste già mai scintille o lampi,Rimbombate dolentiAl suon delle angosciose mie parole,Mentre con mesti accentiIl perduto mio ben con voi sospir:E voi, deh per pietà del mio martiro,Che nel misero cor dimora eterno,Rimbombate al mio pianto, ombre d’Inferno.Ohimè! Che sull’AuroraGiunse all’occaso il Sol degli occhi miei,Misero! E sù quell’ora,Che scaldarmi a bei raggi mi credei,Morte spense il bel lume, e freddo e soloRestai fra pianto e duolo,Com’angue suole in fredda piaggia il verno.Rimbombate al mio pianto, ombre d’Inferno.E tu mentre al Ciel piacqueLuce di questi lumiFatti al tuo dipartir fontan’e fiumi,Che fai per entro a’ tenebrosi orrori?Forse t’affliggi e piagniL’acerbo fato, e gl’infelici amori?Deh! Se scintilla ancoraTi scalda il sen di que’ sì cari ardoriSenti, mia vita, sentiQuai pianti e quai lamentiVersa il tuo caro Orfeo dal cor interno.Rimbombate al mio pianto, ombre d’Inferno.»
[21] Nonostante, il
non lasciò d’urtare nello scoglio incontro al quale urtano sovente gli inventori in
cotai generi, la mescolanza, cioè, dell’antica imitazione colle moderne usanze. La voga
in cui erano allora le pastorali per la celebrità, che aveano acquistata il
Pastor fido, e l’Aminta indusse il a sceglier per suggetto della sua invenzione una
favola boscherecchia, onde ne trasse talvolta lo stile lezioso e soverchiamente fiorito
col quale i poeti di quel tempo erano soliti di far parlare i pastori. Così non è
maraviglia se s’ode Tirsi pregar l’Amore
«che di dolcezza un nembo trabocchi in grembo»
, e che «svegli un
riso di Paradiso»
, se si sente Arcetro
«cercar il loco, ove ghiaccio divenne il suo bel foco»
, e se veggonsi
«arder la terra, arder gli eterei giri a’ gioiosi sospiri dell’uno e l’altro
innamorato core»
, con altri modi di dire propri d’un manierato italiano del
1600, ma in nulla conformi all’antica semplicità de’ Traci pastori a’ tempi d’Orfeo. Dall’uso ancora che allor si faceva della musica
madrigalesca, e dal non aver per anco la lingua italiana preso l’andamento rapido e
breve ch’esige il recitativo, avviene che l’Euridice debba piuttosto
chiamarsi una filza di madrigali drammatici che una tragedia,
come è piaciuto al suo autore d’intitolarla, e nella stessa guisa dalla troppo religiosa
e mal intesa imitazion degli antichi è venuto che dovendosi dividere il dramma in cinque
atti, né somministrando materia per essi il troppo semplice argomento, l’autore non ha
potuto schivar il languore di molte scene e dell’ultimo atto, che riesce del tutto
inutile. Il cangiar ch’ei fa la scena; quantunque alla natura del dramma non si disdica
per le ragioni da me addotte nel capitolo primo di questo libro, è tuttavia troppo
violente nell’Euridice, poiché ad un tratto si passa dai campi amenissimi
nell’Inferno senza che venga preparato, qualmente si dovrebbe, il passaggio. La qual
licenza scusabile nel Rinuccini per esser il primo, e perché forse il suo argomento noi
comportava altrimenti, pervenne in seguito fino all’eccesso negli altri, come dall’esito
lieto che diè alla sua favola non per altro motivo se non perché «ciò gli parvi
convenire in tempo di tanta allegrezza»
58
trassero innavvedutamente i suoi successori una legge che lieto esser dovesse il fine di
tutti i drammi.
[22] Negli anni seguenti si rappresentò in Firenze parimenti un altro dramma del medesimo intitolato l’Arianna modulato da maestro in seguito della Repubblica di Venezia; anzi il soliloquio ove Arianna si lamenta dell’abbandono di Giasone, passò lungo tempo fra i musici per capo d’opera dell’arte in quel genere, e si rammentava da loro non altrimenti che si rammenti in oggi la Serva Padrona posta in musica dal , o il monologo della Didone del modulato dal . Ciò si ha da nel suo trattato sulla musica scenica59, e dalla dissertazione che segue agli scherzi musicali di esso raccolti da Giulio Cesare suo fratello, e stampati in Venezia da Ricciardo Amadino. né inferiore rimase il poeta in quella scena bellissima, la quale incomincia:
«O Teseo, o Teseo mio,Se tu sapessi, oh Dio!Se tu sapessi ohimè! Come s’affannaLa povera Arianna;Forse, forse pentitoRivolgeresti ancor la prora al lito.»
ma ch’io non trascrivo intieramente per esser troppo lunga, e perché dagli squarci di sopra recati può il merito del Rinuccini abbastanza conoscersi.
[23] L’apparato poi di sceniche mutazioni con cui si rappresentarono cotali drammi fu sorprendente. Campagne verdeggianti, amenissimi giardini, vaste vedute in lontananza di mari gonfi di flutti, procelle, tuoni e folgori che precipitavano dal cielo di nereggianti nubi artifiziosamente ingombrato, i soggiorni dilettosi de’ campi Elisi, gli orrori del Tartaro accresciuti dagli spaventevoli lamenti degl’infelici tormentati, boschi ed alberi nati all’improvviso, i tronchi de’ quali aprendosi i saltellanti Satiri partorivano, e Fauni, e Napee, e Sileni in nuove e disusate foggie vestiti, fiumi che con limpidissime acque scorrendo, lasciavano vedere le Ninfe che per entro guizzavano, insomma quanto v’ha di più bello nel mondo fisico, quante vaghezze somministra la favola tutto fu per ornarle leggiadramente inventato60.
[24] Per soddisfar appieno la curiosità del lettore aggiungiamo qualche cosa intorno alla musica, i progressi della quale debbono osservarsi unitamente a quelli della poesia, ove si ragiona del melodramma. La variazione dei tempi, la diversità de’ gusti, che tanto influisce sulle cose musicali, e forse ancora l’eccessivo lusso della musica presente farebbero in oggi comparir quella assai povera e rozza. Infatti scarseggia di note, il senso non vi si comprende abbastanza, abbonda poco di varietà, e il tempo non è a sufficienza distinto a motivo, che i compositori erano soliti a non udir altra musica che la ecclesiastica e la madrigalesca, nelle quali spiccavano simili difetti. In contraccambio regna in quelle composizioni una certa semplicità preferibile a molti riguardi alla sfoggiata pompa della nostra. La poesia e la lingua vi conservano i loro diritti; a differenza dell’odierna, ove le parole vengono così miseramente sformate. Soprattutto la strada battuta da que’ maestri per esprimer bene il recitativo è la sola che dovrebbero battere i compositori d’ogni secolo. Erano filosofi, e da filosofi ragionavano. Lo studio delle cose antiche fece loro conoscere che quella sorte di voce, che da’ Greci e Latini al cantar fu assegnata, da essi appellata “diastematica” quasi trattenuta e sospesa, potesse in parte affrettarsi, e prender temperato corsa tra i movimenti del canto sospesi e lenti, e quelli della favella ordinaria più spediti e veloci, avvicinandosi il più che si potesse all’altra sorte di voce propria del ragionar famigliare, che gli antichi “continuata” appellavano. Le riflessioni sulla propria lingua fecer loro avvertire, che nel parlar comune alcune voci s’intuonano in guisa che vi si può far armonia, o ciò che è lo stesso, distinguerle per intervalli armonici, alcune non s’intuonano punto, per le quali leggiermente si scorre finché si giugne ad altre capaci d’intonazione o d’armonico movimento. Osservarono infine que’ modi e quegli accenti particolari che gli uomini nel rallegrarsi, nel dolersi, nell’adirarsi, e nelle altre passioni adoprano comunemente, a misura de’ quali conobbero che dovea farsi movere il basso or più or meno secondo che richiedeva la lor lentezza o velocità, e tenersi fermo fra le false e buone proporzioni, finché passando per varie note la voce di chi ragiona, arrivasse a quel punto dove il parlar ordinario intuonandosi apre la via a nuovo concento. Così si spiega il nella prefazione, e così almeno in gran parte (giacché non è possibile che nel principio della scoperta alla perfezion dell’arte giugnessero) fecero quei valenti compositori.
[25] Maestri e musici del nostro tempo, che col fasto proprio della ignoranza vilipendete le gloriose fatiche degli altri secoli, ditemi se alcun si trova fra voi che sappia tanto avanti nei principi filosofici dell’arte propria quanto sapevano quegli uomini del secolo decimosettimo, che voi onorate coll’urbano titolo di seguaci del rancidume.
[26] Parte principalissima della musica drammatica è l’aria, che
non si dee sotto silenzio trapassare. Il cavalier pretende che verso la metà del secolo scorso cominciassero
«a inserirsi le arie nei melodrammi poiché fin allora tutto fu in essa
recitativo, e la musica fu tutta in istile recitativo composta. L’introduzione delle
arie è attribuita al , il quale nel suo
Giasone, melodramma pubblicato nel 1640, cominciò a interrompere il
grave recitativo con quelle anacreontiche stanze»
61. La qual notizia
comunicò poscia al cavalier 62 e al 63. scrittori così valenti si sono tutti ingannati per non aver
voluto prendersi la briga di esaminare i fonti. Non è vero che tutto fosse recitativo
nel melodramma italiano avanti al . Non è
vero ch’ei fosse il primo a inserirvi le anacreontiche stanze. L’uno e l’altro si trova
fatto fin dall’origine dell’opera. Alla pagina II della musica del alla citata Euridice si vede che
Tirsi canta a solo i seguenti versi:
«Nel puro ardor della più bella stellaAurea facella di bel fuoco accendi,E qui discendi sull’aurate piumeGiocondo nume, e di celeste fiammaL’anime infiamma.Lieto Imeneo d’alta dolcezza un nemboTrabocchi in grembo ai fortunati amanti,E tra i bei canti di soavi ardoriSveglia nei cori una dolc’aura, un risoDi Paradiso.»
i quali sono un’aria perfetta non meno in musica che in poesia. Le ragioni sono perché vi precede la sinfonia, perché il basso seguita tutte quante le note del cantore, perché si accompagna con altri stromenti, perché si fa il ritornello alla seconda parte, perché il metro è diverso da quello del recitativo, perché manifestamente è un canto, per tutte le condizioni insomma che le arie a dì nostri distinguono. né si veggono soltanto ne’ drammi del . Potrei citare molte degli altri autori, ma basti per ultima pruova una assai leggiadra tratta dalla Flora d’, stampata nel 1628 cioè anni vent’uno prima del Giasone.
«I’era pargolettaQuand’altri mi narrò,Che Amor è viperetta,Che morde quanto può.Quel dir sì m’ingannò,Che Amor gran tempo odiai,Temendo affanni e guai.Ma poiché un giorno io vidiLirindo ed egli me,Ben chiaro allor m’avvidi,Che serpe Amor non é.»
[27] Più grossolano e meno scusabile è lo sbaglio del , il quale scrivendo nel principio del nostro secolo si spiega in questi termini: «Intanto dobbiamo avvertire che nei drammi per lo passato non hanno mai avuto luogo i cori, invece de’ quali sono stati inventati intermedi d’ogni maniera»64. Non avea egli letto i cinque cori che chiudono i cinque atti dell’Euridice? Non avea vedute la Dafne, l’Arianna, il Rapimento di Cefalo, la Medusa, la Flora, la Sant’Ursola, e mille altre? Ignorava egli, che niuno de’ celebri melodrammi italiani fu senza cori fin quasi alla metà del 1600 e che molti gli ebbero ancora nel rimanente del secolo? Cotanta ignoranza si rende pressoché incredibile in uno de’ primi storici della italiana poesia.
[28] Facendo adunque la distribuzione di laude che a ciascun s’appartiene nell’invenzione dell’opera seria, si vede che dee la città di Firenze il vanto riportarne principalmente, che e furono i mecenati, e i precursori nella parte teorica, e nell’arte d’intavolar le melodie , che da lontano adittò agli altri la strada, e nella esecuzione, ma che deesi principalmente l’elogio al , il quale coll’armonia e bellezza de’ suoi versi mirabilmente adattati alle mire dei compagni, e più colla sua autorità, collo studio degli antichi e colla dipendenza in cui teneva gli altri, si fece il ritrovatore d’un nuovo genere che tanto lustro ha recato alla poesia, alla musica e alla sua nazione.
[29] L’opera buffa incominciò parimenti circa il fine del Cinquecento. La prima di cui ci sia pervenuta la notizia sortì alla luce in Vinegia l’anno 1597 col titolo: Anfiparnaso Commedia dedicata a Don Alessandro d’Este. S’ignora dove e in qual anno si recitasse. L’autore fu un modenese che fece la musica e la poesia, chiamato , il quale non si dee confondere con , musico e maestro di Cappella nel medesimo secolo. Egli nella dedica si vanta d’essere stato il primo a metter in musica le poesie drammatiche, e questo vanto vien replicato dall’autore d’una iscrizione latina fatta pel suo sepolcro, che si conserva in Modena, e che vien rapportata dal nella sua Perfetta poesia, ma il lettore dopo il narrato fin qui può giudicare se ciò si dica a ragione. L’Anfiparnaso venne poi in tal dimenticanza presso agl’Italiani che , comecché in tal genere d’erudizione fosse versatissimo, confessa in una sua lettera al d’ignorarne persin l’esistenza. né il ebbe altra notizia che quella che ricavò dalla mentovata iscrizione. Il nel Discorso sul teatro italiano, e il mostrano bensì d’averla veduta. A me pure è venuto fatto d’averla alle mani fra le carte musicali, ove sempre rimase. né la musica né la poesia meriterebbono che se ne facesse menzione, se la circostanza d’esser la prima nel suo genere non m’obbligasse a darle qualche luogo in questa storia. Pantalone, Arlecchino, Brighella, e il capitano Cardone spagnuolo sono fra gli altri i leggiadri personaggi. Si parla in castigliano, in bolognese, in italiano, e persino in ebraico: lascio pensare qual armonico guazzabuglio risultar ne debba da tutto ciò. Sentasi nell’atto secondo il gentil dialogo fra Isabella e il capitano spagnuolo, il quale per antica benivolenza della nazione italiana verso di noi debbe esser sempre posto in ridicolo sul teatro:
Cap. No me hagais mas de estas burlas,Porque poco ha faltado,Que no soy de dolor muerto.Isab. S’a gli arcabugi, et alle collubrineSet’uso a far gran core,Perché temete poi schermi d’amore?Cap. Perché todo vince amor.Isab. Amor non sò, ma voi ben mi vincesti,Quando vi fei SignoreDi questa vita, di questo core.Cap. Decidme; mi Segnora,De quien son estas tetiglias?Isab. Del capitan Cardon.Cap. Y los oscios, y las orescias?Isab. Del capitan Cardon.Cap. Y el rostro, y las narices?Isab. Del capitan Cardon.Cap. La fruente, y la cabezza?Isab. Del capitan Cardon.Cap. Y la capegliadura?Isab. Del capitan Cardon.Cap. Los dientes, y los labios?Isab. Del capitan Cardon.Cap. La vida, y el corazon?Isab. Del capitan Cardon.Cap. O muy contiento!O muy tambien amado,Y de mi dama muy avventurado!»
Benché Isabella si mostri innamorata del capitano, nondimeno il beffeggia dopo che egli è partito, nel che le fanciulle del Cinquecento non differiscono punto da quelle de’ nostri tempi. Se un poeta è rimasto invaghito della bellezza di codesta scena, non resterà meno meravigliato un musico della singolar armonia che si sente in quest’altra.
[30] Francatrippa, servo, vuol porre un pegno in mano degli Ebrei. Egli picchia alla porta del ghetto, mentre quegli recitano le loro orazioni.
«Fran. Tich, tach, toch,Tich, tach, toch.O Hebreorum gentibus!Sù prest: avrì sù: prest:Da hom da ben, che tragh zo l’us.Ebrei. Ahi Baruchai,Badanai, Merdochai,An biluchan, chet milotran:La Barucabà,Fran. A no farò vergot, maide negot.Ch’i fa la sinagoga?O! Che il diavolo v’affoga.Tich, tach, tich, toc, tic, tac, tic, toc.Ebrei. Oth zorochot, Astach mustach,Iochut, zorochot,Calamala Balachot.Fran. U uhi! O, ohi:Omessir Aron.Ebrei. Chi ha pulset a sto porton?Fran. Son mi, son mi, messir Aron.Ebrei. Che cheusa volit? Che cheusa volit?Franc. A voraff’impegnà sto Brandamant.Ebrei. O Samuel, Samuel!Venit a bess, venit a bess;Adonai; che le è lo Goi,Che è venut con lo parachem.Altri Ebrei. L’è Sabbà, che non podem.»
[31] Dicendo che la musica non si disconviene a così fatta poesia, ho renduto la dovuta giustizia all’una e all’altra.
Capitolo sesto §
Riflessioni sul meraviglioso. Origine storica, e propagazione di esso in Europa. Cause del suo accoppiamento colla musica, e la poesia nel melodramma.
[1] Tra i fenomeni letterari che si presentano avanti a chi vuol osservare le rivoluzioni del teatro italiano non è il minore a mio avviso quel maraviglioso strabocchevole, che accoppiandosi col melodramma fin dalla sua origine, lo seguitò passo a passo per tutto il secolo scorso e parte ancor del presente, non solo in Italia ma nelle nazioni oltramontane ov’esso fu trapiantato. Questo non poteva a meno di non dar nell’occhio agli scrittori italiani: così alcun non v’ha tra coloro che la storia delle lettere hanno preso a scrivere, che non parli delle macchine, delle decorazioni, della mitologia e delle favole, come del carattere principale del melodramma in quel secolo. Ma onde sia venuta in mente a’ poeti siffatta idea; per qual istrano cangiamento di gusto una nazione sì colta sene sia compiacciuta a tal segno, che abbia nel teatro antiposta la mostruosità alla decenza, il delirio alla verità, l’esclusione d’ogni buon senso alle regole inalterabili di critica lasciateci dagli antichi; se il male sia venuto dalla poesia ovver dalla musica, o se tutto debba ripetersi dalle circostanze de’ tempi, ecco ciò che niun autore italiano ha finora preso ad investigare, e quello che mi veggo in necessità di dover eseguire a continuazione del metodo intrapreso, e a maggior illustrazione del mio argomento.
[2] Sebbene sia fuor d’ogni dubbio che fra le potenze interne dell’uomo alcuna vene ha portata naturalmente verso il vero, e che in esso unicamente riposi non potendo abbracciar il falso quando è conosciuto per tale; è fuor di dubbio parimenti, che fra esse potenze medesime alcun’altra si ritrova, la quale senza poter fermarsi tra i cancelli del vero, si divaga pei mondi ideali da lei creati, e si compiace de’ suoi errori più forse di quello che farebbe della verità stessa. La prima di esse facoltà è l’intelletto, la seconda la immaginazione, e perciò in quest’ultima è riposta la sede del maraviglioso. La certezza di tal effetto può facilmente conoscersi dalla esperienza. Haccene di quelle cose, le quali avvegnaché assurde e incredibili paiano all’intelletto, nondimeno dilettano grandemente la potenza immaginativa. Leggete in presenza d’un fanciullo, e anche d’un ragazzo di dodici o quindici anni il più bello squarcio della storia di o di , fategli capire una dimostrazione di geometria, o mettetegli avanti gli occhi la più leggiadra esperienza di fisica, egli non istarà molto che s’annoierà, e palesaravvi colla sua inattenzione la noia. Ma se invece di tutto ciò prendete a narrargli le favole d’, o gli strani e incredibili avvenimenti del moro Aladino, della grotta incantata di Merlino, del corno e dell’ippogrifo d’Astolfo, della rete di Caligorante o tali altre cose, che per folle e menzogne si tengono da tutti, e da lui medesimamente; il ragazzo tralascerà con piacere i suoi fanciulleschi trastulli solo per ascoltarvi. Interrogate un amante, addimandate ad un poeta, perché raminghi e soli inoltrandosi fra le più cupe foreste, e fra deserti inerpicati dirupi sfuggano l’uman commercio mesti in apparenza e pensosi: e’ vi risponderanno che ciò si fa da loro per poter liberamente badare agli amabili deliri della propria immaginazione, a quei soavi e cari prestigi, a quelle illusioni dolcissime, che gli ricompensano dalle torture della verità trista spesse fiate e dolorosa. Se si consulta la storia, vedrasi, che le bizzarre invenzioni della poesia hanno dall’India fino alla Spagna, da fino al eccitato universale diletto, e riscossa l’ammirazione de’ popoli. Lo stesso avvenne per molti secoli de’ romanzi e delle avventure degli erranti cavalieri, i quali libri, quantunque pieni fossero di menzogne assurde e ridicole, pur di sollazzo e di piacevole intertenimento servirono alla più colta e più gentil parte d’Europa a preferenza degli storici e filosofici. Le Fate, le Maghe, i Silfi, gl’incantesimi, tutti insomma gli aborti dell’umano delirio, piacquero più assai alla immaginazione attiva e vivace che non le severe dimostrazioni cavate da quelle facoltà che hanno per oggetto la ricerca del vero. E la natura per così dire, in tumulto, e la violazione delle leggi dell’universo fatte da immaginarie intelligenze le furono più a grado che non il costante e regolar tenore delle cose create.
[3] Posto il fatto fuor d’ogni dubbio, il filosofo ne ricercherà le cagioni. Non è proprio di questo luogo, e nemmeno del mio debole ingegno il diffondermi circa un argomento, che richiederebbe più tempo, e penna più maestrevole. A dir però qualche cosa non mi pare ch’errar potesse di molto chi le riducesse a’ capi seguenti.
[4] L’ignoranza delle leggi fisiche della natura dovette in primo luogo condur l’uomo a dilettarsi del maraviglioso. Vedea egli sgorgare da limpida sorgente, e scorrere mormorando fra le verdi rive un ruscello; vedeva germogliare anno per anno le piante, rifiorir gli alberi, e coprirsi di fronda; vedea la notte al giorno, e il giorno alla notte vicendevolmente succedersi, e il sole per gl’interminabili spazi del cielo con invariabil corso aggirarsi finché si nascondeva agli occhi suoi sotto l’orizzonte. E non potendo rinvenire per mancanza di quella intellettuale attività che fa vedere la concatenazione delle cause coi loro effetti, le occulte fisiche forze, che facevano scorrere quel fiume, vegetar quella piantale mover quel sole, trovarono più facile inventar certi agenti invisibili, a’ quali la cura commettessero di produrre simili effetti. Quindi s’immaginarono un Dio, il quale giacendo in umida grotta, e incoronato d’alga, e di giunchi da un’urna di cristallo versasse le acque, e una Napea ascosa dentro alla scorza degli alberi, che il nutritivo umor sospingendo verso l’estremità, fosse la cagion prossima della loro verzura e freschezza, e parimenti un Apollo si finsero, il quale, avendo la fronte cinta de’ raggi, guidasse colle briglie d’oro in mano il carro luminoso del giorno. Quindi, dando anima e corpo a tutti i fisici principi dell’universo, popolarono di numi gli elementi, il cielo, e l’inferno persino, ampio argomento di superstizione a’ creduli mortali, e larga messe a’ poeti, che s’approfittarono, affine di soggiogare l’immaginazione de’ popoli.
[5] Questa avvivata dalle due passioni più naturali all’uomo, il timore cioè e la speranza, giunse perfino a credere le sue finzioni medesime e a compiacersene. Le credette, perché un sistema, che spiegava materialmente i fenomeni della natura, era più adattato a quegli uomini grossolani, su i quali aveano i sensi cotanto imperio. Sen compiacque perché l’amor proprio, quel mobile supremo dell’uman cuore, vi trovava per entro il suo conto. Siccome supponevasi che quella folla di deità si mischiasse negli affari degli uomini, e ch’esse agevolmente divenissero amiche loro o inimiche, così nell’uomo cresceva la stima di se e la fiducia veggendosi assistito da tanti numi. Se incorreva in qualche disastro, imaginavasi di essere di tanta importanza al cielo ch’esso manderebbe all’improvviso una truppa di cotai geni per iscamparlo. Se gli andava amale qualche intrapresa, non dovea incolparsi per ciò la propria imprudenza o poca destrezza, ma bensì il maligno talento di quello invisibile spirito, che perseguitavalo occultamente. Non erano, secondo i Troiani, il rapimento d’Elena o gli oltraggi recati alla Grecia le cagioni delle loro disavventure ma l’odio inveterato d’alcuni Iddi contro la famiglia di Laomedonte. Non erano i Greci coloro che nell’orribil notte dell’incendio portavano scorrendo per ogni dove la strage: era la dea Giunone, che minacciosa e terribile appiccava con una fiaccola in mano il fuoco alle porte Scee; era l’implacabil Nettuno, che scuotendo col tridente le mura, le faceva dai fondamenti crollare. S’Enea abbandona Didone è perché un nume gliel comanda, e se i Tiri dopo sette mesi di resistenza s’arrendono ad Alessandro, non è per mancanza di coraggio, gli è perché Ercole è comparso in sogno al celebre conquistatore offerendogli le chiavi della città. Dal che si vede che gli uomini si dilettano del maraviglioso mossi dal medesimo principio, che gli spinge a crearsi in mente quegl’idoli imaginari chiamati fortuna e destino, per fare, cioè, maggiormente illusione a se stessi.
[6] Un altro fonte del piacere che recan le favole si è l’istinto che ci porta a cercar la nostra felicità. Dotati da una parte di facoltà moltiplici sì interne che esterne, e dall’altra collocati in circostanze, ove i mezzi di soddisfarle sono sì scarsi e dove i mali vengono sovente ad amareggiare i frali ed interrotti piaceri della loro vita, gli uomini non hanno altro supplemento che il desiderio vivo d’esser felici, e l’imaginazione che si finge i mezzi di divenirlo. Però, accumulando col pensiero tutti i beni che a ciascun senso appartengono, e il numero loro e l’intensità quanto si può amplificando, giunsero a inventare i favolosi paradisi, ovvero sia luoghi di delizie, i quali sappiamo a tutte le nazioni essere stati comuni. E gli alberi dell’Esperidi, onde poma d’oro pendevano, e gli eterni zeffiri che leggiermente scherzavano tra le fiondi dei mirti nelle campagne di Cipro, e i rivi di latte e miele che scorrevano nelle Isole fortunate, e i dilettosi boschetti d’Adoni nell’Arabia, e gli orti d’Alcinoo, e i tempi di Tessaglia, e i giardini d’Armida, e il voluttuoso cinto di Venere, e l’immortali donzelle che il sagace Maometto destinò ai piaceri de’ suoi fedeli musulmani dopo la morte loro, non altronde ebbero principio se non se dai voli dell’inquieta imaginazione avvivata dal desiderio di godere di tutte le delizie possibili.
[7] L’ultima causa è l’amore della novità. O perché l’essenza del nostro spirito è riposta nell’azione continua, o perché, essendo di capacità indefinita, non trova alcun oggetto individuale che a pieno il soddisfaccia, onde nasce il desiderio di percorrere tutti gli oggetti possibili, o perché l’ingenita tendenza al piacere lo spinge a variare le sue modificazioni per discoprire tutte le relazioni, che hanno le cose con esso lui, o per qualche altra causa a noi sconosciuta, certo è che l’uomo è naturalmente curioso. La quale facoltà diviene in lui così dominante che qualora gli manchino oggetti reali su cui esercitarsi, s’inoltra persin nel mondo delle astrazioni a fine di trovarvi pascolo. A soddisfare siffatta inquietezza sono conducenti la mitologia e le favole. Che le cose accaggiano secondo l’ordinario tenore, ciò non desta la maraviglia, ma il sentire avvenimenti stravaganti e impensati, il vedere una folla d’Iddi, i quali sospendono il corso regolare della natura, e intorno a cui non osiamo pensare se non se pieni di quel terrore sublime che ispira la divinità, ciò sorprende gli animi consapevoli a se medesimi della propria debolezza, ne risveglia la curiosità e ne riempie d’un certo sensibile affetto misto d’ammirazione, di riverenza e di timidezza. Oltredichè la fantasia s’aggrandisce, per così dire, e dilatasi per cotai mezzi. Quando l’immaginazione a scioglier il nodo altre vie non sa rinvenire che le ordinarie, l’invenzione non può a meno di non essere imbarazzata e ristretta, ma qualora ne abbia essa la facilità di snodar per macchina ogni evento, avendo alla mano il soccorso di codeste intelligenze invisibili, i suoi voli diventano più ardimentosi e più liberi, e l’invenzione più pellegrina. I mezzi naturali non sariano stati sufficienti a liberar Telemaco dalle perigliose dolcezze dell’isola di Calipso, vi voleva Minerva che dall’alto d’uno scoglio sospingendolo in mare cavasse il poeta d’impaccio, e mettesse in sicuro la troppa combattuta virtù del giovane eroe. Perciò gli antichi, i quali sapevano più oltre di noi nella cognizione dell’uomo, stimarono esser la favola tanto necessaria alla poesia quanto l’anima al corpo, all’opposito d’alcuni moderni che, volendo tutte le belle arti al preteso vero d’una certa loro astratta filosofia ridurre, mostrano di non intendersi molto né dell’una né dell’altra65.
[8] Indicati i fonti del diletto che nasce dal maraviglioso, avviciniamci al nostro argomento, ricercando brevemente la sua origine storica in quanto ha relazione col melodramma. Il meraviglioso, che in questo s’introdusse nel secolo scorso, fu di due sorti, la mitologia degli antichi, e le fate, gl’incantesimi, i geni con tutto l’altro apparato favoloso, cui io darei il nome di mitologia moderna. Non occorre punto fermarsi intorno all’origine della prima, essendo noto ad ognuno che nacque dalla mal intesa imitazione de’ poeti greci e latini trasferita al teatro. Merita bensì la seconda qualche riflessione.
[9] Lo squallido aspetto della natura ne’ paesi più vicini al polo per lo più coperti di neve, che ora si solleva in montagne altissime, ora s’apre in abissi profondi; i frequenti impetuosi volcani, che fra perpetui ghiacci veggonsi con mirabil contrasto apparire; foreste immense d’alberi folti e grandissimi credute dagli abitanti antiche egualmente che il mondo; venti fierissimi venuti da mari sempre agghiacciati, i quali, sbuccando dalle lunghe gole delle montagne, e pei gran boschi scorrendo, sembrano cogli orrendi loro muggiti di voler ischiantare i cardini della terra; lunghe e profonde caverne e laghi vastissimi, che tagliano inegualmente la superficie dei campi; i brillanti fenomeni dell’aurora boreale per la maggior obliquità de’ raggi solari frequentissimi in quei climi; notti lunghissime, e quasi perpetue; tutte insomma le circostanze per un non so che di straordinario e di terribile che nell’animo imprimono, e per la maggior ottusità d’ingegno che suppongono negli abitanti a motivo di non potervisi applicare la coltura convenevole, richiamandoli il clima a ripararsi contro ai primi bisogni, doveano necessariamente disporre alla credulità le rozze menti de’ popoli settentrionali. Della qual disposizione approfittandosi, i pretesi saggi di quella gente chiamati nella loro lingua “Runers”, o “Rimers”, che riunivano i titoli di posti, d’indovini, di sacerdoti e di medici ben presto inventarono, o almea promossero, quella sorte di maraviglioso che parve loro più conducente ad eccitare in proprio vantaggio l’ammirazione e il terrore dei popoli.
[10] Una religione malinconica e feroce, qual si conveniva agli abitanti e al paese, prese piede fra gli idolatri della Scandinavia. La guerra posta quasi nel numero degli dei dal loro antico conquistatore Oddino avea tinto d’umano sangue le campagne e i sassi. Tutto ivi respirava la destruzione e la morte. Il legislatore deificato poi da’ suoi seguaci veniva onorato da essi col titolo di padre della strage, di nume delle battaglie, di struggitore e d’incendiario. I sagrifizi più graditi che gli si offerivano erano l’anime degli uomini uccisi in battaglia, come il premio che si riserbava nell’altra vita ai più prodi campioni era quello di bere un nettare delizioso presentato loro nel cranio de’ propri nemici dalle Ouris, ninfe di sovrumana bellezza destinate per sin nel cielo ad essere il più caro oggetto di godimento, ovunque una religione falsa e brutale consulta piuttosto i sensi dell’uomo che la ragione. Così nemmeno fra le delizie sapevano dimenticarsi della loro fierezza. Sembra che Oddino altro divisamento non avesse fuorché quello d’innalzar la gloria degli Scandinavi sull’eccidio del genere umano. Siffatte idee trasparivano eziandio nella loro mitologia ripiena di geni malefici, i quali uscivano dal grembo stesso della morte per far danno ai viventi. Quindi ebbero origine le appirazioni de’ gli spiriti aerei, gli spettri, i fantasimi, i folletti, i vampiri e tanti altri abortivi parti della timida immaginazione, e della impostura. Nicka nell’antica lingua degli Scandinavi era uno spirito, il quale si compiaceva di strangolar le persone che per disgrazia cadevano nell’acqua. Mara era un altro che gettavasi sopra coloro che riposavano tranquillamente sul letto, e levava loro la facoltà di parlare e di muoversi. Bo era un ardito guerriero figlio d’Oddino, il cui nome profferivano i soldati all’entrar in battaglia sicuri di riportarne vittoria. Rath era un genio sitibondo del sangue de’ fanciulli, il quale invisibilmente succhiava qualora trovati gli avesse lontani dalle braccia della nutrice. E così degli altri. Gli Scandinavi stimavano tanto necessario istillar negli animi teneri siffatte opinioni, che fra gl’impieghi che cercavano i Septi, ovvero sia i principiali tra loro per la buona educazione de’ figliuoli, uno dei primi era quello di facitore di novelle.
[11] Divenuti i numi così maligni, i popoli aveano bisogno di mediatori per placarli. Egli è ben credibile, che i mentovati indovini o sacerdoti non lascierebbero scappar via una così bella occasione di rendersi necessari. A questo fine era lor d’uopo farsi creder dal volgo superiori agli altri nella scienza e nella possanza, ritrovando una tal arte che supponesse una segreta comunicazione tra il mondo invisibile e il nostro, e della quale essi ne fossero esclusivamente i possessori. L’uno e l’altro fu fatto, ed ecco divenir familiari tra loro gli incantesimi, le malìe, i sortilegi, le stregonerie e le altre magiche operazioni, colle quali assicuravano di poter eccitare e serenar a grado loro le tempeste, sedar il mare, sparger il terrore fra gli inimici, sollevarsi nell’aria, trasportarsi improvvisamente da un luogo all’altro, scongiurare e far comparire gli spiriti, convertirsi in lupo, in cane o in altro animale, trattener il sangue delle ferite, farsi amar dalle donne all’eccesso, guarir ogni sosta di malattie e render gli uomini invulnerabili, del che non pochi fra loro vantavansi d’aver fatto in se medesimi lo sperimento. E ciò non solo colle parole e col tatto, ma con misteriosi caratteri ancora, i quali aveano virtù d’allontanare ogni guai da chi li portava seco: onde trassero origine i talismani, gli amuleti, e tai cose.
[12] La religione cristiana, apportando seco l’idea semplice, vera e sublime d’un unico iddio, distrusse nella Scandinavia i deliri della idolatria, e con essi la potenza dei , che ne erano il principale sostegno. Ma siccome troppo è difficile nei popoli rozzi estirpare in picciol tratto di tempo ogni radice d’antica credulità, così gran parte di esse superstizioni divelte dal sistema religioso durò lungamente nelle menti del volgo.
[13] Colle conquiste dei goti si sparse adunque per l’Europa la moderna mitologia abbellita di poi, e vieppiù propagata da’ poeti e de’ romanzisti. I disordini introdotti dal governo feudale, e l’impossibilità d’ogni buona politica ove le leggi deboli ed impotenti non potevano far argine ai delitti, ove altro non regnava fuorché violenze e rapine, e dove la bellezza dell’oggetto era un incitamento di più ai rapitori, aveano convertita l’Europa in un vasto teatro d’assassini e di furti, di scorrerie e di saccheggi. Tra le prede che più avidamente cercavansi, eran le donne, come oggetti fatti dal cielo per piacere, e che in tutti i secoli e dappertutto furono la cagion prossima de’ vizi dell’uomo e delle sue virtù. Quindi per la ragion de’ contrari non men valevole nelle cose morali che nelle fisiche, nacque la custodia più gelosa di loro, e il combatter per esse, e il ritorle dai rapitori, e il farsi molti un punto d’onore cavalleresco nel diffenderle, sì per quell’intimo sentimento che ci porta a proteggere la debole ed oppressa innocenza, come per acquistarsi maggiormente grazia nel cuor delle belle riconquistate: grazia che tanto più dovea esser cara quanto più ritrosa e difficile, e quanto più erano consapevoli a se medesimi d’aversela meritata. Di più, essendo a que’ tempi ricevuta dalle leggi l’appellazione per via di duello, le dame, che non potevano venir a personale tenzone, combattevano per mezzo dei lor cavalieri, ai quali veniva troncata la mano in caso di perdita. In altri paesi le donne accusate di qualche delitto non si condannavano alla pruova dell’acqua e del ferro rovente se non se allorquando niun campione prendeva la loro difesa. Era perciò ben naturale che queste consapevoli a se medesime della propria fievolezza pregiassero molto i cavalieri prodi e leali, dai quali oltre l’istinto naturale del sesso, attendevano aiuto e patrocinio nelle occasioni. Quindi poi gli amori vicendevoli, le corrispondenze fortissime, l’eroismo d’affetti e di pensieri, d’immaginare e d’agire, che noi per disonor nostro mettiamo al presente in ridicolo, ma che pur vedevasi allora accoppiato colla bellezza nelle donne e coll’onoratezza e il valor guerriero nei cavalieri.
[14] Dalla osservazione di siffatti avvenimenti, e dalla voga che avea preso nel popolo quel maraviglioso tramandato dai settentrionali, nacquero i romanzi in verso e in prosa, i quali altro non sono stati in ogni secolo se non se la pittura de’ pubblici costumi. Perciò insiem coi palazzi e le selve incantate, colle anella, le armi, e le verghe fatate, cogli endriaghi, e gl’ippogrifi dotati d’intelligenza, coi giganti, nani, damigelle, e scudieri a servigio delle belle o in loro custodia, cogl’incantatori, le fate, e i demoni or favorevoli or nemici, vi si leggono fellonie de’ malandrini severamente punite, provincie liberate dai tiranni e dai mostri, cortesie, e prodezze impareggiabili de’ paladini, pudor seducente nelle donne e costanza congiunta a dilicatezza inesprimibile, e tali altre cose, le quali schierate innanzi agli occhi d’un tranquillo filosofo, e paragonate con quelle d’altri tempi, lo conducono alla cognizione generale dell’uomo, e a disingannarsi della vana e ridicola preferenza che gli interessati scrittori danno ai costumi delle nazioni e de’ secoli che essi chiamano illuminati, sopra quei delle nazioni e de’ secoli che chiamano barbari66,
[15] Alle accennate cause della propagazion delle favole debbe a mio giudizio aggiugnersi un’altra. La filosofia colle premure di e poi codici disotterrati, colla venuta dei Greci in Europa, e col patrocinio della Casa Medici, de’ pontefici, e de’ re di Napoli, rinacque in Italia nel secolo XV principalmente la Cabbalistica e la Platonica, non quale aveala dettata in Atene il suo pittoresco e sublime autore, ma quale dai torbidi fonti della setta alessandrina a noi si derivò. E siccome trascuravasi allora lo studio pratico della natura, senza cui vana e inutil cosa fu sempre ogni filosofica speculazione, così altro non era che un ammasso di bizzarre cavillazioni e di fantasìe. Lasciando alle stolide menti del volgo il mondo vero e reale qual era uscito dalle mani del Creatore, comparve nei libri di que’ metafisici non diversi in ciò dai poeti un altro universo fantastico pieno di emanazioni, e d’influssi celesti, di nature intermedie, d’idoli, di demoni, di geni, di silfi e di gnomi, vocaboli inventati da loro per sostituirli nella spiegazione delle cose naturali alle qualità occulte de’ peripatetici, da cui volevano ad ogni modo scostarsi. Onde sorsero in seguito o crebbero la magia eretta in sistema, l’astrologia giudiziaria, la chiromanzia superstiziosa, la fisica inintelligibile, la chimica misteriosa, la medicina fantastica e tali altre vergogne dell’umanar ragione, ch’ebber nome di scienze nell’Europa fino a’ tempi del Galileo e del Cartesio.
[16] Da tai mezzi aiutata la moderna mitologia si trasfuse nella poesia italiana, e contribuì non poco ad illeggiadrirla. Testimonio fanno i poemi del , del , del , dell’, e dietro a loro anche il , che non piccola parte introdusse negli episodi, e il , e il con altri. Particolari cagioni fecero sì che tanto questa spezie di maraviglioso quanto quello della mitologia degli antichi s’unissero agli spettacoli accompagnati dalla musica. Per ispiegarle bisogna più alto risalire.
[17] Benché l’unione della musica e della poesia, considerata in se stessa o com’era nei primi tempi della Grecia, nulla abbia di stravagante, né di contrario, tuttavia considerandola come è nata fra noi dopo la caduta del romano impero, vi si scorge per entro un vizio radicale, di cui gli sforzi de’ più gran musici e poeti non l’hanno potuto intieramente sanare. Questo vizio consiste nella distanza che passa tra la favella ordinaria e la poesia, e tra la poesia comune e la musica. Io ho esaminato di sopra i caratteri musicali della lingua italiana, ed holla per questa parte commendata moltissimo: ma il lettore avrà riflettuto che l’esame fatto è puramente relativo allo stato attuale delle altre lingue d’Europa, e che molto calerebbero di pregio la poesia e la lingua italiana se invece di paragonarle colle viventi si paragonasse colla poesia e la lingua de’ Greci. So che alcuni eruditi non si sgomentano del confronto ad onta dell’ignoranza in cui si trovano di quella favella divina, e so che fra gli altri il 67 e il 68 si sono lasciati dal pedantismo e dalla farraginosa erudizione addormentar l’animo a segno d’asserire che l’esametro degli antichi era privo d’armonia paragonato coll’italiano d’undici sillabe. Altri disputerà quanto vuole per contrastar la loro opinione; io che l’attribuisco più che a mancanza d’ingegno al non aver gli organi ben disposti a ricever le impressioni del bello, mi contento di dire che siffatto giudizio non si sconverrebbe alle orecchie di Mida, il quale trovava più grati i suoni della sampogna di Pane che della lira d’Apollo.
[18] Chechessia di ciò, la lingua italiana, come tutte le altre, non si dispose a ricever la poesia se non molto tardi, allorché erasi di già stabilita, e col lungo uso di parlar in prosa fortificata. I poeti adunque che vennero dippoi, non trovando se non sintassi uniforme e difficile e frasi triviali, si videro astretti per distinguersi a inventar certe forme di dire, certi turni d’espressione e figure e inversioni inusitate, che allontanassero il linguaggio prosaico dal poetico. Cotal lontananza divenne maggiore allorché la lingua dovette accoppiarsi colla musica: impercioché siccome la poesia rigettava molte frasi prosaiche, così la musica non ammetteva se non poche forme di dire poeti che, onde nacque un linguaggio musicale separato e distinto, che non potea trasferirsi a’ comuni parlari. Fu non per tanto giustissima l’osservazione d’un giornalista a cui né questo titolo, né lo stile impetuoso e sovente mordace debbono sminuire il pregio d’aver veduto chiaro in molte cose, che di quarantaquattromila e più voci radicali che formano la lingua italiana, solo sei o settemila in circa fossero quelle ch’entrar potessero nella musica69. Dall’altra parte questa rinata come la lingua più per caso o per usanza, che per meditato disegno d’unirsi alla poesia, crebbe in principio e si formò separatamente da essa. Così allorquando dovettero insieme accoppiarsi, vi si trovò un certo imbarazzo cagionato dalla mancanza di prosodia e di ritmo sensibile nelle parole, onde poco vantaggio ne traeva il movimento regolare e la misura, e dal troppo complicato giro del periodo e accozzamento duro delle voci poco favorevole alla melodia. Il qual imbarazzo tanto dovette esser più grande quanto che la natura di esso accoppiamento esigeva, che. la musica e la poesia si prendessero per un unico e spio linguaggio.
[19] Cotali difficoltà fecero sì che il popolo, non vedendo alcuna relazione tra la favella ordinaria e la musicale, stimò che quest’ultima fosse un linguaggio illusorio, che poco avesse del naturale, destinato unicamente a piacere ai sensi. Però di nulla altro ebber pensiero i musici che di dilettarli, ora accumulando suoni a suoni e stromenti a stromenti affine di sorprender l’orecchio e di supplire collo strepito alla mancanza del verosimile; ora cercando nella varia unione degli accordi i mezzi di piacere anche indipendentemente della poesia, a cui non ben sapevano unire la musica, onde nacquero le sonate, le sinfonie, i concerti e gli altri rami d’armonia strumentale; ora chiamando in aiuto gli altri sensi affinchè riempissero colla loro illusione quel divario, che pur durava tra le due facoltà sorelle. Ed ecco il perché fin dal principio di rado o non mai venne sola la musica, ma quasi sempre accompagnossi colla pompa, colla decorazione e collo spettacolo ne’ canti carnascialeschi, nelle pubbliche feste e ne’ tornei: benché tristo compenso dovea riputarsi questo nella mancanza d’espressione e di vera melodia. E siccome per le cagioni esposte fin qui le favole e il maraviglioso erano, per così dire, l’anima di cosiffatti spettacoli a que’ tempi, perciò la musica ad essi congiunte fu creduta da tai cose esser inseparabile.
[20] Salita poi sul teatro continuò a comparire unita alle farse, agl’intermezzi ed ai cori, che con grande apparato esponevansi agli occhi. Noi abbiamo veduto che non fu se non assai tardi che s’incominciarono a intavolar le melodie ad una voce sola, le uniche che potevano contribuire a dirozzare la musica e a facilitar la sua applicazione alla poesia. E basta esaminar i pezzi di musica corica, ovvero a più voci, che ne rimangono de’ cinquecentisti per veder quanto allor fosse imbarazzata e difficile pei vizi mentovati di sopra nemici della energia musicale, e contrari al fine di quella facoltà divina. Per quanto adunque s’affaticassero que’ valent’uomini della non mai abbastanza lodata camerata di Firenze, non valsero a sradicare in ogni sua parte i difetti della musica, che troppo alte aveano gettate le radici, né poterono dar alla unione di essa colla poesia quell’aria di verosimiglianza e di naturalezza che avea presso a’ Greci acquistata, dove la relazione più intima fra queste due arti dopo lungo uso di molti secoli rendeva più familiare, e per ciò più naturale il costume d’udir cantar sul teatro gli eroi e l’eroine. Perciò gl’inventori s’avvisarono di slontanare il più che si potesse l’azione dalle circostanze dello spettatore, affinchè minor motivo vi fosse di ritrovarlo inverosimile. Non potendo far agire dignitosamente cantando gli uomini, gli trasmutarono in numi. Non trovando nella terra un paese dove ciò si rendesse probabile, trasferirono la scena al cielo, all’inferno, e a’ tempi favolosi. Non sapendo come interessar il cuore colla pittura de’ caratteri e delle passioni, cercarono d’affascinare gli occhi e gli orecchi coll’illusione, e disperando di soddisfare il buon senso, s’ingegnarono di piacere alla immaginazione. Tale fu a mio giudizio l’origine del maraviglioso nel melodramma.
[21] In appresso la musica, per le cause che si esporranno nel capitolo ottavo, rimase nella sua mediocrità dai tempi del Caccini e del Peri fino a più della metà del secolo decimosettimo. Crebbe all’opposto e salì alla sua perfezione l’arte della prospettiva per l’imitazione degli antichi, per l’ardore acceso negl’Italiani in coltivarla, per le scuole insigni di pittura fondate in parecchie città emule della gloria e degli avanzamenti, pel gran concorso di stranieri, e pel favore de’ principi. L’architettura si lasciò parimenti vedere in tutto il suo lume ne’ sontuosi portici e ne’ vasti teatri degni della romana grandezza, per riempire i quali vi voleva tutto lo sfoggio delle arti congiunte. Gl’Italiani adunque, attendendo procacciarsi diletto, fecero uso di queste in mancanza di buona musica, allorché essendo conducente il sistema del maraviglioso, e trovandolo di già stabilito a preferenza degli argomenti storici, fu maggiormente promosso nel melodramma, e vi si stabilì come legge propria di tai componimenti.
Capitolo settimo §
Rapida propagazione del melodramma dentro e fuori d’Italia. Azioni musicali in Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, e la Russia.
[1] Uno spettacolo che riuniva tutte le vaghezze delle belle arti non poteva far a meno di non aggradare all’universale. Così appena comparve il melodramma in Firenze che rapidamente si sparse dentro e fuori d’Italia.
[2] Roma, che in ogni tempo si dichiarò protettrice delle arti e delle lettere, sì perché le une e le altre servono ad abbellire il maestoso edifizio della religione, come perché questa nuova maniera di signoreggiare negli animi si confà molto alle mire di quella Capitale del mondo cristiano, e perché gli avanzi non anco spenti della sua grandezza la richiamano ogni giorno allo studio dell’antichità il quale tosto o tardi conduce al buon gusto, doveva parimenti promuovere la musica e la poesia. Quel genio, che la determinò a incoronar il in Campidoglio e a preparare per il medesimo onore, che la mosse ad inalzar il primo teatro conosciuto in Italia a tempi di Sisto IV e a far rappresentare a’ tempi di Leon X la prima tragedia che la sollecitava a voler fregiare colla porpora di cardinale gli omeri di Raffaello d’Urbino e a profonder tesori a pro de’ begli ingegni, quel genio medesimo fecesì che ben presto allignò per entro alle sue mura codesto nuovo genere di musica teatrale. L’anno 1600 vi rappresentò L’anima e il corpo, pastorale di , dama lucchese, posta in musica da . Nel 1606, , celebre compositore romano, fece colà vedere uno spettacolo consimile per istigazione di assai noto pe’ suoi viaggi. La celebrità che acquistò poco dopo l’Arianna del modulata dal introdusse fra i signori romani l’uso delle musiche di camera e delle cantate, a comporre le quali concorrevano a gara i primi poeti e le più brave donne a cantarle. Levò fra l’altre gran fama l’Oronta di componimento in ottava rima messo in musica allo stesso tempo da quattro maestri. Il severo e religioso contegno del papa Innocenzo XI trattenne in seguito per qualche tempo il corso a siffatti divertimenti, ma dopo la sua morte incominciò di nuovo la corte ad assaporarli, dando a ciò occasione il concorso di tanti stranieri e la magnificenza di tante famiglie principesche, le quali si pareggiavano coi sovrani nella sontuosità e nelle ricchezze. né troppo era strano il vedere i cardinali stessi impegnati nell’accrescer lustro e splendore a’ teatrali spettacoli; tra essi basti annoverare il cardinal Deti, il quale in compagnia di istituì l’anno 1608 nel proprio palazzo l’Accademia degli Ordinati, destinata a promuovere le cose poeti che e le musicali, come anche un altro porporato illustre scrisse, e fece rappresentar l’Adonia, melodramma di cui fa ne’ suoi Commentari un magnifico elogio, ma che debbe riporsi tra i molti insensati panegirici, che il bisogno o la voglia di farsi proteggere detta non poche fiate a quelli scrittori che fanno della letteratura un incenso onde profumare gl’idoli più indegni di culto.
[3] Una delle prime anche ad abbracciarlo fu Bologna, città che dopo essersi renduta famosa per le virtù che ispira l’amore della libertà, coltivava allora le arti che germogliano nell’ozio d’una pacifica servitù. Memore della sua antichissima gloria nelle lettere, e desiderosa di conservarla, essa fu quasi la sola che mantenesse nel secolo scorso le belle arti guaste per tutto altrove dal cattivo gusto dominante. Tra queste fiorirono principalmente la pittura nella pregievolissima scuola de’ , e la musica nelle tante accademie erette a fine di perfezionarla. I Filomusi, istituiti dal nel 1622, i Floridi, i Filaschi, i Filarmonici, e soprattutto i Gelati e pel favore prestato alle cose musicali, di che ci è rimasta la testimonianza in molte e belle cantate, e per le fatiche di molti dotti accademici che coltivarono questo ramo di drammatica poesia, contribuirono assaissimo a propagarlo in Italia. L’anno 1601 si rappresentò ivi l’Euridice del , e poi di mano in mano altri drammi comparvero con poche volte interrotta cronologica serie fin quasi a’ nostri tempi.
[4] l’introdusse in Vinegia allorché divenne maestro della Serenissima Repubblica, e prima nei privati palagi e ne’ conviti dei dogi, poi nell’antichissimo teatro di S. Cassiano fu veduta per la prima volta comparire in pubblico l’Andromeda colla musica e la poesia di . D’allora in poi quella città fu sempre uno de’ principali seggi del dramma, e qui si rappresentava colla pompa più illustre, massimamente nel Carnovale a fine di tirare a se l’oro de’ forestieri. Tutte le altre città chi più presto chi più tardi s’affrettarono anch’esse ad accoglierlo.
[5] Nè si ristette fra i termini d’Italia,
ma varcando le Alpi portò la gloria della musica e della lingua italiana per tutta
l’Europa. La superba Francia, la quale
vorrebbe pur ora far fronte e resistere alla dominatrice magia delle modulazioni
italiane, fu allora la prima a chiamare a se il dramma musicale, e ciò nel 1645. Non è
che i Francesi non avessero anche avanti notizia di qualche spezie di rappresentazioni
musicali, poiché senza risalire fino a’ provenzali, che furono i primi a introdurle in
Italia, sappiamo ancora che erano conosciute fin dai tempi di
Francesco I, il quale fece venir da
Firenze parecchi uomini celebri in questo genere, annoverandosi
tra loro corte il più distinto un certo Messer chiamato dall’ in una
lettera scrittagli nel 6 di luglio del 1538: «lume dell’arte, che l’ha fatto sì
caro alla sua Maestà e al mondo»
. Furono poi maggiormente promosse sotto la
regenza di Caterina de’ Medici, la quale chiamò
musici e suonatori italiani per rallegrare con balli, mascherate e festini la corte, ove
gran nome s’acquistò il conosciuto dai
Francesi col nome di colle sue
leggiadrissime invenzioni, onde ottenne l’impiego di cameriere della regina, e in
seguito di Arrigo Terzo. né dee tralasciarsi
inventore del dramma in
Italia, il quale allorché accompagnò la regina Maria de’ Medici, di cui ne fu perdutamente innamorato,
col titolo di gentiluomo, il gusto delle cose musicali grandemente promosse. Ma il
melodramma, come s’intende in oggi, non fu conosciuto se non se a’ tempi del cardinal
Mazzarini. Codesto celebre ministro per
trattener Luigi XIV nella sua giovinezza, e per
avvezzarlo a quella dissipazione di spirito così fatale ai popoli e così utile ai
favoriti che aspirano ad uniccheggiar nel comando, fece di nuovo venir
dall’Italia gran numero di musici, i quali rappresentarono per
la prima volta sul teatro Borbone la Finta pazza,
dramma di colla musica del . Nel 1647 fu visto nel teatro del Palazzo
Reale
Orfeo ed Euridice d’
rappresentato con magnificenza incredibile. Nel 1660 comparve sul medesimo teatro
l’Ercole amante finché nel 1669 Monsieur ottenne il privilegio di comporre esclusivamente per l’opera
francese70, condotta di poi a gran celebrità pell’erezione
dell’Accademia in musica, per le armonie del , e per le mirabili poesie di .
[6] Il privilegio esclusivo dato al fu la cagione che il melodramma s’introducesse in Inghilterra. Imperocché sdegnato di ciò il , musico francese che pretendeva al medesimo onore, lasciò il proprio paese e si ritirò a Londra, dove le feste musicali erano in uso come per tutto altrove da lungo tempo. Sotto i primi re d’Inghilterra e di Scozia, la musica fu selvaggia quasi del tutto. Dai tempi di Riccardo cuor di Lione cominciò lentamente a prender forma più regolare. Scaduta dall’antico privilegio che godeva ai tempi de’ Caledoni, d’animare, cioè, i popoli ai trionfi e alla osservanza de’ riti nazionali, essa prese il carattere della scostumatezza e della licenza nelle canzoni chiamate da loro Drinking Catches, ovvero sia da cantarsi nei brindisi. In questi componimenti non meno che negli amorosi si scorge piuttosto la vivacità e il brio che il vero gusto musicale, sebbene alcuna vi si legga di esse lavorata con siogolar espressione71. , quel celebre italiano favorito dalla bella e sventurata regina Maria Stuarda, introdusse il primo di tutti nella musica scozzese il gusto italiano, che dura tuttora in alcune composizioni72. Sotto il regno di Elisabetta fece quest’arte qualche maggior progresso pel favore della regina, e pel commercio cogl’Italiani. In seguito preser voga gl’intermedi nelle commedie o feste, massimamente ne’ conviti e ne’ tempi di pubblica allegrezza, tra le quali assai bella e ingegnosa comparsa ne fece quella rappresentata nel palazzo di San James l’anno 1613 nelle nozze di Federigo V Palatino del Reno colla principessa Isabella d’Inghilterra e di cui ne daremo in altro luogo la descrizione. Da quali principi incoraggito il mostrò per la prima volta agli occhi degli Inglesi il dramma musicale qualmente si trovava allora in Francia, ma non si potendo sostenere per la persecuzione mossa contro all’autore, furono chiamati dall’Italia musici e cantori che introdussero il melodramma italiano, sollevato di poi a maggior altezza nelle composizioni del fecondo e sublime 73.
[7] La Germania l’accolse parimenti versò la metà del Seicento. Le loro antiche fiere, ovvero siano feste carnascialesche chiamate Wirschaft, che con grandissimo apparato di comparse e di suoni vi si celebravano; la musica strumentale da loro coltivata con impegno; la magnificenza degli elettori di Baviera, di Sassonia, dell’Imperador Leopoldo, e d’altri principi che non risparmiavano spesa né diligenza affinchè riuscissero sontuosissimi gli spettacoli che si davano alle loro corti, aveano di già appianata la via al melodramma. , poeta drammatico superiore agli altri della sua nazione in quel secolo, fu il primo a introdurlo in Dresda, traducendo in tedesco la Dafne del , e un’altra d’autore diverso intitolata la Giuditta. Ciò avvenne verso il 1630. Pel sentiero da lui indicato si stradarono parecchi scrittori desiderosi d’arricchire la poesia germanica con un teatro lirico nazionale; ma o fosse che la lingua rozza e inflessibile non potesse alla dolcezza musicale abbastanza piegarsi, o nascesse ciò dalla penuria d’ingegni superiori, certo è che i tedeschi abbandonarono allora il pensiero di scriver drammi nel proprio idioma. Aggiugnendosi poi la circostanza che la corte imperiale si riempì di ministri e di signori italiani e che l’Imperator Leopoldo74 molto si dilettava della musica loro, fu chiamato gran numero di suonatori e di cantanti, i quali sparsero dappertutto il gusto dell’opera, e furono scelti poeti che ne componessero, tra quali il marchese ne scrisse cinque drammi intitolati: l’Armida, la Disperazione fortunata, la Fuga, l’Innocente mezzano della propria moglie, e l’Alessandro magnanimo. L’Italia è debitrice di molto ai tedeschi, i quali, procurando agli ingegni italiani l’agio e il comodo di coltivar i propri talenti, sono stati la cagione che l’Europa ammiri in oggi i e i .
[8] Nel medesimo tempo in circa si lasciò il melodramma vedere tra
gli Spagnuoli amantissimi della musica massimamente nazionale. Ciò si scorge dalla
inclinazione al canto e al suono nella gente ancor più rusticana, nelle feste villerecce
che celebransi spesso con istromenti propri di quella gente di minor dilicatezza forse
che gl’Italiani, ma più atti a svegliar le passioni, nelle serenate urbane, nelle
ciaccone, nelle follie, nelle sapate, moresche, sarabande, fandanghi, pavaniglie ed
altri balli sparsi per tutta l’Europa colla dominazione
spagnuola, e massimamente in Italia, la quale ora disdegna di
confessare nel tempo della sua decadenza ciò che non ebbe a schifo di accogliere nel
secolo più illustre della sua letteratura. Musica più composta fu ancora in uso ne’
tempi più antichi, rimanendo per testimonianza non solo la memoria delle canzonette
arabiche cantate dai mori, ma componimenti spagnuoli eziandio posti sotto le note da
Alfonso il Savio re di
Castiglia. Oltre a questi debbono anche aver luogo le
rappresentazioni sacre chiamate Villancicos, che celebransi
con gran pompa nelle chiese, la notte del santissimo Natale, come reliquie de’ Misteri della Passione, come anche le feste profane di tornei,
quadriglie, caroselli, parejas e altri simili divertimenti, che erano allora in gran
voga, e principalmente a’ tempi d’Isabella e di
Ferdinando, e poi di Filippo Secondo. Salì non molto dopo la musica in sul
teatro, dove il primo di tutti la condusse , che fu tra gli Spagnuoli ciò ch’era Tespi fra i Greci. Nel suo tempo
si cantavano dietro alle scene alcune vecchie cantilene nazionali chiamate Romanzes senza strumenti di sorte alcuna. Il toledano , se prestiamo fede a 75, obbligò i musici a sortir fuori alla vista
del pubblico . , ristauratore anch’esso del
genere drammatico, ampliò la musica strumentale, raddoppiando il numero e la qualità
degli strumenti nella orchestra. e introdussero i primi l’usanza di
cantare negli intermezzi, lo che in quella prima rozzezza delle arti drammatiche veniva
eseguito dagli orbi. I Saynetes, sorta di frammessi bellissimi
che sono nel teatro spagnuolo l’immagine della vera e genuina commedia, e nella composizione dei quali ebbe gran nome Don nel secolo passato e Don nel nostro, servirono a promuovere
maggiormente la musica teatrale aprendo talora la scena con qualche coro di musica e
anche framischiando talvolta qualche dialogo musicale. Le Tonadillas, ovvero sia spezie di arie buffe che vi si cantano, possono
gareggiare nella vivacità comica con qualsivoglia componimento musicale delle altre
nazioni. Sui primi anni del regno di Filippo
Secondo s’introdusse l’usanza di cantar duetti e terzetti nelle commedie, e
il melodrammma sarebbe stato conosciuto più presto se da una parte il carattere di
Filippo Terzo dedito alla divozione e alieno da
i teatrali divertimenti, e dall’altra la preferenza data da Filippo Quarto alle commedie nazionali nelle quali furono insigni al suo
tempo , , , e tanti altri sotto le insegne del loro antecessore
, non avessero altrove chiamata
l’attenzione del pubblico . Da una lettera di Don scritta a si
rileva che «la nuova musica drammatica inventata dal era dalle corti de’ principi italiani passata a quelle di
Spagna e di Francia»
, lo che,
essendo certo, proverebbe che l’opera in musica fosse stata trapiantata fra gli
Spagnuoli quasi subito dopo la sua invenzione. Ma per quante ricerche abbia io fatte
affine di verificar l’epoca indicata dal non
mi è avvenuto di poterlo fare, né ho ritrovato notizia alcuna del dramma musicale avanti
ai tempi di Carlo Secondo, nelle nozze del quale
con Marianna di Neoburg si rappresentarono alcuni
drammi colla musica del , il primo dei quali fu
intitolato l’Armida. Indi a non molto, non piacendo alla nazione la
musica francese, si fecero venire musici e cantori da Milano e da
Napoli a rappresentare il melodramma italiano.
[9] Quantunque la introduzione del melodramma in Moscovia non s’appartenga ai tempi di cui parliamo, ho tuttavia giudicato opportuno il trattarne in questo luogo per non vedermi poi obbligato a interromper di nuovo la narrazione. Spero che le cose che sono per dire abbiano a interessare la curiosità del lettore, trattandosi di un paese che ha rivolti verso di se gli occhi di tutta l’Europa, e che sì famoso è divenuto oggimai non meno per la sua passata barbarie che per il presente splendore. La musica dei russi è semplicissima, come debbe esserlo in tutte le nazioni non ancor coltivate. Essa si compone, come dappertutto, di parole, di canto e di suono. Ma ciò che ha la moscovitica di particolare, si è che la poesia veniva esclusa dai loro componimenti musicali, perocché i russi non cantavano se non la prosa. Egli è vero che qualche antico romanzo in versi non rimati si conserva tuttora presso al popolo, come quello del gigante , del grande , ed altri di simil guisa, ma le moderne canzoni tutte in prosa altro per lo più non sono che improvvisate, che ciascuno compone a suo talento, senza curarsi d’osservare il numero delle sillabe o il ritorno delle rime76.
[10] A così strana usanza danno occasione gli accenti della lingua russa, i quali sono così spiccati e sensibili, che agevolmente possono adattarsi alla melodia senza l’aiuto del metro. Coloro che non comprendono come la lingua greca fosse cotanto musicale, troveranno in un barbaro idioma formato tra i giacci e le paludi del settentrione convenevol risposta ai loro dubbi poco fondati, e le nazioni meridionali, che fiancheggiate da filosofiche teorie stimano se sole essere state privilegiate dal cielo per ricevere e rimandarne le dolcissime scosse dell’armonia, dovranno confessare di non poter coi loro linguaggi neppur venire al paragone (almeno in qualche circostanza) con un idioma scitico. Da ciò si vede che il canto costituiva la principal parte della musica russa e che gli strumenti non servivano ad altro che a sostenere la voce. Questa non s’aggirava se non intorno ad una sola specie di melodia, la quale si variava poi dal cantore secondo il proprio genio, onde veniva in conseguenza che l’arte del compositore e del maestro fosse del tutto ignorata. Gli strumenti erano egualmente semplici e l’arte gli ha così poco perfezionati che si veggono a un dipresso nel medesimo stato in cui furono inventati. I principali sono il Gudock, ovvero sia piccolo violino a tre corde. La Balalaika, spezie di chittarino comunissimo presso al popolo, composto di due corde, una delle quali si vibra colla man sinistra mentre con la destra si suonano entrambe. La Dutha, o Schvreraan, composto di due flauti, uno più grande e più piccolo l’altro, ma di tre fori ciascheduno. La Walinka, spezie di cornamusa semplicissima, la quale si forma mettendo due flauti in una vescica di bue inumidita. La Gusli, stromento più nobile perché usato nelle città eziandio, rassomiglia nella fabbrica interna, nella grandezza e nella figura ad un clavicembalo senza tasti. Le corde sono di latta, e si suonano ambidestramente. Il suono è armonioso e gradevole, e capace di gran varietà.
[11] Tal’era lo stato della musica in
Russia dal golfo di Finlandia fino alla
Siberia, e dalla Uckrania fino al
mar glaciale, benché con quelle modificazioni locali che
naturalmente esige una varietà così prodigiosa di climi, allorché Pietro il Grande salì sul trono. Questo genio immortale
che fu non meno il Mercurio che il Solone della sua nazione, tra i moltiplici oggetti
della sua vasta riforma comprese ancora la musica. Egli fece venire dalla
Germania, ove diligentemente avea osservato ne’ suoi viaggi
codesto ramo delle umane cognizioni, ogni sorta di trombe, tamburi, cornetti, fagotti,
viole, tromboni ed altri strumenti; istituì una truppa di giovani moscoviti da erudirsi
nella musica; ne introdusse il gusto e l’usanza ne’ pubblici e ne’ privati divertimenti
promovendo in particolar modo la musica militare come la più confacente alle sue mire.
Il principe Federico d’Olstein-Gottorp, in
occasione di portarsi a Pietroburgo a fine di prender in moglie Anna Petrowna figliuola di Pietro, menò seco dodici bravi musici tedeschi, i quali fecero sentire per
la prima volta a’ moscoviti un concerto in forma. La novità colpì, qualmente si dovea
aspettare, i grandi della nazione, ed ecco a gara coltivarsi da loro la musica, anche
per imitare l’imperatore, il quale avea cominciato a tener accademie regolate di musica
due volte alla settimana nel proprio palazzo. Anna
Iowanona portò sul trono il gusto della musica, e fu nei primi anni del suo
regno che si vide l’Abiazar, opera italiana, comparir sul teatro di corte
con intermezzi e balli. , napoletano, fu il
maestro di cappella, siccome italiani furono per la maggior parte i cantori e i
suonatori, che il gusto nazionale maggiormente promossero. L’Imperatrice Elisabetta protettrice di tutte le belle arti, e in
particolare di questa, fece costruire il primo teatro pubblico dell’opera a
Mosca, dove assistette nella sua incoronazione alla Clemenza di
Tito posta in musica dal celebre , e
rappresentata con magnificenza incredibile. Il prologo intitolato la Russia
afflitta, e riconsolata era dell’,
L’aria «ah miei figli» fu onorata dal pianto universale, e di quello altresì della
imperatrice. Dopo il Seleuco, lo Scipione, e il
Mitridate, drammi composti dal , fiorentino, e messi sotto le note dal nominato , fu rimpiazzato come maestro di Cappella di corte il
pistoiese. Fece questi la musica
all’Alessandro nell’Indie, alla Semiramide, e
all’Olimpiade del ,
rappresentata nel gran teatro di Mosca l’anno 1752 per
l’incoronazione della regina Caterina. Indi si
coltivò l’opera russa. La prima intitolata Cefalo e Proci ebbe per autore
il poeta , e fu posta in musica
dall’. I suonatori e i cantanti erano tutti
russi. Sotto Caterina II fu chiamato alla corte
con grossissimo stipendio il celebre , maestro
allora di cappella in Venezia. La Bidone del
modulata da lui incontrò l’aggradimento
universale. L’imperatrice, terminato che fu lo spettacolo, gli mandò in regalo una
boccetta piena di rubli, dicendo che «la sfortunata Didone avea sul punto di morire lasciato per lui quel
codicillo»
. A succedette il
, napoletano, famoso compositore anch’egli.
, fiorentino, fu dichiarato poeta della
corte. In oggi per la scelta delle più belle voci e de’ più gran musici, per la
magnificenza delle decorazioni e dei balli, l’opera di
Petersbourg è la più compita di Europa.
[12] Siami concesso però di riflettere che lo splendore, che le belle arti ai nostri sguardi tramandano nel clima della Moscovia non è che effimero e passaggiero. Sebbene Pietro il Grande incominciasse dalla musica con lodevole divisamento la sua riforma, sapendo quanta influenza acquisti su un popolo non coltivato tutto ciò che parla immediatamente al sensi, non è tuttavia da commendarsi che siasi egli prevalso a cotal fine d’una musica straniera invece di perfezionare la nazionale. Ogni arte che dipende dal gusto, ha la ragione della sua eccellenza nel clima, nei costumi, nel governo, e nell’indole non meno fisica che morale di quelle nazioni che la coltivano, né può altrove trapiantarsi senza perder molto della sua attività. Codesta verità tanto più diviene sensibile quanto maggiore ne è la differenza che corre tra i paesi, e più stretto è il rapporto che vuolsi mettere fra lo stromento della riforma e la riforma stessa. La musica e la poesia italiana non possono adunque se non assai debolmente influire sulla civilizzazione dei russi, i quali, ignorando le ascose cagioni della loro bellezza, altro non saranno giammai che languidi e freddi copisti. Laddove se le arti di genio fossero presso a loro piante native e non avventizie, se il novello legislatore avesse a poco a poco preparata la nazione al gran cangiamento, se avesse prima profondamente studiato nella storia le vie che percorre l’umano spirito nel coltivarsi, avrebbe forse innalzato al suo nome un più durevole monumento, e le belle arti abitatrici finora dei privilegiati climi della Grecia e dell’Italia additerebbono anche a’ loro cultori nuovi originali da imitare sulle rive del freddo Tanai, e sugli scogli deserti di Sant’Arcangelo.
Capitolo ottavo §
Stato della prospettiva e della poesia musicale fino alla metà del secolo scorso. Mediocrità della musica. Introduzione degli eunuchi e delle donne in teatro.
[1] Ritornando all’Italia, il dramma giacque fin dalla sua origine affastellato ed oppresso sotto lo strabocchevole apparato delle macchine, dei voli e delle decorazioni. Se i compositori che vennero dopo il avesser tenuto dietro alle pedate di quel grande ingegno, e con pari filosofia disaminato la relazione che ha il maraviglioso col melodramma, avrebbono facilmente potuto, dando la convenevol regolarità ed aggiustatezza alle lor favolose invenzioni, crear un nuovo sistema di poesia drammatica che aggradasse alla immaginazione senza dispiacer al buon senso, come fece dappoi in Francia il , il solo tra tutti i poeti drammatici che abbia saputo maneggiar bene il maraviglioso. Ma essendo privi d’ogni principio di sana critica, senza cui non può farsi alcun progresso nella carriera del buon gusto, e stimando che il piacere del volgo fosse l’unica misura del bello, fecero invece di composizioni regolate un caos enorme, un guazzabuglio di sacro e di profano, di storico e di favoloso, di mitologia antica e di mitologia moderna, di vero e d’allegorico, di naturale e di fantastico tutto insieme raccolto a perpetua infamia dell’arte.
[2] Di siffatto disordine tre ne furono le vere cagioni: la prima, la natura stessa del maraviglioso, il quale, ove non abbia per fondamento una credenza pubblicamente stabilita dalla religione e dalla storia, non può far a meno che non degeneri in assurdità, perocché l’immaginazione lasciata a se stessa senza la scorta dei sensi o della ragione più non riconosce alcun termine dove fermarsi. Se dunque avverrà che il maraviglioso, che si vuol introdurre, invece di appoggiarsi sulla popolare opinione, le sia anzi direttamente contrario, allora le poeti che e romanzesche invenzioni, prive d’ogni autorità e d’ogni esempio, non avranno altra regola che il capriccio di chi le inventa. Saranno giudiziose fra le mani d’un , o d’un , ma diverranno stravaganti fra quelle d’un o d’un .
[3] La seconda fu l’esempio d’un celebre autore, il quale ugualmente ricco di fantasia lirica, ugualmente benemerito della propria lingua, che sprovveduto delle altre doti che caratterizzano un gran poeta, contribuì coll’autorità che aveasi acquistata fra suoi nazionali in un secolo, che di già inchinava al cattivo gusto, a guastar il dramma musicale. Questi fu nel suo Rapimento di Cefalo rappresentato nell’anno stesso, nella stessa occasione, e coll’apparato medesimo di quei del , a cui però rimase di gran lunga inferiore nelle cose drammatiche. Il maraviglioso vi si vede gittato alla rinfusa senz’alcun discernimento, Giove, Amore, Berecintia, l’Aurora, Cefalo, Titone, l’oceano, il sole, la notte, i Tritoni e i segni del Zodiaco, sono gl’interlocutori, se non in quanto vengono interrotti dal coro dei cacciatori, i quali, benché siano mortali, non hanno perduto il privilegio d’intervenire alle più intime confidenze dei numi. La scena si rappresenta nei campi, nell’aria, nel mare e nel cielo, e così gran via si trascorre dal poeta in cinque atti brevissimi. Basta ciò per conoscere che le scene debbono essere disunite, il dialogo slegato e privo del menomo calore, i caratteri immaginari, contradicentisi e senza interesse. Lo scarso affetto che regna è tutto lirico, cioè tratto dalla immaginazion del poeta, ma che lascia il cuor vuoto. Infatti qual espressione di melodia può cavarsi dalla invocazione che fa l’Aurora all’Amore?
«Saettator fornitoD’alto fuoco infinitoOnde ogni cosa accendi,Deh! perché meco a saettar non prendiL’aspro smalto onde Cefalo s’indura?»
O qual mezzo di farsi amare da un cuor ritroso è mai quello di addurre per motivo, che se Cefalo non le risponde nell’affetto:
«Il Sol sia senza scorta,L’aria non avrà lume,La terra inferma perirà gelata?»
[4] Amabile e tenero ! Tu non metti in bocca a’ tuoi personaggi simili scempiaggini. Ma il gran nome di legittimò tutti i difetti, e fece tacer ogni critica.
[5] Dietro alla scorta di lui non pensarono i poeti che ad abbagliar gli occhi senza curarsi del rimanente. Tanto era più bello un dramma quanto i cangiamenti di scena erano più spessi, e più grandiosi. Può servire di esempio il Dario di rappresentato a Venezia, il quale in soli tre atti cangiò fino a quattordici volte. Si vide il campo di Dario cogli elefanti che portavano sul dosso torri piene di soldati armati, una gran valle fra due montagne, la piazza di Babilonia, le tende militari del campo Persiano, magnifico cortile di un gran palazzo, il quartiere dell’armata colle macchine di guerra, la sala reale del palazzo babilonese, il padiglione dei re, il mausoleo di Nino, la cavalleria e la fanteria schierate in ordine di battaglia, prigione di tetrissimo aspetto, rovine d’un antico castello e il palazzo intiero di Babilonia. Eppur questo dramma non fu de’ più spettacolosi. Usaronsi delle invenzioni e delle macchine per rappresentare tutti gli oggetti possibili, favolose, storiche, mitologiche, allegoriche, morali, fisiche, sacre, profane, civili, rusticane, marittime, boschereccie i scientifiche d’ogni genere, e molte ancora di mero capriccio e fantasia, cosicché non si possono ridurre a determinate classi. Non poche tra queste per opera de’ bravi macchinisti, che allora fiorivano, e principalmente di Giacomo Torelli, del Cavalier Pippo Aiacciuoli, del Colonna, del Metelli, del Periccioli, del Mingaccino, e del Sabbattini riuscirono vaghissime ed ingegnosissime. Un dramma, o per dir meglio uno spettacolo frammezzato di poesia drammatica lavorata dal si rappresentò a Mantova l’anno 1608 per le nozze di D. Francesco Gonzaga con Margarita di Savoia con sontuosità e grandezza tale che fa stordire i lettori. Si trova alla distesa la descrizione nel tomo terzo delle Opere di esso . Ingegnose molto e leggiadre furono per lo più le invenzioni de’ drammi a Firenze e a Torino, quella per isquisito gusto di ogni arte bella sempre distinta in Italia, questa pella gara de’ più celebri artefici italiani e francesi ivi quasi in centro di riunione di entrambi paesi insieme raccolti. Massimamente sotto il governo di Cristina sorella di Lodovico XIII re di Francia e vedova di Vittorio Amadeo Duca di Savoia, che a quei tempi regolava come tutrice i popoli di Savoia e del Piemonte, e che molto si compiaceva di siffatti divertimenti insiem col Conte Filippo d’Agliè non men celebre pel suo buon gusto nelle decorazioni teatrali che per politiche disavventure77, Meritano particolar menzione per allegoria opportuna e per vaghezza di ritrovato il cielo di cristallo, e le Glorie di Firenze rappresentate colla solita magnificenza di quella corte nelle nozze di Cosimo de’ Medici con Maddalena d’Austria, e per quella di Torino il Vascello della felicità, e l’Arionne che furono veduti al palazzo reale nel Carnovale del 1628, celebrandosi la nascita di Madama di Francia. Non isgradiranno i lettori che io ne dia ioro un qualche saggio a fine di esporre io stato delle invenzioni sceniche nel secolo scorso. Allo scoprirsi che fece il regio salone con grandissimo strepito di stromenti comparvero in cielo tutti gl’iddi propizi agli uomini, ciascun de’ quali cantò un breve recitatativo, cui rispondeva il coro. Indi furono visti apparir gli elementi diversamente simbolleggiati, cioè un vascello che significava l’acqua, un teatro per la terra, un mongibello per il fuoco, e un iride per l’aria. Ecco il salone riempirsi d’acqua in un subito a guisa di mare, pel quale il vascello lentamente inoltravasi, portando nella prora un ricchissimo trono preparato pei sovrani e gli altri principi della corte. Ne’ lati della nave vedeansi di qua e di là incise in diversi scudi le arme delle provincie soggette al Duca di Savoia, e in mezzo una gran tavola apparecchiata per quaranta persone. Il dio del mare invitò i sovrani, le dame, e i cavalieri a entrar in codesto vascello ove furono serviti a suntuosa cena dai Tritoni i quali portavano le vivande sul dosso de’ mostri marini. Frattanto in uno scoglio, che inalzavasi non molto lontano, si rappresentò la favola d’Arione gittato in mare e salvato dal delfino, opera di , bolognese. La musica fece il prologo. Il primo atto conteneva la partenza di Arione da Lesbo sua patria. Nel secondo vedevasi assiso e cantando sul delfino. Nel terzo si trovava a Corinto dove il re Periandro volle udir narrare le sue disavventure, facendolo dappoi riconoscere dai marinari che l’aveano tradito. Alla perfine le Sirene fecero un balletto, che fu invenzione del Duca Carlo Emanuele.
[6] Vinegia si distinse dalle altre città nella magnificenza ed apparato delle comparse, e memorabile si rendette fra gli altri drammi la Divisione del mondo rappresentato nel 1675 a spese e sotto la direzione del Marchese Guido Rangoni sul teatro di San Salvatore, dove tutte le parti del globo terracqueo si videro simboleggiate con istraordinario accompagnamento di macchine, di maravigliosa invenzione. Nel Pastore d’Anfriso eseguito poco dopo nel teatro di San Giovanni Grisostomo, si vide scendere dall’alto il palazzo del sole di vaghissima e bellissima architettura lavorato di dentro e di fuori con cristalli a diversi colori, i quali con singolare maestria si volgevano in giro continuatamente. I lumi erano in tanta copia e con tal artifizio disposti che gli occhi degli spettatori sostener non potevano il vivace chiarore dei raggi, che dai cristalli venivano ripercossi e vibrati. Nel Catone in Utica lavoro d’un poeta di merito assai inferiore a quello di , si supponeva che gli abitanti delle vicine provincie preparassero per Cesare e per la sua armata un magnifico spettacolo lungo la riva del fiume. Lo sfondo del teatro rappresentava una vastissima pianura, in mezzo alla quale si vedeva sospeso in aria un globo che avea la figura di mappamondo. Al romore d’una brillante sinfonia accompagnata dal suono delle trombe, ecco il globo maestosamente avanzarsi verso la parte anteriore del teatro senza che apparissero in modo alcuno le scerete molie, che lo spingevano. Giunto appena sotto gli occhi di Cesare, si spaccò in tre parti che rappresentavano le tre parti del mondo conosciute attempi di quell’imperatore. La faccia interna del globo conteneva una intiera orchestra de’ più bravi suonatori, ed era dapertutto fregiata di molt’oro, di lucenti gemme, e di metalli dipinti a vari colori. E fin qui delle decorazioni.
[7] La terza causa dell’accennato disordine negli spettacoli fu l’uso smodato dei framessi, ovvero sia intermedi musicali. Nella invenzione del dramma siccome i ritrovatori pretesero d’imitar i Greci, presso a’ quali le rappresentazioni non erano mai interrotte dal principio sino alla fine, così non introdussero né intermezzi, né balli, e riempirono gli intervalli coi soli cori; ma tosto degenerando fra le mani degli altri compositori, né sapendo questi come fare per sostener l’attenzione degli spettatori cori azioni prive di verosimiglianza e d’interesse, cominciarono a tagliar i componimenti in più parti frammezzandovi tra atto ed atto intermezzi di più sorta. Alle volte erano d’argomento differente, e ciascuno formava un azione da se, alle volte s’univano cori qualche rapporto generale e formavano uno spettacolo. Sul principio i poeti e i direttori cercarono d’accomodar in qualche riiodo i suddetti intermedi alla natura del dramma, e frapposero quelli di genere boschereccio alle pastorali in musica, i seri al melodramma tragico, e i comici all’opera buffa. Così l’Aurora ingannata servì di favoletta per gl’intermedi musicali nel Filarmindo, favola pastorale, il Glauco schernito per gl’intermezzi del Corsaro Arimante, favola pescatoria, la Dafne conversa in Lauro nella tragicommedia intitolata l’Amorosa clemenza, la tomba di Nino per gli intermezzi dell’Ercole in Eta, dramma eroico, il Disinganno per la virtù in cimento, dramma morale, e il Capriccio con gli occhiali per i Diporti in Villa, dramma giocoso scritto nel dialetto bolognese. Ma tosto inoltrandosi la corruttela, gli accessori divennero l’azion principale, si moltiplicarono gli intermedi senza modo né regola, e lo spettacolo divenne un mostro.
[8] Intanto la poesia era quella parte del dramma cui meno si badava dai compositori. Regolarità, sentimenti, buon senso, sceneggiare, caratteri, orditura, passioni, interesse teatrale erano contati per nulla. Ora si vedeva nell’assedio di Persepoli, capitale antica della Persia, una mina sotterranea, che coll’aiuto della polvere faceva andar in aria una parte della città, ora il leggiadro Alcibiade che veniva in sulle scene sopra un carrozzino alla moda preceduto da corrieri e da volanti. Alle volte Prassitele innamorato di Frine le donava in regalo un orologio da saccoccia di questi che si chiamano mostre; alle volte la stessa cortegiana compariva nell’Areopago di Atene vestita in maschera alla veneziana. Nel Clearco del , Clearco re della Colchide e protagonista del dramma comparisce ubbriaco in teatro, inciampa, cade, s’addormenta, e poi si sveglia vaneggiando. Nella Didone del , poeta veneziano, il primo atto comprende l’incendio di Troia; il secondo l’arrivo di Enea dopo sett’anni di navigazione e di travagli alle spiagge di Cartagine dove s’innamora di Didone; nel terzo l’abbandona, Didone s’uccide, e Jarba diventa pazzo da uomo stimato prima il più saggio di tutti. V’erano dei drammi, e fra gli altri quelli di , fiorentino, dove per mezzo di gran caratteri mobili di fuoco si leggevano in aria degli anagrammi, dei bisticci, degli enigmi e delle divise allusive ai personaggi ch’erano presenti. Non si potrebbe senza infastidirne i lettori indicar tutte le sconvenevolezze di simil genere. personaggi fantastici, numi ed eroi mischiati tra buffoni, un miscuglio di tragico e di comico, che non aveva né la vivacità di questo né il sublime di quello, ne facevano allora il più cospicuo ornamento del dramma. Divenne un vezzo della poesia; anzi un costume l’introdurre dei serventi scilinguati e gobbi, che interrompessero con mille buffonerie gli avvenimenti più serii. Che bel sentire, per esempio, il seguente vezzosissimo soliloquio che fa Sifone nell’Ercole in Tebe:
«Go-go-go-gobo a me?Non mi conosci affè,Gente a vedere eroi po-poco avvezza;Io son colui che taglia, buca e spezza.Ho la lingua col restioMa per dar mazza che volaNo che gobbo non son io.Ma me-menti per la gola.Son ca-ca-camerataD’Ercole trionfante,E questo coso tondoSulle re-rene è un pezzo di quel mondo,Che regger gli aiutai col vecchio Atlante.Mi fece NaturaNel visoNarcisoE Marte in bravur:Pa-pa-ri è il valore alla bellezza:Io son colui, che taglia, buca e spezza.Con questa bizzarriaTutti di casa miaPadre, figlio, fratel, nonno e bisavoloVan cercando le risse a casa il dia-diadia-dia-dia. A casa il dia-dia acasa il diavolo»
bellezza che può essere agguagliata soltanto da quest’altro amabile dialoghetto fra Egeo e Demo nel tanto decantato Giasone di , fiorentino.
Egeo Re. E verso dove andranno?Demo balbuziente. S’imbarcano per co co, co, per co, co, co.Egeo. Per Coimbra?Demo. Per co, co, co, co.Egeo. Per Coralto?Demo. Oibó! Per co, co, co.Egeo. Per Cosandro?Demo. Nemmeno: per co, co, co.Egeo. Per Corinto?Demo. Ah! bene, beneMi cavasti di pene
[9] Gli amori introdotti sempre come principale costitutivo dei drammi non solo erano ricercali, falsi e puerili, ma in siffatta guisa indecenti che sembravano rappresentaci a bella posta sulle scene per giustificar il rimprovero che diè il Conte ai poeti italiani di quel tempo:
«Fatto è vil per lascivia il Tosco inchiostro.»
[10] Alcuni tratti scelti a caso ne faranno comprendere maggiormente lo spirito. In un’opera dell’, Socrate vuol cacciar via dalle scuole dove insegnava la filosofia una donna, che vi si era furtivamente introdotta. Ella resiste, il filosofo insiste, per dimesticare il quale la cortegiana, che conosceva per isperienza tutto l’impero delle proprie attrattive, si squarcia i veli, e gli mostra il seno scoperto. In un altro dramma del si legge un duetto dove due amanti dimandano, ricusano, ridomandano a vicenda e si danno dei baci. E quello che v’ha di più obbrobrioso si è che una musica tenera, voluttuosa e rinforzata dagli strumenti dava tutto l’agio possibile ai lazzi scandalosi degli attori. Nella Ipermestra del la castissima sposa, apostrofando alle labbra dello sposo, dice in piena udienza:
«Belle porpore vezzoseOnde Amore i labbri inostraPur son vostra:Di rubini almo tesoro,Mio ristoro, idolo mio,E che più bramar degg’io?»
indi affrettando la notte troppo lenta ai pudici suoi desideri, ripiglia:
«Graditi orrori,Coprite il dì:Ammantate sì sì l’eterea moleSe fra l’ombre degg’io godere il Sole.»
[11] Nella Dorinda d’un poeta sconosciuto si trova un monologo fatto ad imitazione di quello d’ nel Pastor fido, dove fra le altre cose Dorinda dice:
«Niso amato ed amante,Se giugnesti a veder quanto mi costaQuesto finto rigore,So che avresti pietà del mio dolore.Anch’io vorrei potendoArciera fortunataDall’arco di due labbraScoccar contro il tuo sen dardi amorosiE delle braccia mieFar zona al fianco tuo salda, e tenace;Ma, sopportalo in pace,Forse verrà quel giornoIn cui del fato a scornoPotrai, caro Ben mio,Stemprare in vivo fuoco il tuo desio.»
[12] Circa lo stile a tutti è nota la viziosa maniera ch’erasi in Italia per ogni dove introdotta. Il lettore può senza scrupolo cavare una conseguenza intorno al gusto generale del secolo dal seguente squarcio di un monologo tratto da un dramma che fu con sommo applauso rappresentato in pressoché tutti i teatri d’Italia, il quale divenne lavoro pregiatissimo d’un rinomato poeta. Egli è Ercole, che indirizza in questa guisa il discorso alle donne:
«Donne, coi vostri vezziChe non potete voi?Fabbricate nei criniLabirinti agli eroi.Solo una lagrimettaChe da magiche stille esca di fuore,Fassi un Egeo cruccioso,Che sommerge l’ardir, l’alma e il valore;E il vento d’un sospiroEsalato dai labbri ingannatori,Dai campi della gloriaSpiantò le palme, e diseccò gli allori.»
[13] Se tal era il linguaggio riserbato ad un semi-deo, ognun prevede in quale stile si doveva far parlare gli uomini. Nell’Elio Pertinace dell’ havvi un personaggio che si spiega pei seguenti termini:
«Orologio rassembra il mio cuoreDi quel sole, ch’è l’anima miaServe d’ombra crudel gelosia,E di stilo spietato rigore.S’egli è a polve, la polve è l’arena:S’egli è a ruota, la ruota è il tormento,E del tempo misura è la pena,Ma la pena non passa con l’ore.»
[14] Il mentovato verso la metà del secolo trasferendo al melodramma i difetti soliti allora a commettersi nelle altre poesie drammatiche, accoppiando in uno avvenimenti e personaggi seri coi ridicoli, interrompendo le scene in prosa colle poeti che strofi, che arie s’appellano, e mischiando squarci di prosa alle scene in verso, confuse tutti gli ordini della poesia, e il melodramma italiano miseramente contaminò. Fu nondimeno tenuto a’ suoi tempi per ristorator del teatro: i suoi drammi furono ristampati non poche volte come cose degne di tenersi in gran pregio: i letterati sel proponevano per modello d’imitazione, e le muse anche elleno, le vergini muse concorsero a gara per onorar con inni di laudi chi più d’ogni altro recava loro vergogna ed oltraggio. Tanto è vero che il giudizio de’ contemporanei è poco sicuro per gli autori, come lo è pei sovrani; che il pregiudizio a quelli, a questi l’adulazione tributano sovente degli omaggi insensati, o talvolta l’invidia gli calpesta con ingiuste criminazioni; e che alla imparziale posterità solamente appartiensi il diradar con quel raggio di luce regolator del pubblico sentimento la nebbia che intorno agli oggetti si sforzano d’avvolgere le nostre passioni.
[15] Però non si può immaginare al mondo cosa più bislacca di
codesto ramo della poesia teatrale, onde esattamente la diffinì il Marchese «un’arte storpiata in grazia d’un altra, e dove
il superiore miseramente serve all’inferiore, talché il poeta quel luogo ci tenga che
tiene il violinista ove suoni per ballo»
78. Non giudico pertanto
pregio dell’opera il trattenermi intorno agli autori che scrissero in secolo così
sventurato79 né intorno ai
titoli dei drammi loro, de’ quali può a ragione asserirsi che ne perisse la memoria col
suono. Chi tanto abbondasse d’ozio e di voglia troverà ampiamente nel di che soddisfarsi. Aggiugnerò soltanto che fra i
moltissimi componimenti che mi è convenuto leggere per formarmi una giusta idea del
gusto di que’ tempi, a fatica ho trovato alcuni pochi che non partecipano quanto gli
altri della universal corruzione. Questi sono que’ d’, il quale meglio d’ogni altro seppe dopo il far versi accomodati alla musica, alcuni del Conte
, dell’, del , il
Trionfo d’Amore di , e pochi
altri.
[16] Minore fu il contagio nelle opere buffe sì perché avendo in esse meno luogo il maraviglioso più ne rimaneva pei caratteri, e sì perchè il loro stile più vicino al familiare non ammetteva le frascherie e gli stravizzi dell’eroico. Perciò si trovano alcune degne di miglior secolo, e quali a stento si vedrebbono nel nostro. Darò per saggio la Verità raminga di fornita di sollazzevole critica con pittura di caratteri assai bene delineati. Il tempo fa il prologo. Escono un medico e uno speziale, che si rallegrano scambievolmente di ciò che i mali degli uomini fanno il loro guadagni, e che la terra seppelisce tutti i loro spropositi. La verità comparisce avanti chiedendo loro aita per trovarsi tutta pesta, e mal concia dalle mani de’ procuratori e degli avvocati, ma accorgendosi chi ella è, la sfuggono, dicendo:
«A duo. E tu sei la verità?Va pur via fuggi di qua.Medico. Chi sapesse ben il veroDel mestieroDi chi va cercando i maliManderebbe alla mal’oraTutti i medici, e spezialiPer goder la sanità.Via pur via fuggi di quà.»
Un cavaliere accorre al pericolo per difenderla, ma riconoscendola per dessa l’abbandona al momento.
«Vanne, vanne da me,Che se solo consiste il far il grandeIn bravar a credenza:Se solo e un’apparenzaQuesta che oggi si chiamaCavaglieresca vita:Se tu fossi tra noi saria spedita.»
Un soldato fa la medesima cosa perché la verità lo beffeggia per le sue millanterie. Otto villani, che ballano al suono d’una bizzarra sinfonia di zucche, la scacciano da sé parimenti:
«Vanne pur, vattene via,Non entrar in questa cricca,Se chi dice il ver s’impiccaNon sei buona compagnia.Tutti. . Non vogliam di questa razza:Dalle dalle, ammazza, ammazza.»
[17] Nella seconda parte (poiché in due sole è divisa) viene un mercante, il quale fra le altre recita la seguente arietta:
«Al Perù che occorre andare,E disagi ognor soffrire:Basta solo esercitareIl mercante, e poi fallire:Questo è il modo d’arricchireInventato da più scaltri,Far a mezzo di quel d’altri.»
Esce in seguito un sensale, per la cui opera il mercante vorrebbe disfarsi della sua coscienza come di merce scomoda per sé e affatto inutile, ma il sensale si scansa adducendo per motivo che:
«Questa roba non ha spaccio:Oggi più non se ne tratta,All’usanza non è fatta,A chi l’ha serve d’impaccio.»
A loro altresì ricorre la verità, ma, come può ben credersi, ambedui la sfuggono. Si presenta alle dame ma con eguale riuscita. La loro risposta è:
«Sebben conforme è il sessoNon è il genio lo stesso;Tu del finger non sai la nobil arte.Nobil arte alla fè,Queste s’ingegnan soloFar comparir altrui quel che non è.»
Finalmente Talia, che è la musa del teatro, l’accoglie, ma solo a condizione che la verità, se vuol comparir in pubblico, dovrà cangiar abito, sembianze, favella, e maniere.
«Così forse avverrà che mascherataPiù dal mondo scacciataNon sia la verità.»
Infatti alcuni buffoni chiamati da Talia dopo aver riverita la verità finiscono con un ballo allegro.
[18] Frattanto la musica faceva pochissimi progressi. Dai surriferiti inventori del melodramma fino a più della metà del Seicento non si trova un solo maestro che abbia promosso d’un passo la espression musicale. Il desiderio di variare, d’alterare, di far delle repliche, delle fughe, de’ rovesci, e altri simili avanzi della fiaminga ruvidezza erano il gusto allor dominante, nel quale ebbe gran nome il tenuto perciò dagl’intelligenti piuttosto come buon contrappuntista che come buon musico. L’armonia era ben concertata, e spiccava la pienezza degli accordi, ma niuno, o pochissimo studio si metteva nell’osservar la relazione tra la parola e il canto, e nel perfezionare la melodia. Tale a un dippresso era lo stile del , del , del , del , del , del , ed altri, eccettuato che seguitò più da vicino le pedate del e del , e che avrebbe fatto epoca nella storia della musica scenica come la fece nella madrigalesca se i principi di quella fossero stati meglio conosciuti a’ suoi tempi. Un nobile tedesco chiamato dimorante allora in Italia insieme con inventore di nuova sorte di tastatura negli stromenti, con , con , romano, con , con , con , celebre suonatore d’arpa, e di violino, introdussero nella musica strumentale mille chiamato da loro galanterie, che si riducevano a trilli, strascichi, tremoli, finte, sincopi e tal cose, che accrebbero maggiormente la corruzione. Uno dei vezzi musicali più stimati a quel tempo era di esprimere colla possibile evidenza il romore materiale degli oggetti compresi nelle parole. Non si può meno di non ridere nel vedere nella musica fatta dal sul dramma intitolato il Podestà di Coloniola affaccendato sommamente il compositore per rendere cogli strumenti il suono dei rispettivi animali descritti ne’ seguenti versi:
«Talor la granocchiella nel pantanoPer allegrezza canta qua quarà:Tribbia il grillo tre, tre, tre:L’agnellino bè, bè, bè:L’assiuolo uhu, uhu, uhu,Et il gal cucchericcù;Ogni bestia sta gaia, io sempre caricoDi guidaleschi a ugni otta mi rammarico.»
[19] Come non può a meno di non recar meraviglia la pena che si prese il , compositore ignoto d’un più ignoto componimento rappresentato in Bologna, e che aveva per titolo L’Amore in cucina, di esprimere colla orchestra il suono del papagallo e dell’artiglieria unicamente perché nel dramma si faceva menzione del canto dell’uno, e un personaggio diceva dell’altra.
«Io del cannone al suonSolo risponderò bun - ban - bun - bon».
[20] Siffatta mediocrità delle cose musicali proveniva da varie
cagioni. Il piacere, che gustava il popolo nelle macchine e nelle decorazioni, faceva
che si stimasse più un buon macchinista che un poeta o un musico: quindi mancò
l’emulazione tra i professori, la quale non si riscalda, ove il pubblico grido non la
risveglia. Nel secolo antecedente, secolo di attività e d’invenzione, erano usciti alla
luce parecchi trattati eccellenti indirizzati a migliorare la musica. Vi furono delle
gare e delle dispute celebri tra e
il . Si tentarono tutti i mezzi di trasferire
alla musica moderna le impareggiabili bellezze dell’antica, nel qual tentativo si
distinsero il , il , il , il , il
con altri minori, ma nulla vi fu di ciò fino alla metà del Seicento, onde mancò a’
musici la istituzione convenevole. Gli è vero che visse a que’ tempi , scrittore grandissimo, il quale solo
varrebbe per tutti, ma la più bella tra le opere sue, e la più acconcia a spargere il
buon gusto, cioè il Trattato della musica scenica, rimase fra le tenebre
inedita fino a’ nostri giorni. Anche il celebre gesuita mandò l’anno 1650 in luce la sua Musurgia, opera
ove s’imprende a trattare tutta, quanta è, l’armonica facoltà, ma che incontrò la
disapprovazione degli scienziati pei molti abbagli presi dall’autore, e per l’infedeltà
nel tradurre i musici greci. critico
di prima sfera fortemente il riprende di ciò, stendendo la sua accusa a tutta
l’Italia, e «maravigliandosi (sono
le sue parole) che non solo dal più celebre paese del mondo ma da uomo così
famoso potessero venir fuori cotante inedie. Che se in questa guisa s’anderà avanti
nello studio delle lettere e dell’antichità, ben tosto, cangiato l’ordine delle cose,
vedrem la barbarie sortita dalla coltissima regione d’Italia
diffondersi per tutta l’Europa»
80. Per rimuovere
dalla sua nazione un rimprovero così umiliante fatto da uno scrittore il più capace di
giudicare di quanti fossero allor tra i viventi, s’ingegnò , perugino, nella sua Storia della
musica81 di far
vedere che i musici e i compositori italiani che fiorivano in
Roma allorché si pubblicò ivi la Musurgia, niuna
mano aveano avuta in quell’opera, cosicché gli errori giustamente ripresi nel a lui doveano imputarsi, non già
all’Italia. Ma, così parlando il , o ingannò se stesso, o volle gittar la polvere sugli occhi a’
lettori: imperocché basta scorrer soltanto di volo le due prefazioni poste dal avanti alla Musurgia per veder ivi
espressi i nomi di quelli stessi compositori romani citati dal con più altri assai de’ più famosi, i quali o consultati, o
pregati, o con musica, o con trattato, o in altra maniera concorsero al compimento di
quell’opera, di che l’autore ne ricava per essa un buon augurio di durevole fama.
[21] La terza e principal cagione fu il dicadimento della poesia, giacché tale è il vincolo che passa fra codeste due facoltà sorelle, che, ove l’una si guasti, è pressoché indispensabile che si corrompa anche l’altra. Con parole vuote d’interesse e di affetto non poteva congiungersi se non musica, che nulla esprimesse, e quando il sentimento era carico di concetti viziosi o puerili, l’armonia non sapeva aggirarsi se non intorno ad ornamenti superflui. Aggiungasi inoltre che i versi piccoli di quattro e cinque sillabe soliti a usarsi allora ne’ drammi mettevano i compositori in necessità di valersi di note minutissime, lo che rendeva la musica stemperata, e che la frequenza de’ versi rimati gli costringeva a far sentir troppo spesse, e vicine le consonanze, lo che la rendeva monotona.
[22] Dallo stato svantaggioso in cui si trovava la musica e la poesia, presero occasione i cantanti di uscir di mano a’ poeti e ai compositori, e di rapirsi il primato in teatro, rivolgendo a sé l’attenzione del pubblico . , del quale si è parlato a lungo di sopra, era stato il primo a raffinar il canto monodico, introducendovi non pochi ornamenti di passaggi, trilli, gorgheggi, e simili cose, le quali saggiamente e parcamente adoperate contribuirono a dar espressione e vaghezza alla melodia. Questa maniera coltivata in appresso con molta grazia da Giuseppe Cenci, fiorentino, per cui divenne assai celebre dentro e fuori della sua patria, fu poi condotta a maggior perfezione da Lodovico chiamato il Falsetto, dal Verovio, dall’Ottaviuccio, dal Niccolini, dal Bianchi, dal Lorenzini, dal Giovannini, e dal Mari cantori bravissimi, ma principalmente da una singolar genia di persone, che cominciò nel secolo decimosettimo a comparir sulle scene.
[23] Nel principio delle drammatiche rappresentazioni in musica il carattere di soprano era per lo più eseguito da fanciulli. Ma l’ingrossamento della voce, che succedeva in loro col crescer dell’età, e la difficoltà che si trovava nel conseguire, ch’eglino dassero al canto tutta quella espressione d’affetto, della quale non sono capaci gli anni più teneri, costrinsero i direttori degli spettacoli a prevalersi degli eunuchi. La relazione sconosciuta, ma da tutti gli anatomici avverata, che passa tra gli organi della generazione, e que’ della voce, impedisce in colpco, cui vien proibito lo sviluppo ulteriore del sesso che s’ingrossino i ligamenri della gola per la minor copia di umori che vi concorre, gli rende più atti a vibrarsi, e conseguentemente a eseguire le menome graduazioni del canto, assottiglia l’orifizio della glottide, e la dispone a formar i tuoni acuti meglio degli altri. Cotali circostanze doveano dar ad essi la preferenza in teatro. Non può dirsi a punto fisso l’epoca della introduzion loro. Da una bolla di Sisto V indirizzata al Nunzio di Spagna si ricava che l’uso degli eunuchi era molto comune in quella nazione probabilmente per la musica delle chiese o per quella di camera. Dico probabilmente, poiché sebbene la surriferita bolla nulla indichi di ciò (riguardando soltanto l’abuso introdottovisi, di congiungersi gli eunuchi in matrimonio colle donne) non apparisce per qual altro motivo si potessero permettere. Da una lettera del celebre viaggiatore Pietro della Valle a Lelio Guidiccione scritta nel 1640 si vede ch’erano di già comunissimi sulle scene italiane a quel tempo. Il trasporto di codesta nazione pel canto e le voci di tai cantori proporzionate alla mollezza, o per dir meglio, alla effemminatezza della nostra musica mi fa credere che gl’Italiani se ne prevalessero subito dopo l’invenzione del melodramma. I più famosi in allora furono Guidobaldo, Campagnuola mantovano, Marco Antonio Gregori, Angelucci, e sopra tutti Loretto Vittori, di cui eritreo fa tali elogi, che sembrano ad uom mortale non poter convenire82.
[24] Egli è un problema assai difficile a sciorsi se convenga o no alla morale pubblica che le donne rappresentino negli spettacoli. L’esempio degli antichi Greci e Romani, che escluse le vollero costantemente; il rischio, cui si espone la loro virtù esercitando una professione, ove per un orribile ma universal pregiudizio, non ha alcun vantaggio il pudore, ove tanti ne ha la licenza; l’ascendente che prendono esse sugli animi dello spettatore non meno contrario al fine del teatro, che pericoloso al buon ordine della società; la mollezza degli affetti, che ispirano coi loro atteggiamenti espressivi di già troppo avvalorata colla seduzione naturale della bellezza e del sesso; lo spirito di dissipamento che spargono fra giovani scapoli, i cattivi effetti del quale si risentono in tutti gli ordini dello stato politico, sembrano legittimar il divieto ad esse pur fatto sul principio delle drammatiche rappresentazioni in Italia di comparir sul teatro. Ma dall’altra parte i disordini forse maggiori che nascevano dal sostituir invece loro giovinastri venali e sfacciati, ai quali, dopo aver avvilito il proprio sesso coi femminili abbigliamenti, non era troppo difficile il passaggio ad avvilir la natura eziandio; la influenza grande nella società, e maggiore in teatro, che i nostri sistemi di governo permettono alle donne, dal che nasce, che essendo elleno la parte più numerosa e la più pregiata degli spettacoli, cui vuolsi ad ogni modo compiacere, amano di vedere chi rappresenti al vivo in sul teatro i donneschi diritti; l’amore, il quale per cagioni che non sono di questo luogo, è divenuto il carattere dominante del moderno teatro e che non può debitamente esprimersi, né convien che si esprima da altri oggetti, che da quelli fatti dal ciclo per ispirarlo; la ristrettezza de’ nostri teatri picciolissimi a paragon degli antichi, dove la distanza che passa tra gli attori e gli spettatori è tale, che i personaggi non possono agevolmente prendersi in iscambio, e dove troppo è difficile il mantener l’illusione; altre cause insomma facili a scoprirsi dal lettore filosofo costrinsero alla perfine i saggi regolatori delle cose pubbliche ad ammetter le donne sulle scene. La qual permissione tanto più divenne necessaria nel dramma quanto che non ci era maniera di supplire per altro verso alla dolcezza delle voci loro così acconcie ad esprimere e comunicare gli affetti, primo e principale scopo del canto. Trovasi per ciò di buon’ora stabilita cotal usanza, e celebri si resero in Mantova la Muranesi e la Martinelli, sul sepolcro della quale si legge tuttora una elegante e patetica iscrizione latina fatta scolpire dal duca Vincenzo suo protettore ed amante83. In Firenze levarono grido le due Lulle Giulia, e Vittoria assoldate dalla corte colla Caccici figliuola di uno degl’inventori del melodramma, e altrove le Lulle, la Sofonisba, la Camilluccia, la Moretti, la Laodamia del Muti, le Valeri, le Campane, le Adriane con altre che furono con indicibil plauso sentite in diversi teatri d’Italia. Allora sdegnando il volgar nome di cantatrici e di cantori prederà quello di virtuose e di virtuosi per distinguersi anche dagl’istrioni, coi quali non vollero più accomunarsi. Allora l’utilissimo talento di gorgheggiar un arietta divenne una strada sicura per giugnere alle ricchezze ed agli onori, e ne fu dal popolo riguardato collo entusiasmo medesimo, con cui avea ricevuta in altri tempi Vetturia, allorché liberò Roma dal giogo di Coriolano, ovver Pompeo conquistatore dell’Asia e di Mitridate84.
[25] Tuttavia la maniera di cantare che regnava nell’universale,
non sembra che meritasse cotanti applausi. A eccezione di que’ pochi mentovati di sopra
gli altri cantori si erano di già lasciati infettare da quel vizio che ha pressoché in
ogni tempo sfigurata la musica italiana, cioè gli inutili e puerili raffinamenti. I
ghiribizzi della musica e della poesia si trasfusero nel canto eziandio, né poteva
avvenire che la melodia fosse naturale, ove le note e le parole nulla significavano.
Sentasi come parla uno scrittore contemporaneo, il quale, dopo aver ragionato alla lunga
dei difetti del canto, soggiugne: «Mentre i nostri cantori cercano di schivare la
durezza e la troppa sterilità delle modulazioni, le stemperano poi e le triturano in
maniera che si rendono insopportabili. Dal qual morbo sono particolarmente attaccati
gl’Italiani, i quali, credendo se stessi i Virimagni della facoltà, stimano il
restante degli uomini altrettante pecore o tronchi. Ciò gli fa meritevolmente ridicoli
agli occhi degli stranieri: non so se questi giudichino con piena cognizione di causa,
ma so che almeno non cadono in simili inedie così frequentemente»
. Non è colpa
mia se il testo surriferito è alquanto sfavorevole all’Italia.
Basti sapere per mia difesa, che l’autore non è uno straniero, ma un italiano, e un
celebratissimo italiano. Egli è il mentovato 85.
Fine del Tomo Primo.
[Permissione] §
NOI RIFORMATORI
dello studio di padova.
[1] Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gip: Tommaso Mascheroni Inqusitor General del Sant’Offizio di Venezia nel Libro intitolato: Le Rivoluzioni del teatro Musicale italiano ec. di Stefano Arteaga, Stampato; non v’esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro principi, e buoni costumi concediamo Licenza a Carlo Palese, Stampator di Venezia, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle pubbliche Librerie di Venezia* e di Padova.
Registrato in Libro a Carte 161. al num. 1437
Tomo secondo §
Capitolo nono §
Secol d’oro della musica italiana. Progressi della melodia. Valenti compositori italiani. Scuole celebri di canto, e di suono col vario loro carattere.
[1] Lo spettacolo dell’opera tutto insieme piaceva nondimeno agli Italiani ad onta de’ suoi difetti sì per la novità, sì perché non ne avevano un altro migliore. Avendo perduta intieramente l’idea del teatro antico, e non vedendo sul moderno, se non se tragedie e commedie piene di mille assurdità, era ben naturale che s’appigliassero al melodramma, in cui trovano un ampio compenso. Se il cuore non vi si mischiava per nulla, gli occhi almeno trovavano il loro pascolo, e se il terrore e la pietà non laceravano gli animi degli spettatori, si sentivano essi rapiti dall’ammirazione, il quale affetto sostituito ad ogni altro rendeva pregievote uno spettacolo contrario per se stesso al buon senso. I suoi difetti erano riputati altrettante bellezze, e si metteva come pregio intrinseco del componimento la sfoggiata pompa del macchinista, la quale faceva perder ogni suo effetto alla musica e alla poesia senza riflettere, come osserva un grandissimo ingegno, che quest’apparente ricchezza altro non era che povertà, nella medesima guisa che i fiori sparsi innanzi al tempo sulle campagne indicano per lo più la sterilità del terreno.
[2] Tuttavia non poteva a meno di non avvenire che fra le tante lascivie dell’arte, ond’erano ingombrate la musica e la poesia, non sortisse alle volte dagli strumenti qualche suono, il quale penetrasse più avanti nell’animo, e qualche tratto non infelice dalla penna de’ poeti. La natura ha questo di proprio, che basta che ci si mostri nel suo vero aspetto, perché tosto faccia nascer vaghezza di sé. Ecco il momento della rivoluzione. I poeticominciarono a conoscere che si potevano interessare gli animi a preferenza degli occhi, e s’avvidero i musici che la possanza dell’arte loro avvegnaché ne abbia per fondamento gli accordi e le leggi armoniche, era nondimeno riposta principalmente nella melodia.
[3] Essa in fatti è la sola che fa che la musica divenghi un’arte imitatrice della natura, esprimendo colla varia successione de’ tuoni e delle note i diversi accenti delle passioni. Essa è quella che adoperando i muovimenti or rapidi, or lenti, or con debita misura sospesi, ci strappa le lagrime nel dolore, affretta il corso del sangue nell’allegrezza, ci fa smarrire nell’abbattimento e ci determina alla speranza, al timore, al coraggio, ed alla maninconia. Essa è che riproducendo le sensazioni, che in noi risvegliarono le immagini rappresentative degli oggetti fisici, sa dipingere il mormorio d’un ruscello che scorre lentamente fra l’erbe, e lo strepito d’un torrente che romoreggia precipitato dalle montagne, lo spavento d’una tempesta, e il susurro voluttuoso d’un fresco venticello, gli urli delle Furie e il sorriso delle Grazie, la maestà e il silenzio della notte, o l’allegrezza d’un meriggio rischiarato dal sole. Essa è l’unica parte della musica che cagioni degli effetti morali nel cuor dell’uomo, i quali oltrepassano la limitata sfera dei sensi, e che trasmette a’ suoni quella energia dominatrice che ne’ componimenti s’ammira de’ gran maestri. La quale non altronde deriva se non se dal prendersi le inflessioni musicali come altrettanti segni delle nostre affezioni e delle nostre idee: dal che nasce che risovvenendoci degli oggetti, che vengono per mezzo di esse rappresentate, ci sentiamo parimenti agitare da que’ movimenti medesimi che avrebbe in noi eccitati la presenza loro. Essa è finalmente quella che sottopone, a così dire, l’universo all’imperia dell’orecchio, non altramente che il sottopongano la pittura e la poesia, quella al giudizio degli occhi, e questa a quella della immaginazione.
[4] Tutto ciò non può ottenersi dalla semplice armonia considerata in se stessa: imperocché, consistendo principalmente nelle proporzioni equitemporanee dei suoni, è atta bensì a formare un accozzamento gradevole, che diletti l’udito; ma non può sollevarsi fino al privilegio d’imitar la natura, colla quale l’unione degli accordi non ha se non se una relazione troppo lontana, né può avere una influenza notabile sugli affetti, che è il vero scopo della musica teatrale. Nella stessa maniera che le sole regole della grammatica faranno bensì un discorso pura e regolato, ma non saranno giammai sufficienti a formar uno scrittore eloquente. La forza degli argomenti, la convinzione dello spirito, l’eccitamento delle passioni, farte insomma di persuadere sebbene non possano ottenersi senza osservar la sintassi, non è perciò che dalla sintassi in tal modo dipendano, che basti l’averla osservato perché altri divenga oratore. La rettorica è quella che disponendo a sua voglia delle regole e delle parole, e servendosi di esse come di veicoli delle idee, comunica loro quella espressione, che da sé sole non avrebbero fra le mani di un grammatico. Ora come la melodia è per la musica ciò che la rettorica per il linguaggio, così l’armonia è per i suoni ciò che la sintassi per il discorso. Può essa concorrere dal canto suo a produr la espressione ora ordinando con certa regola i suoni, come la grammatica ne adatta i vocaboli, ora unendo con alcune leggi di modulazione la succession loro, come l’ortografia ne distingue i periodi, ora rendendo più giuste le intonazioni per mezzo degli intervalli, come la sintassi rende più intelligibile l’orazione per mezzo delll acconcia collocazione delle parole, ora assoggettando al sistema generale dei suoni le inflessioni difettive e vaganti, non altrimenti che la grammatica tenta di accomodare ai precetti generali le anomalie de’ nomi e de’ verbi. Ma fintantoché il compositore resterà fra cotai cancelli, la musica non avrà né vita né spirito, l’accento spontaneo e naturale delle passioni si convertirà in un intervallo armonico, il quale, appunto perché è figlio dell’arte, non produrrà il menomo effetto sul cuore, che mai non vien mosso da proporzioni astratte o da semplici ragioni numeriche, restringerà ad un picciolissimo numero di modi le varie e moltiplici inflessioni delle quali è capace il linguaggio dell’uomo appassionato, impoverirà di molto l’eloquenza musicale parte escludendo una folla di suoni attissimi a commuovere unicamente perché non entrano nel sistema arbitrario dell’armonia, parte levando a quelli che restano il mezzo più possente della espressione, che è quello di parlar all’anima nostra un qualche linguaggio, e di rappresentarle un oggetto determinato. Imperocché ove la musica non mi farà sentire che intervalli, consonanze, proporzioni, accordi, e rapporti, ove tutta la sua possanza si ridurrà a titillare unicamente i nervi auditori con certe vibrazioni metodiche e insignificanti, io applaudirò bensì alla scienza del musico, ammirerò quell’algebra sonora, come ammiro i calcoli di Ricatti e d’Eulero, goderò tinche dello stesso materiale diletto che mi arrecano i gorgheggi d’una lecora o d’un canario, ma rassembrerò altresì a que’ vecchi descritti da , che formavano il consiglio di Priamo, i quali ammiravano la bellezza di Elena senza sentirsi commossi, perché non vi ravviserò punto quel principio d’imitazione, che di tutte le belle arti ne è il fondamento, non troverò alcun segno di convenienza tra gli accordi armonici e le mie proprie affezioni, né sentirò ricercarmi l’anima e il cuore da quei movimenti improvvisi e forti, che dalle arti di genio ha ogni uomo sensibile diritto di esigere. Come i colori accozzati su un quadro niun effetto cagionano senza il disegno che è lo spirito vivificante della pittura, così la combinazione de’ suoni nulla giova a interessare senza la melodia. L’immagine delle nostre passioni e degli oggetti che le mettono in esercizio, lo specchio delle nostre idee e de nostri sentimenti rinovellato alla memoria per mezzo del canto, o della sinfonia: ecco l’unica via d’intenerirci, di smuoverci, e di render viva, ardente, ed energica la favella musicale. Tal ne è la cagione eziandio per cui rimanendo freddo e indifferente lo spettatore alla veduta d’un bosco o d’un deserto espresso sulla tela da un valente pennello, non rimane altresì ozioso nel sentire una voce che canti in quella solitudine o in quel boschetto. Le frondi degli alberi, l’albeggiante azzurro dell’orizonte, le punte delle roccie inerpicate, le lontananze e i chiaroscuri delle valli dipinti sul quadro sebbene invaghiscano l’occhio de’ riguardanti, nulla dicono però allo spirito loro; laddove una voce solitaria, che risuoni dolcemente nel silenzio di solinga valle, annunzia tosto a chi l’ascosta, che colà soggiorna un essere socievole, compagno nelle sciagure e nei diletti, e creato al paro di lui dalla natura per fruir l’aura della vita, e per godere le delizie dell’universo.
[5] Talmente incominciarono a pensare i compositori italiani. O fosse che la riflession gli portasse a così interessante scoperta, o si lasciassero essi condurre da quell’intimo sentimento del bello che genera il gusto e che vien generato dall’istinto, o nascesse ciò dalla perpetua e inalterabile oscillazione, per cui le facoltà appartenenti alla immaginazione, e alla sensibilità passano dal pessimo stato al mediocre, e dal mediocre all’ottimo per ricader di bel nuovo nel pessimo; certo è che il cuore riacquistò i suoi diritti, che dai sensi gli erano stati ritolti, e che la musica da un puro accozzamento di suoni divenne un’arte imitativa capace di esprimere tutte le passioni e di rappresentare tutti gli oggetti. Il primo benché debole cangiamento venne dalla ecclesiastica. , , , e il rinomatissimo cominciarono in Roma i primi a ripolire alquanto e simplificar l’armonia dagl’ispidi intrecci del contrappunto, a concertar con più esattezza le parti, a connetter fra loro i passaggi secondo il luogo, che debbono occupare nella modulazione, a scegliere e regolare gli accordi secondo la relazione che hanno essi col tutto. , inventando il basso continuo, così chiamato perché dura tutto il tempo della composizione, inventò parimenti con siffatto mezzo la maniera di regger meglio l’armonia, di sostenere la voce e di conservar i tuoni nella debita proporzione e giustezza. Così la misura prese a poco a poco un andamento più regolare, il tempo divenne più esatto e più preciso, e il ritmo musicale acquistò una cadenza sensibile attissima à farne spiccar maggiormente le progressioni del movimento e della misura. Con tali preparativi la declamazion musicale, ovvero sia il recitativo, confuso fin’allora col canto, o non abbastanza distinto, divenne un genere di per sé, che acquistò peculiar forma e leggiadria. , illustre compositore romano dopo la metà dello scorso secolo, cominciò a modular i recitativi con più di grazia e di semplicità, avvegnaché non vi si facesse allora particolar riflessione sì perché il gusto del pubblico rivolto intieramente alle macchine e alle decorazioni badava poco alla dilicatezza della composizione, come perché la poesia dei drammi così poco interessante faceva perdere il suo pregio, anche al lavoro delle note. Ma il vero stile della declamazion musicale si riconobbe più distintamente nelle opere di , fiorentino, il quale, passando in Francia nella piccola età di sei o sette anni, e apparando ivi l’arte di suonar il violino e di comporre per musica divenne portato dal grandissimo ingegno onde avealo fornita la natura, il corifeo della Francia. Lo che egli fece imitando la musica sacra qualmente si trovava allora ne’ bravi compositori italiani, e trasferendola al proprio idioma ed al teatro con quelle mutazioni che esigeva il genio dell’uno e dell’altro. Chi ha sentito eseguire i. celebri mottetti del e del da qualche bravo cantore, vi ravvisa per entro la sorgente onde ricavò il suo recitativo, se non in quanto lo svantaggio che ebbero quelli lavorando su parole sconnesse e mezzo barbare d’una lingua morta, non lo ebbe già il musico fiorentino cui toccò in sorte un poeta francese inimitabile.
[6] L’alta riputazione di Luigi Decimoquarto, ai cui servigi si ritrovava il , avendo richiamato alla sua corte il fiore delle altre nazioni nelle arti e nelle lettere, eccitò in particolar maniera la curiosità degli Italiani, i quali vi si portarono in folla spinti non meno dal desiderio d’imparare e di conversare cogli uomini grandissimi, che allora fiorivano in Francia, che di far mostra de’ propri talenti alla corte d’un sì gran re protettor dichiarato d’ogni sorta di merito, e divenuto assai più celebre per questo mezzo che per l’incomparabile sua fortuna nella guerra, o per la preponderanza acquistata sugli affari di Europa. Documento luminoso a’ sovrani per far loro conoscere che la sola maniera d’eternar il lor nome e di farsi adorare dai posteri è quella di rendersi veramente utili alla umanità, promovendo le arti che soddisfanno a’ bisogni degli uomini, e favoreggiando le scienze che perfezionano il loro spirito. La gloria delle armi e delle conquiste passa, come il fragore d’un turbine di cui non si conserva la memoria se non per le rovine che ci attestano della strage; laddove quella de’ principi che proteggono le cognizioni proficue inseparabili dal vero merito, dura come la quercia descritta da Lucano, che era la figliuola primogenita del bosco, riverita da’ pastori e abitata da’ numi, ai rami della quale appendevano corone di fiori le ninfe, e i capitani i loro militari trofei86.
[7] L’accennata circostanza unita alle liberalità del monarca e alla politica illuminata del suo ministro Colbert contribuì infinitamente ai progressi delle lettere non solo in Francia, ov’egli è indubitabile che arrivarono al maggior loro splendore, ma nelle contrade straniere eziandio. Imperocché, s’egli è vero, siccome apparisce chiaramente dalla storia del cuor umano, che l’interesse, l’emulazione e la gloria siano le tre leve più possenti a sollevare l’ingegno e ad affrettarlo nella carriera del sapere, codeste passioni si ritrovavano tutte grandemente lusingate a Parigi nell’epoca di cui parliamo. La munificenza d’un sovrano, che pagava con quattordici mila scudi un pessimo sonetto di , faceva con più ragione attendere non dissimili favori per sé ai belli spiriti tanto più bramosi nella pratica di ricchezze, e di un’agiata fortuna quanto più si mostrano disprezzatori di esse ne’ loro scritti; somiglianti appunto a que’ sacerdoti musulmani, di cui parlano i viaggiatori, i quali, predicando fervidamente ai turchi l’astinenza del vino, niun’altra cosa assaporiscono con tanto diletto quanto una bottiglia di eccellente liquore europeo. L’emulazione, quella figlia pericolosa dell’amor proprio, che alle volte partorisce l’invidia, alle volte genera l’eroismo, ma che divien necessaria in mancanza della virtù per far germogliar i talenti e per sollecitarli alle magnanime imprese, ne trovava aperto un vastissimo campo in tanti rivali illustri, su quali diveniva sommamente gloriosa la vittoria, e scusabile la sconfitta. Gli sforzi fatti adunque per superarli, o per distinguersi dovettero necessariamente portare ciascun’arte alla rispettiva lor perfezione, fra le quali la musica ebbe non mediocre fortuna. , con altri valenti Italiani emuli a Parigi e imitatori del riportarono al loro ritorno nella patria idee più chiare e più distinte dell’armonia. S’aggiunse a questa più giusta cadenza secondo il gusto lulliano, furono risecati i soverchi artifizi, si fecer camminare con maggior precisione e calore il movimento e la misura, e le aperture di molte opere italiane si lavorarono alla francese, il qual costume durò per più di vent’anni di qua dai monti fino al principio del secolo presente, checché ne dicano in contrario gli Italiani facili ad essere smentiti colla pruova delle carte musicali di que’ tempi. Allora si svegliarono dappertutto gli ingegni, ed ecco sorgere a debellar il gusto fiamingo, che da lungo tempo vi dominava, il , e il a Roma, il a Venezia, il a Bologna, il a Ferrara, e lo a Genova celebre non meno per l’abilità sua che per i suoi amori e tragico fine. Dietro alle pedate di costoro camminarono felicemente que’ grandi armonisti , l’, il , il famoso , e , bolognese, i quali sostennero con tanto decoro la gloria del nome italiano in Inghilterra in mezzo al grido che aveano meritamente levato in quell’isola le composizioni dell’. Gli Inglesi, che ad un vivo interesse per la patria loro sanno accoppiare quella imparziale filosofia che generalizza i sentimenti e le idee, e presso ai quali il titolo di straniero non è, come per tutto altrove comunemente, un titolo alla esclusiva, o un’arma di più contro al merito nelle mani dell’invidia, si prendevano talvolta il piacere di obbligar i tre professori a che suonassero in presenza del pubblico a gara in tre organi separati con proposte e risposte da una parte, e dall’altra, come già nell’antica Grecia si vedevano e , e , e concorrere nell’Odeon d’Atene a disputarsi fra i lietissimi applausi del radunato popolo ora il premio del tripode, ora il privilegio di recitar sul teatro i loro componimenti.
[8] Allora si coltivò l’espressione anima e spirito dell’arte, la quale è alla musica ciò che l’eloquenza al discorso: s’imparò a subordinare l’una all’altre tutte le diverse e moltiplici parti che la compongono, e a dirigere il tutto verso il gran fine di dipingere e di commuovere; si studiò con maggior cura l’analogia, che dee sempre passare tra il senso delle parole e i suoni musicali, tra il ritmo poetico e la misura, tra gli affetti che esprimono i personaggi, e quelli che rende il compositore; si sminuirono considerabilmente le fughe, le contrafughe, i canoni, e gli altri lavori simili, i quali sebben provino, allorché sono eseguiti esattamente, la ricchezza della nostra armonia e l’abilità del maestro, nondimeno sogliono per lo più nuocere alla semplicità ed energia del sentimento. Si badò soprattutto a conservar l’unità nella melodia regola fondamentale di musica, come lo è di tutte quante le belle arti, la quale consiste nel rivolgere verso un oggetto tutta l’attenzione e tutto l’interesse dell’uditore, nel rinforzar il motivo dominante, ovvero sia il canto della parte principale con quello di ciascuna in particolare, e nel far sì che l’armonia, il movimento, la misura, la modulazione, la melodia e gli accompagnamenti s’acconsentano scambievolmente, e non parlino, a così dire, che un solo linguaggio. Codesto pregio, che non sembra a prima vista né straordinario, né difficile ad ottenersi, è nullameno uno degli sforzi più grandi che abbiano fatto i moderni italiani. La difficoltà consiste nella natura de’ nostri sistemi musicali composti di moltiplicità di parti. Se ciascuna di esse ha il suo canto peculiare e distinto, come può darsi che suonando tutte insieme e contemporaneamente, a vicenda non si distruggano? Se per lo contrario le parti producono tutte un solo e medesimo canto, in qual guisa s’otterrà l’armonia, che è una combinazione equitemporanea di più modulazioni diverse?
[9] Tra i primi autori di sì felice rivoluzione debbono annoverarsi e , napoletani, nelle composizioni de’ quali incominciarono le arie a vestirsi di convenevol grazia e melodia, e fornite si veggono d’accompagnamenti più copiosi e brillanti. Il loro andamento è più spiritoso e più vivo che non soleva essere per lo passato: donde spicca maggiormente il divario tra il recitativo e il canto propriamente detto. Le note però e gli ornamenti sono distribuiti con sobrietà, in maniera che senza toglier niente alla vaghezza dell’aria, non rimane questa sfigurata dal soverchio ingombro. Il , mirabile nella forza e vivacità delle immagini, prese a perfezionar quella specie di composizione detta volgarmente recitativo obbligato, la quale per la situazione tragica che esprime, pel vigore che riceve dalla orchestra, e pel patetico di cui abbonda, è lavoro pregiatissimo della musica drammatica. L’ultimo atto della Didone abbandonata modulato in gran parte da lui a questo modo è preferibile a quanto han di più fiero e più terribile nella pittura i quadri di . Celebre parimente si rese bolognese abbastanza noto in Europa e per essere stato uno dei primi maestri nella musica di chiesa, e per aver fatto un grandissimo dono alle scienze armoniche nella persona di Fra il più illustre fra suoi discepoli. , napoletano, e aggiunsero maggior perfezione al recitativo strumentato quello pell’ammirabile facilità di canto che seppe dargli, questo pel maneggio degli strumenti attissimo all’espressione. , il gran Pergolesi, divenne inimitabile per la semplicità accopiata alla grandezza del suo stile, per la verità dell’affetto, per la naturalezza e vigore della espressione, per l’aggiustatezza ed unità del disegno onde vien meritamente chiamato il Raffaello e il della musica. Simile al primo egli non ebbe altra guida che la natura, né altro scopo che di rappresentarla al vivo,
«L’arte, che tutto fa, nulla si scopre.»
[10] Simile al secondo ei maneggiò con felicità incomparabile i diversi stili de’ quali si fa uso nella musica, mostrandosi grave, maestoso, e sublime nello Stabat mater, vivo, impetuoso e tragico nell’Olimpiade, e nell’Orfeo, grazioso, vario e piccante, ma sempre elegante e regolato nella Serva padrona, la quale ebbe il merito singolare, sentita che fu la prima volta a Parigi, di cagionare una inaspettata rivoluzione negli orecchi de’ Francesi troppo restii in favor della musica italiana. Niuno meglio di lui ha saputo ottenere i fini che dee proporsi un compositore; niuno ha fatto miglior uso del contrappunto, ove l’uopo lo richiedeva; niuno ha dato più calore e più vita ai duetti, questa parte così interessante della musica teatrale. Di che possono far fede l’inimitabile addio di Megacle e di Aristea nell’Olimpiade, e il lo conosco a quegli occhietti della Serva padrona, modelli entrambi di gusto il più perfetto cui possa arrivarsi in codesto genere. Egli insomma portò la melodia teatrale al maggior grado di eccellenza a cui sia stata finora portata, e se non ci fosse stato da troppo immatura morte rapito87 la quale gli proibì di potersi correggere di alcuni difetti annessi al genio ci avrebbe forse fatto vedere, che se la musica moderna non produce i maravigliosi effetti dell’antica, ciò non proviene dall’esser ella incapace di produrli, ma da mancanza delle nostre legislazioni, che non sanno convenevolmente applicarla. il giovane, , , , , , lucchese, , ed alcuni altri lavorarono all’esempio loro con ottimo gusto, benché con istili alquanto diversi, de’ quali però, non formando classe da per sé, ma riducendosi a principi esposti di sopra, non occorre il farne individualmente menzione.
[11] Come al rattiepidirsi della stagione nella primavera, il calore, che penetra nel centro della terra, va dilatandosi a poco a poco per tutti gli oggetti finché comprende e vivifica la intiera natura, così il buon gusto comunicato sul principio ad un genere si propagò ben tosto agli altri, che concorrono alla perfezione del melodramma. La strumentale fu la prima a partecipare del benefico influsso. È opinione avverata dalla esperienza e confessata dagli oltramontani eziandio, che il ridente cielo dell’Italia comunichi a gli strumenti una non so qual dilicatezza, che non si ritrova sotto gli altri climi di Europa. Forse ciò deriva dalla temperatura dolce e fervida insieme dell’aria, che domina generalmente in questo paese, la quale, rendendo più ben cotti, più aridi, e conseguentemente più leggieri i legni, e più elastiche le corde, è la cagione altresì che pesino meno e che più acutamente risuonino. Al che aggiugnendosi l’accento vivo ed appassionato degl’Italiani, che gli dispone in particolar maniera alla melodia e dolcezza di canto, non è da maravigliarsi se la musica strumentale, la quale non è che una imitazione più o meno vaga e generica della musica vocale, ne prende anche essa l’indole dilicata e leggiera del suo modello. Così si vede per pruova, che posta la stessa fabbrica degli strumenti, lirici o pneumatici che siano, e la stessa abilità ne’ maestri, si osserverà tuttavia dagli orecchi imparziali ed esercitati la soavità del suono italiano a preferenza degli altri.
[12] Se non che il miglioramento dell’arte del suono in
Italia non dee tutto ripetersi dalle accennate cagioni ma dalle
scuole eziandio che incominciarono a fiorire dopo la metà del passato secolo. Le più
celebri furono quella del , e non molto dopo
quella del . La prima, che ebbe origine dal
più grande armonista che mai ci sia stato di qua dai monti, spiccava principalmente
nell’artifizio e maestria delle imitazioni, nella destrezza del modulare, nel contrasto
delle parti diverse, nella semplicità e vaghezza dell’armonia. La superiorità nell’arte
sua e la facilità di piegarsi a’ diversi gusti di entrambe nazioni italiana e francese
procacciò al un nome immortale in tutta
Europa, quantunque un numero assai discretto di produzioni ci
abbia egli lasciate memore della massima di :
«Dipingo adagio perché dipingo per tutti i secoli»
. Lo stesso si riconobbe inferiore a lui, allorché spinto da bassa
e indegna gelosia si prevalse della grazia in cui si trovava presso alla corte di
Francia per iscacciarnelo da quel regno. Fra i rinomati
discepoli di questo grand’uomo la posterità annovera tuttora il bergamasco, il , e
il . Il primo compositore disuguale e fecondo
presenta agli amatori del bello musicale eccellenti esemplari d’imitazione nei maestosi
e patetici gravi lavorati in gran parte sull’esempio degli adagi del suo maestro, nelle
sue brillanti variazioni e soprattutto nelle suonate a solo, le quali sono la più
pregievol raccolta che ci resta della scuola corelliana. Ma i suoi
Capricii ripieni di operose stranezze, e inventati soltanto per aver il
vanto della difficoltà vinta, non dovranno servir di modello a chicchessia, se non se
allora quando l’imbarazzo gotico sarà preferibile alla greca semplicità. Il serberà chiara lungo tempo la sua memoria presso
agl’intelligenti a motivo della sua perizia nell’imitar lo stile del suo maestro, e
nella esecuzione, come il per la flessibile
leggerezza, uguaglianza, soavità e limpidezza del suo stile.
[13] Il gran si rese benemerito dell’arte per tutti que’ mezzi che contribuiscono all’avanzamento di essa. Fu pratico eccellentissimo, maestro sensato e distinto scrittore. In ogni cosa, che prese a perfezionare, ha saputo imprimere lo spirito d’invenzione e la natura riflessiva e sagace, cui portavalo il proprio temperamento. Ingrossando le corde del violino troppo fino allora sottili e fievoli, e stangandone alquanto l’archetto, raddolcì l’asprezza di quello stromento che sarebbe stridente di sua natura, e studiando sulla maniera di guidar l’arco di sotto e di sopra, di rallentarlo, d’affrettarlo, e di premerlo, giunse a trar fuori suoni dolcissimi, e maravigliosi. Spicca nei suoi componimenti quell’aurea schiettezza, quella unità di pensiero, quella incomparabile semplicità, quel patetico dolce e dilicato tanto graditi dalle anime gentili quanto difficili a ben difinirsi. Egli comprese in tutta la sua forza la verità del precetto d’.
«Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem.»
[14] Quindi aveva per costume di esser modesto e rattenuto in sulle prime per sollevarsi poscia bel bello fino a quel grado di espressione che caratterizza i suoi componimenti, e che altri assomiglierebbe alla musa del , di cui esso musico si dichiarava ammiratore grandissimo. Di ciò ne può far fede l’uso ch’egli aveva prima di mettersi a comporre di leggere e meditare un qualche sonetto di quel poeta a fine di riscaldar il suo ingegno alle pure fiamme di quel platonico e sublime amatore88. V’ha di quegli che l’accusano di soverchia parsimonia negli accompagnamenti, e certamente se si paragonano in codesto articolo i suoi componimenti a quelli degli altri, la differenza è troppo visibile, ma il difetto si dilegua ben tosto qualora si voglia riflettere, che lo stile tartiniano colorito di tinta finissima perderebbe forse ogni sua grazia, se gli si aggiugnessero in troppa copia, oppur caricati di soverchio gli accordi, come se alla linda venustà de’ puttini dell’ volesse un pittore accoppiare l’atteggiamento animoso di o la schietta nitidezza dell’Aminta del s’esprimesse collo stile lumeggiato e forte d’un o d’un .
[15] Per le fatiche di questi e d’altri valenti compositori l’arte degli accompagnamenti fu condotta alla maggior perfezione, e l’orchestra, parte così necessaria all’ottima riuscita del dramma, si vide disposta dagli uni e regolata dagli altri con incomparabile maestria. Non più si collocarono alla rinfusa gli strumenti, né si credette che il numero e la scelta di essi nulla avesse che fare colla espressione, ma si pensò bensì che l’una e l’altra di queste cose contribuissero assai a produrne il total affetto. Partendo dal principio della unità accennata di sopra, conobbero essi che essendo fatto non il canto per gli strumenti, ma piuttosto gli strumenti pel canto, non doveano quelli primeggiar sulla voce del cantore, ma regolarla soltanto, sostenerla, e rinvigorirla; che essendo ciascuno stromento necessario in parte al fine propostosi, non dovea l’uno impedir l’azione dell’altro cosicché il basso, per esempio, affogasse la voce di tutta l’orchestra, o gli stromenti da fiato signoreggiassero su quelli da corda, o questi all’incontro su quelli; che non convenendo mischiare fra loro suoni di diversa natura, faceva di mestieri collocar insieme gli strumenti della medesima spezie, acciò si accordassero meglio e con maggior esattezza suonassero; che i bassi però si dovessero interpolare or qua or là per tutta l’orchestra, giacché da essi dipende la movenza, e l’andamento d’ogni buon’armonia; che non essendo a proposito qualunque sgomento per produrre qualunque suono, bisognava studiar bene la natura di ciascuno per meglio combinarli fra loro, e farli muovere a luogo e tempo; che i subalterni dovevano esser intieramente subordinati al maestro, e posti in maniera che potessero esser tutti insieme veduti e veder anch’essi scambievolmente chi suona il clavicembalo; che bisognava avvezzar di buon ora i sonatori alla giustezza del tempo, e a regolar il loro movimento colla mossa generale degli altri, affinchè l’aggregato de’ suoni avesse quell’unità, senza cui non havvi senso o significato alcun nella musica. Con tali massime generali ordinarono gl’Italiani l’orchestra, e fra gli altri i maestri napoletani, alla particolar avvedutezza de’ quali ne è debitrice l’Italia della sua superiorità in cotal genere. Insigne parimenti divenne , chiamato altrimenti celebre non meno per questo merito che per lo studio posto nella espressione del costume musicale, intendendo io con siffatto vocabolo il qualificare come si conviene, col debito grado d’intonazione e colla propria spezie di canto, la natura e situazione attuale de’ personaggi che prendonsi a rappresentare. né minor gloria s’acquistò l’immortale , il quale in siffatto pregio come nella felicità de’ suoi voli musicali, che lo rendono, a così dire, il e l’ de’ compositori, nell’accoppiar la espressione al difficile, nella fecondità e nel brio de’ suoi concerti fu veramente originale. Ma da niun altro maestro si potrà meglio imparare l’arte difficilissima di combinar gli strumenti quanto dal rinomatissimo , ovvero sia il sassone educato e perfezionato nella musica in Italia sotto agl’insegnamenti di , il quale maneggiò da filosofo e da uomo di genio la musica. Veggasi fra le carte del Dizionario di la pittura della orchestra di Dresda regolata da lui per molti anni, dove s’imparerà più con una occhiata sola che colla più minuta descrizione che da me potesse farsi.
[16] Ma niuna cosa contribuì tanto a render chiara la musica italiana in quest’epoca quanto l’eccellenza e la copia de’ cantori, che fiorirono di qua dai monti. Infatti come sarebbe possibile, anzi a che gioverebbe la perfezione delle altre parti costitutive della musica, se quella, cui tutte debbono riferirsi, e dalla quale ogniuna principalmente dipende, restasse abbandonata alla ignoranza e al pessimo gusto? L’arte del maestro e del sonatore altro non è infine che un linguaggio imperfetto, col quale non s’arriva a esprimere se non troppo rimotamente ciò che si vuole, laddove il canto è la più compita e più interessante imitazione che le belle arti possano proporsi per fine. La più compita, poiché imitando immediatamente i tuoni della umana favella, gli elementi stessi, onde si forma l’oggetto rappresentato, servono ad essa di mezzi a ben rappresentarlo. La più interessante, poiché egli è certo, che fra tutte le imitazioni possibili la più gradita al cuor dell’uomo sarà in ogni tempo quella della propria sensibilità e delle proprie affezioni. La pittura e la scoltura si fermano imitando, a così dire, nella scorza dell’uomo; il canto penetra fin nell’anima, l’avverte della sua esistenza, ne risveglia la sua attività, e ne dipinge le sue modificazioni più intime. Quelle sono come il Pimmalione della favola allorché ritrae dal marmo la statua di Galatea, questo è simile al nume propizio che animò quella statua medesima e che ai sensi sottopose dell’artefice innamorato i soavi ondeggiamenti, i palpiti successivi, i tremoli sguardi, i sospir seducenti, i sorrisi ingenui, e le incantatrici parole indizi di vita trasfusa all’improvviso in quella pietra infeconda, e delizioso alimento alle speranze dell’amante. Però nella mossa generale del buon gusto musicale in Italia l’arte del canto se ne dovette spogliare, e se ne spogliò infatti del cattivo metodo antico, e contribuì a rinforzar vieppiù l’espressione, non già facendo strazio della poesia, come nel secolo passato, né aggirandosi intorno a’ vani arzigogoli, come a’ tempi nostri, ma ponendo ogni suo studio nell’immitar l’accento naturale delle passioni, nell’acquistar una perfetta intonazione, che è il cardine d’ogni melodia, nell’imparar la maniera di cavare, modulare, e fermare la voce a dovere, nell’eseguir maestrevolmente i passaggi da nota in nota colla debita gradazione acciochè tutte quante spicchino le diverse inflessioni del sentimento, nell’appoggiar a tempo e luogo sui tuoni trattenuti, ove il richieda la espression del dolore o della tristezza, scorrendo poi leggiermente sugli altri, che generati vengono da affetti contrari, nel preferir il naturale al difficile, e lo stile del cuore a quello di bravura, nel far uso di quelli abbellimenti soltanto, che necessari sono alla vaghezza e brio della voce senz’adoperarli tuttavia con prodigalità nuocevole alla espressione, nell’attemperar l’agilità naturale di essa voce non già all’arbitrio di chi la possiede fecondo per lo più di capricci, ma all’indole della natura e della passione, nell’accomodar la prosodia della lingua coll’accento musicale in maniera che vi si distingua nettamente ogni parola, se ne comprenda il sentimento e la forza, e si ravvisi il quantitativo valor delle sillabe, nell’accompagnar col gesto appropriato e convenevole i movimenti del canto, e il carattere de’ personaggi, in una parola nel portar il più lontano che sia possibile l’interesse, l’illusione, e il diletto, que’ gran fonti della teatrale magia.
[17] Secondo lo spirito dell’esposto sistema s’aprirono nelle più cospicue città utilissime scuole intente a promuover quest’arte incantatrice, e ripolirla. Modena ebbe quella di , come Genova quella di , l’Orfeo e il Batillo della Liguria. Venezia oltre gli oratori destinati con gran vantaggio della musica alla educazione de’ cantanti ebbe il e il per capiscuole. Roma, dove la particolar esecuzione della musica sacra avea da lungo tempo introdotta la necessità degli studi e de’ maestri, fioriva allora per l’industria e pe’ talenti dei , e di , i quali uniti con esempio non troppo comune ai letterati in fratellevole amicizia cogli altri uomini valenti nell’arte del suono e della composizione, comunicavansi a vicenda i lor sentimenti e le osservazioni loro al comune giudizio esponevano, onde poi copiosi lumi ritraeva ciascheduno per corregerne i propri difetti, per migliorarne il piano di educazion musicale, e per dilatarne i confini dell’arte. Serve d’argomento a provar la diligenza di questi eccellenti maestri il costume che avevano, siccome riferisce il illustre allievo della scuola romana, di condurre a spasso i loro discepoli fuori delle mura di Roma colà dove si ritruova un sasso famoso per l’eco, che ripete più volte le stesse parole. Ivi ad imitazione di , di cui si dice che andasse ogni giorno al lido del mare affine di emendare la balbuzie della sua lingua col suono de’ ripercossi flutti, gli esercitavano essi facendoli cantare dirimpetto al sasso, il quale, replicando distintamente le modulazioni, gli ammoniva con evidenza de’ loro difetti, e gli disponeva a correggersi più facilmente. Fu celebre maestro in Milano , e in Firenze, che non dee confondersi coll’, che tanti vantaggi ha recato alla sua lingua, alla poesia, e alla fisica. Ma gli empori più illustri del canto sul fine del Seicento furono Napoli e Bologna. La prima cotanto rinomata ne’ fasti della moderna musica ebbe una folla di maestri, e di scuole, che lungo sarebbe il voler partitamente noverare. Le più insigni furono quelle di , di , di , di , e di , dai quali uomini valentissimi non meno nella pratica dell’arte loro che nel metodo d’insegnarla, sortirono poscia que’ tanti discepoli, che quali novelli prodigi di melodia si fecero ammirare da tutta Europa. Non essendomi permesso il nominar tutti, mi restringerò a due soli, che successivamente riempirono di stupore e di meraviglia i teatri.
[18] Il primo fu Baldassarre
Ferri perugino, creato poi cavaliere, che imparò la musica in
Napoli e in Roma verso la fine dello
scorso secolo, e in gloria del quale benché morto in fresca età si conservano tuttora
varie raccolte di poesie, produzioni dell’entusiasmo che ovunque eccitava quel
sorprendente cantore. Se si presta fede agli autori contemporanei, , , e
dovevano contarsi per nulla. Le doti, che
rendono ammirabile separatamente qualunque musico, si trovavano insieme in lui riunite.
Possedeva per eccellenza tutti i caratteri piegavasi maravigliosamente a tutte le
inflessioni, muoveva invincibilmente tutti gli affetti. Il , che fa menzione di lui nel suo Dizionario, dice
in pruova della sua abilità: «che egli saliva e discendeva in un fiato solo due
piene ottave con un trillo continuo, marcando tutti i gradi cromatici con tanta
giustezza di voce, benché senz’accompagnamento, che se l’orchestra suonava
all’improvviso quella nota dove ei si trovava, fosse bemolle, o fosse diesis, si
sentiva al momento una conformità d’accordo che faceva stupir gli
uditori»
89. Non inferiore al suo merito era pure il favore del pubblico per
esso lui. Alle volte nembi di rose piovevano sulla sua carrozza, quando egli sortiva
dopo aver recitata una cantata. A Firenze dov’era stato chiamato,
uscì lunghi per ben tre miglia della città numeroso stuolo di dame e di cavalieri a
riceverlo, come potrebbe farsi nell’ingresso d’un principe. Recitando in
Londra una volta il personaggio di Zeffiro, gli fu presentata al sortire dà una maschera
sconosciuta uno smeraldo di gran valore. Io ho veduto un suo ritratto in carta con
all’intorno questo moto profanato invece di epigrafe: «qui fecit mirabilia
multa»
, e una medaglia eziandio dove si vede da una banda la testa incoronata
d’alloro, e dall’altra un cigno moribondo sulle rive del Meandro
colla cetra d’Arione che discende dal
cielo.
[19] Il secondo è stato il cavalier Don Carlo Broschi altrimenti detto Farinelli nato in Napoli, dove apparò i primi elementi musicali sotto la direzione di e di . Questi insegnamenti gli fecero ben tosto sviluppare i portentosi suoi talenti pel canto. Ni uno a’ tempi nostri ha sortito dalla natura còrde più valenti, e insiem più flessibili, tenera più sonora, né maggior ampiezza di voce. Questa volava indistintamente per tutti i tuoni per quanto fossero essi gravi, acuti, e profondi. Una fantasia creatrice congiunta con una pieghevolezza d’organi a tutta pruova lo mettevano in istato di poter inventar mille forme di canto sconosciute e pellegrine. Colle doti naturali acconsentirono mirabilmente quelle dell’arte. Intuonazion perfettissima che poteva servir di canone di Policleto nella sua professione, agilità incomparabile, destrezza inaudita ne’ trilli, sobrietà e vaghezza negli ornamenti, ugual eccellenza nello stil leggiero che nel patetico, sopra ogni cosa graduazione esattissima nel sollevare e diminuire successivamente la voce secondo l’indole del sentimento: ecco le mirabili prerogative che gli vengono unanimemente accordate, e che poscia a quella sublime fortuna il condussero che non può ignorarsi da chicchessia.
[20] Pregevole pel metodo d’insegnare, per la varietà degli
stili, e pel numero di bravi discepoli fu la scuola bolognese fondata da . Antesignano di essa divenne il
celebre Antonio Bernacchi, il quale, comechè
avesse fievole voce e disadorna, tanto ei seppe fare a forza di studio, che attissima la
rese pel canto, nel quale maravigliosamente poi si distinse pel facile spianamento, per
l’arte di graduar il fiato, per la leggiadria degli ornamenti, e per la esatta maniera
di eseguir le cadenze. Il suo raro merito invece di renderlo «il caposcuola, e il
della moderna licenza»
, come a
torto il chiama il Conte 90,
il fece anzi comparire uno de’ più rinomati cantori del suo tempo. Antonio Raff, Giovanni
Tedeschi, Tommaso Guarducci, e
Giambattista Mancini, che si è anche distinto
fra i letterati pel suo bel libro intitolato Riflessioni pratiche sul canto
figurato allevati da lui fanno tuttora parte viventi, e parte defunti bella
testimonianza del valore del loro maestro. La taccia di avere in qualche modo
contribuito all’odierno rilasciamento potrebbe forse con più ragione ripetersi dal
Pasi bolognese scolaro del . Il suo stile composto di volatine, di gruppetti,
di passaggi ricercati, di trilli, e di mille altri abbellimenti, se bene piacesse in lui
perché proprio e tutto suo, era nullameno esposto a degenerare in abuso, qualora venisse
imitato da cantori inesperti. Carlo Carlani e
Pio Fabri, tenori eccellenti, Bartolino faentino, e il Minelli uno di que’ cantori che hanno a’ tempi nostri posseduto con
eminenza l’accento musicale, erano pure della stessa scuola.
[21] Di lungo tedio e di niun giovamento al lettore sarebbe il venir meco per ogni dove cercando tutti i famosi professori di canto, che dell’uno e dell’altro sesso ebbe allora l’Italia, oppure quali fossero i diversi stili de’ Buzzoleni, de’ Cortona, de’ Matteucci, de’ Sifaci, de’ Carestini, de’ Senesini, delle Boschi, delle Cuzzoni, delle Visconti, e di tanti altri, l’abilità de’ quali è ita sotterra con esso loro, sebben non rimanga spenta in quanto alla fama. Basterà non per tanto l’accennar brevemente il valore di due donne, che si fecero a quel tempo sentir sul teatro con gloria uguale a quella de’ più celebrati cantori. La prima fu Vittoria Tesi fiorentina discepola del e del , la quale ad una inflessione di voce sommamente patetica, ad una intonazion perfettissima, ad una pronunzia chiara, netta e vivacemente sonora, ad un portamento di persona simile a quello della Giunone d’ seppe unire possesso grande della scena, azione mirabile, espressione sorprendente de’ diversi caratteri: doti, che la resero la prima attrice del secolo. La seconda fu Faustina Bordoni veneziana allieva di buon contrappuntista. Divenne egualmente insigne pel proprio merito che per la fortuna di esser la sposa del gran . Agilità di voce, cui non è facile trovar l’uguale, facilità senza pari, speditezza ne’ passaggi, destrezza nel conservar e ripigliar il fiato, vaghezza nei trilli, nuovi, e brillanti pasteggi amenti di voce, mille altre qualità insomma, la rarità e il pregio delle quali viene stimato soltanto dai conoscitori, scrissero il nome di questa cantatrice nei fasti del genio.
[22] A queste due mi si permetta aggiungere una terza, di cui farò in particolar modo menzione meno pel merito del suo canto che per un altro più insigne e più rispettabile agli occhi del filosofo. Sono note ad ognuno le calamitose vicende dalle.quali fu travagliato nella sua gioventù dopo la morte del suo primo benefattore . Non solo gli fu negato un impiego onde poter miseramente campare, non solo si vide vicino a perir di fame, ma (ciò che fa.fremere ogni cuor sensibile) in Italia, in quella città stessa, che dovrebbe andar più superba d’averlo avuto per figlio che de’ trionfi, che ne adornano il suo Campidoglio, ebbe egli a soffrire un ignominioso processo. L’Europa avrebbe perduto per sempre quel gran poeta se la famosa Marianna Bulgarini cantatrice di professione nol ritraeva dalla indigenza, e nol rimetteva in sentiero. Quest’opera dell’amore e della generosità merita d’essere registrata ne’ fasti pur’troppo scarsi delle umane virtù: per riscuoterne l’universale riconoscenza. Donna incomparabile! Tu sei sicura di quella di tutte l’anime oneste. S’io desidero qualche celebrità pel mio nome, e qualche durevolezza pe’ miei scritti, non è l’ultimo tra i motivi quello di tramandare alla posterità i sentimenti d’ammirazione che m’ispira la tua memoria. Sì, tu vivrai negli annali della filosofia insieme col tuo illustre amico e protetto, e mentre il nome di tanti figli dell’opulenza disprezzati dai saggi e ben degni di esserlo, mentre quello di tanti vegetabili automati che si chiamano grandi per obbrobrio del titolo, si dileguerà dalla memoria degli uomini, come gl’impuri vapori che s’innalzano sulla superficie delle paludi, i nomi della Bulgarini, e di brilleranno fra i posteri finché esisterà negli uomini un qualche sentimento del bello morale, e finché il carattere del genio riscuoterà i ben dovuti omaggi del pubblico .
[23] Fornita di tale e tanta ricchezza in ogni genere, l’Italia divenne allora per le altre nazioni scuola pregiata d’ogni saper musicale, onde i più gran compositori stranieri o vi si portarono a bella posta a imparare, o impiegaron le proprie fatiche nel perfezionar il melodramma italiano, massimamente dappoiché le poesie del rapirono senza contrasto il principato del teatro lirico. E il , l’, il , e il e tanti altri posero sotto le note i drammi italiani che si videro signoreggiare imperiosamente in tutte le corti europee da Petersburgo perfino a Lisbona, e da Pultava fino ad Amsterdam eseguiti da uomini e donne italiane non senza vantaggio considerabile d’infinite famiglie e di moltissimo oro colato in Italia per questa via. né minore si fu la riputazione che del buon gusto e del prospero stato delle arti italiane presero gli oltramontani, in veggendo le tante colonie composte di maestri, di sonatori, di cantanti, di ballerini, e di macchinisti bravissimi, che sortivano dal loro paese per procacciar ad essi un sì vario, sì gentile, e sì perfezionato diletto, né minori i contrassegni, onde vennero distinti non pochi Italiani celebri solo per questo merito; Ferri, Matteucci, e Guadagni furono creati cavalieri, Farinelli ebbe la croce di Calatrava in Ispagna, dove sotto la sua direzione, e regolamento si rinovellò negli spettacoli teatrali tutta la magnificenza e il buon gusto dell’antica Atene; la Tesi fu premiata coll’acquisto dell’ordine della Fedeltà e Costanza in Danimarca, e così via discorrendo. Non so per tanto con qual ragione un riflessivo e interessante scrittore91 abbia chiamata vana e inutile quella gloria che ritraggono gl’Italiani dal vedere che la loro lingua, musica, e poesia sono superiori a quelle degli oltramontani. L’Italia non dovrà mai al nostro avviso riputar vana una lode che suppone in suo favore una decisiva maggioranza nelle doti dell’ingegno, e in quelle dell’arte. Nelle prime, perché né la musica né la poesia possono arrivar a tanta eccellenza in un popolo, che dotato non sia di squisita sensibilità, e di brillante immaginazione; qualità, che trasferite alle belle arti non solo bastano ad immortalar un uomo, ma ad assicurar eziandio ad una intiera nazione l’omaggio di tutti i secoli. Nelle seconde, perché la perfezione di quelle facoltà è un indizio sicuro, che si coltivano pur ora, o si sono per l’addietro coltivate felicemente molte altre che dipendono dalle prime, o s’inanellano con esse in maniera che non possono reggersi da per sé; così una lingua ripolita, abbondante, armoniosa, e pieghevole suppone un lungo progresso di lumi, di coltura, e di cognizioni; una poesia ricca, e perfetta nei moltiplici rami che la compongono, suppone un uso quotidiano del teatro, una gran cognizione critica della storia, uno studio filosofico, analizzato e profondo del cuor dell’uomo; una musica come è l’italiana, suppone un avanzamento prodigioso nel gusto, e in tutte le arti del lusso. Imperocché è incontrastabile, che giammai un popolo baderebbe a perfezionar con tanto studio le facoltà di puro diletto, se l’agio, la pace, la morbidezza, e le superflue ricchezze, onde nasce il lusso, non vi dominassero da lungo tempo. né può tampoco chiamarsi inutile quella gloria, che al sostentamento serve di tanta gente, e contribuisce in particolar maniera a tirar in Italia l’oro degli stranieri, essendo certo, che da niun ramo delle belle arti cava, se ben si considera, tanto lucro questa provincia, quanto da quei che servono al melodramma. principalmente dacché le arti del disegno dopo aver padroneggiato senza rivali per’ben due secoli nel bel paese,
«Che Appenin parte, e l’mar circonda, e l’Alpe»
voltarono infine le spalle, e sene andarono assise sul carro di Minerva ad illeggiadrire colla sua venustà le rive della Senna e dello Scaldi.
[24] Se non che non si dee credere che il buon gusto musicale
quale è stato finora descritto, fosse così universale quanto a prima vista apparisce. Se
le armoniche facoltà ebbero i loro e i loro
, non mancarono di e di anche in abbondanza, e
se la semplicità, la sobrietà, l’espressione, e la naturalezza furono le delizie dei
primi, le fiaminghe anticaglie, il contrappunto operoso, le difficili puditezze, e la
romorosa armonia spiccaron non meno nelle composizioni dei secondi. Che se alcuno
stentasse a credermi, faranno invece mia sicura testimonianza due chiarissimi autori,
cui niuno potrà rimproverare di aver voluto adombrar il vero, o recar onta alle glorie
della loro patria. L’uno si è il signor conte regio direttore degli studi a Torino, il
quale in due belle lettere sull’arte del suono inserite nella raccolti degli opuscoli di
Milano92 così si esprime, esponendo lo stato della musica, allorché cominciò a spuntare qual astro novello sul cielo
della Italia: «Dominava ancora tra gli scrittori quel
barbaro gusto delle fughe, de’ canoni, e di tutti insomma i più avvilupati intrecci
d’un ispido contrappunto. Questa increscevol pompa di armonica perizia, questa gotica
usanza d’indovinelli e di logogrifi musicali: questa musica gradita agli occhi e
crudel per gli orecchi, piena d’armonia e di romore, e vuota di gusto e di melodia,
fatta secondo le regole, seppur le regole hanno l’atrocità di permettere di far cose
spiacevoli, fredde, imbrogliate, senz’espressione, senza canto, senza leggiadria, qual
altro pregio veramente aver può che quel di abbagliar gli eruditi, e di uccider per la
fatica il compositore, e êr la noia i dormigliosi ascoltanti?»
L’altro è il
famoso patrizio veneto, genio fra
i più grandi che abbia nel nostro secolo posseduti l’Italia, e
che nella sua immortale composizione de’ salmi gareggia col se non lo supera. Quest’uomo eccellentissimo, che alla gravità
dell’antica musica ha saputo unir così bene le grazie della moderna, compose ancora una
saporitissima critica intitolata il teatro alla moda, senza nome, senza
data e senza luogo di stampa, ma che fu per altro mandata in luce poco dopo il mille e
settecento, ove colla licenza che permette la maschera, schiera ad uno ad uno con
festiva ironia tutti i difetti che dominavano al suo tempo in sulle scene. Ad essa noi
pure rimettiamo i lettori che dello stato del teatro italiano volessero avere piena
contezza. né i mentovati vizi si trovano nel volgo soltanto dei compositori, e degli
attori, ma in alcune composizioni eziandio di quelli uomini sommi, di cui si è finora
parlato con tanta lode. ha delle cose molto
triviali, i principi di non furono conformi
alla eccellenza cui giunse dappoi, pagò
tributo al suo secolo infettando le sue prime sonate con quello stile di labirinto, in
non tutte le opere uguagliano la quinta, né
la melodia dell’immortal Farinelli fu la stessa
nella età sua virile, che fosse stata nella sua giovinezza. Ma non ci dobbiamo punto
maravigliare di questo, ripensando che nelle vie che percorre l’umano spirito per
istruirsi, l’errore è quell’istimo fatale posto dalla natura tra la verità e
l’ignoranza, che non lice ad alcun nocchiero schivare se annoverato non viene fra que’
pochissimi, cui propizio sorrise Giove
dall’Olimpo.
Capitolo decimo §
Miglioramento della poesia lirico drammatica, in Francia precursore della riforma. Celebri poeti fino a . Avanzamenti della prospettiva.
[1] La Francia, che avea in parte contribuito a fare che gl’Italiani trovassero il vero stile del recitativo musicale, contribuì non meno col proprio esempio al miglioramento della poesia drammatica. Dal tempo in cui s’introdusse il melodramma in quella nazione per opera del Cardinal Mazzarini, i poeti che rivolsero l’ingegno a cotal genere di componimenti modellarono intieramente il loro gusto e la loro maniera su quella delle produzioni italiani, che levavano maggior grido. Non è adunque da maravigliarsi che i vizi d’un sì cattivo esemplare si propagassero ai melodrammi francesi, e che questi sprovveduti d’ogni poetico pregio cadessero nello stesso avvilimento in cui erano caduti in Italia. , che fu il primo poeta che componesse opere nella propria lingua, , primo direttor francese della orchestra drammatica, e Sourdiac, primo macchinista, divertirono per molti anni la corte con spettacoli sconci in quel tempo medesimo che il gran creava il teatro tragico, che incominciava a gareggiar con , e che sorgeva oscurando colle sue commedie la gloria degli e de’ . Niuno crederebbe che Luigi Decimoquarto avvezzo ad ammirare tanti capi d’opera sovrani in ogni genere di poesia sene dovesse compiacere, come infatti sene compiacque, della triviale e plebea rappresentazione della Pomona, ove si parlava a lungo di pomi e di carciofoli, che potesse aver la sofferenza di sentir parlare nelle Pene, e piaceri d’Amore Diana, Venere, e l’Aurora col linguaggio delle fantesche e delle ostesse, e che non si raccapriciasse per lo spavento nel sentir codesta bestiale invocazion de’ demoni che si faceva nell’opera intitolata la Circe
«Sus Belial, Satan, et Mildefaut,Turchebinet, Saucierain, Gribaut,Francipoulain, Noricot, et Graincelle,Asmodeus, et tout la séquelle.»
siffatto scongiuro era più a proposito per mandar in inferno i viventi che per trarne fuori i demoni.
[2] Tal era lo stato del melodramma in Francia, allorché s’accinse insieme col alla impresa di riformare il teatro dell’opera. Questo celebre poeta tanto criticato nel suo secolo quanto lodato nel nostro, avea avuta la disgrazia di comporre alcune cattive tragedie, per le quali era talmente incorso nella disgrazia di , che il satirico non perdeva occasione di motteggiarlo ovunque gli cadeva in acconcio. La sfortunata riuscita delle sue prime fatiche fecero capire a essere il suo talento poco a proposito per la tragedia, e che meglio gli tornerebbe volgendolo ad altri generi di poesia. Il suo divisamento divenne utilissimo alla gloria della Francia, poiché con questo mezzo si vide il parnaso nazionale arricchito di tante produzioni eccellenti quanti sono i pezzi drammatico-lirici ch’egli compose. E certo è che prendendo egli ad abbellire il poetico mostro, che si chiamava opera, gli diè quella regolarità e quella forma, della quale niuno l’avrebbe dreduto capace. Il sistema della mitologia e delle fate, sorgente perenne di deliri non meno sul teatro italiano che sul francese acquistò fra le sue mani del vigore, della forza e dell’ordine. E Medea, Arcabona, Armida, Medusa con altri esseri fantastici piacquero a quelli uditori medesimi che erano avvezzi a sparger lagrime sulle calamità di Fedra, e d’Ifigenia, non tanto per l’interesse che potevano eccitare siffatti personaggi (il quale per le ragioni altrove accennate dovea ridursi pressoché al nulla) quanto per la bellezza delle comparse che somministravano. Massimamente in un paese e in un secolo dove la musica allora nascente non avea per anco fatto sentire la varietà, le grazie, la dolcezza, e la melodia che manifestò poscia nelle composizioni de’ gran maestri italiani. Più d’ogni altra cosa contribuì l’eleganza, la precisione e chiarezza dello stile, la naturalezza e facilità del periodo, la varietà, mollezza, ed armonia de’ versi, la dilicatezza dell’affetto, tutte quelle doti insomma che caratterizzano la poesia musicale, e nelle quali non ha avuto alcun rivale in Francia né prima né poi. I lettori che amano di farne i confronti tanto giovevoli agli avanzamenti del gusto mi sapranno forse buon grado ch’io esibisca loro un qualche saggio dello stile di questo poeta pressoché sconosciuto in Italia. Ne addurrò dunque alcuni squarci nella propria lingua, non osando trasferirli nella italiana per non toccar con mani profane la Venere ignuda de’ Medici. Quando, traducendo le cose poeti che da un idioma in un altro non si è sicuro d’aver il polso d’un , o d’un , si va a rischio di rinovellar la favola de’ Pigmei, allorché s’affannavano per alzar da terra la clava d’Ercole che dormiva.
[3] Si tratta di esprimere quella mescolanza di rimprovero e di preghiera, que’ sospetti mitigati dalla speranza, quella eloquenza timida insieme ed ardita che ispira l’amore a coloro, che antiveggendo da lontano l’incostanza dell’oggetto che adorano, cercano pure di richiamarlo con dolenti bensì ma dolcissime querele a’ primitivi trasporti? Ecco nelle prime scene dell’Iside un esempio mirabile allorché Ierace si lagna della ninfa Io:
«Vous juriez autrefois que cette onde rebelleSe ferait vers sa source une route nouvellePlutôt qu’on ne verrait votre cœur dégagé;Voyez couler ces flots dans cette vaste plaine:C’est le même penchant qui toujours les entraîne.Leur cœur ne change point, et vous avez changé.Io.
Non, je vous aime encor.Hierax.
Quelle froideur extrême!Inconstante, est-ce ainsi qu’on doit dire qu’on aime?Io.
C’est à tort que vous m’accusez.Vous avez vu touiours vos rivaux méprisés.Hierax.
Le mal de mes rivaux n’égale point ma peine.La douce illusion d’une espérance vaineNe les fait point tomber du fait du bonheur:Aucun d’eux, comme moi, n’a perdu votre cœur.»
[4] Si vuol rappresentare il tormento più squisito e più crudele che possa trovar ricetto nel cuor d’un amante, la certezza, cioè, d’essere stata l’involontaria cagione della morte della sua amata? Leggansi nell’atto quinto dell’Attide que’ versi, dov’egli rimprovera a se stesso di essere stato l’omicida di Sangaride:
«Quoi! Sangaride est morte! Atys est son boureau!Quelle vengeance, ô dieux! Quel supplice nouveau!Quelles horreurs sont comparablesAux horreurs que je sens!Dieux cruels, dieux impitoyables,N’êtes-vous tout-puissantsQue pour faire des misérables?»
[5] E non si creda già che riuscisse bene soltanto nelle cose amorose. Niun poeta francese, compreso anche lo stesso che il deprimeva sì ingiustamente, l’ha uguagliato, quando egli ha voluto, nella sublimità e nella forza della espressione. Sentasi in qual guisa parla un coro di seguaci di Plutone nell’Alceste:
«Tout mortel doit ici paraître.On ne peut naîtreQue pour mourir.De cent maux le trépas délivre;Qui cherche à vivreCherche à souffrir.Plaintes, cris, larmes,Tout est sans armesContre la mort.Est-on sageDe fuir ce passage!C’est un orageQui mène au port.»
[6] Si ponga mente alla robusta fierezza di Medusa nel Perseo:
«Je porte l’épouvante, et la mort en tous lieux;Tout se change en rocher à mon aspect horrible.Les traits que Jupiter lance du haut des cieux,N’ont rien de si terribleQu’un regard de mes yeux.Les plus grands dieux du ciel, de la terre, et de l’ondeDu soin de se venger se reposent sur moi.Si je perds la douceur d’être l’amour du mondeJ’ai le plaisir nouveau d’en devenir l’effroi.»
[7] S’avverta innoltre al discorso che fa Ercole a Plutone; si rifletta al coro che nella Proserpina ringrazia gli dei per la sconfitta de’ giganti; si leggano i versi dove si fa per ordine di dio la creazione del mondo; si paragonino poi codesti squarci e molti di più che potrebbero in mezzo recarsi coll’ode sulla presa di Namur, dove ha voluto far pompa di lirica grandiosità, indi si giudichi, se sia o no più facile il criticar un grand’uomo che l’uguagliarlo.
[8] L’esempio di annunziava una mutazione simile nella poesia lirico drammatica d’Italia, se non in quanto le diverse circostanze di questa nazione fecero cangiar il piano abbellito dal poeta francese. L’opera riserbata fin’allora a festeggiar le nozze de’ principi o a comparire nelle pubbliche allegrezze in mezzo alle corti e nei sontuosi palagi, cominciò anche a lasciarsi vedere nei teatri prezzolati, dove regolata da impressari scarsi di sostanze e cupidi del guadagno più non si potè mantenere col dispendio che esigevan le decorazioni e le appariscenze proprie degli argomenti favolosi. Il cangiamento accaduto poscia nella musica, rivolgendo verso i cantori l’attenzione del pubblico che si prestava da prima ai macchinisti, fu la cagione che i musici si tenessero in maggior conto, e che paghe strabocchevoli richiedessero per le fatiche loro, onde venne in seguito la necessità d’appigliarsi ad altri provvedimenti, che servissero a risparmiar da una parte ciò che si profondeva dall’altra. Della qual disposizione dovuta forse più alle cause accidentali, che a positivo disegno di migliorar il melodramma approfittandosi i begl’ingegni d’Italia, ben presto porsero mano alla riforma della poesia. Appena s’incominciò a capire che il vero, il grande, il patetico, il semplice erano le sole strade per giugnere al cuore, che immantinente sparì tutto quell’apparato di favole e tutto il viluppo di avvenimenti e di meraviglie inventate unicamente per sorprender l’immaginazione in mancanza della natura. Gli dei e i diavoli furono sbanditi dal teatro, allorché si seppe far parlare dignitosamente gli uomini, e i madrigali, le antitesi, le acutezze amorose e l’altre simili ipocrisie dell’affetto si mandarono via insiem colle fughe, le contrafughe, i doppi, i rovesci, e tali altri riempitivi della musica. Le pitture nobili, le forti passioni, i caratteri grandi tratti dalla storia greca e romana, (quasi le due sole nazioni che somministrino argomenti al teatro, perché esse quasi le sole furono ove si conoscessero quelle virtù che possono riceversi dalla legislazione, e dalla filosofia) si sostituirono sulle scene all’abbominio del buon gusto, che dominava per tutto. Si vide che la rapidità, la concisione e l’interesse che partoriscono la commozione, erano l’anima della poesia musicale, e che la lentezza, la monotonia, le dissertazioni e i lunghi episodi trattenevano l’effetto d’un’arte, la quale ha per fine il destar negli animi degli uditori il tumulto e il disordine di tutti gli affetti. Quindi s’accorciarono di molto i componimenti, il numero degli atti si ridusse a tre di cinque che solevano essere, si tolsero via gli inutili prologhi, i quali facevano altrettante azioni preliminari separate dalla principale, si abbreviarono i recitativi, e si cacciarono infine delle scene le arie, ove prima si frammettevano contra ogni retto pensare. Una cognizione più intima del teatro gli fece avvertire che l’aria, essendo quasi l’epifonema o l’epilogo della passione, non dovea collocarsi sul principio, o tra mezzo ad una scena, giacché non procedendo la natura per salti, ma bensì colla opportuna graduazione ne’ suoi movimenti, non è verosimile che sull’incominciare d’un dialogo si vedesse di già il personaggio nel colmo della passione per rientrar poi immediatamente nello stile pacato che esige il recitativo. Lo che era incorrere nello stesso errore in cui incorrerebbe un retorico, il quale dasse principio ad un discorso colla perorazione, facendo in seguito succeder l’esordio.
[9] Due difetti però che più d’ogni altro sformavano il melodramma s’assoggettarono a particolar correzione, l’uno il disordine che regnava nei cangiamenti di scena, l’altro la maniera d’introdurre i cori. Per lo passato niun pensiero si prendevano i poeti di preparar le decorazioni. Il mostro descritto da , che aveva sembianza di donna su una cervice di cavallo, le piume sul dosso e il restante pesce, era il vero emblema del teatro musicale. Dopo averti mostrata la reggia d’Amore ti conducevan per mano a contemplare un mausoleo parcamente illuminato da lampadi sepolcrali. Venere tirata dalle colombe seguitava gli affumicati cavalli di Plutone, e il palazzo del sole serviva di anticamera poetica alle grotte di Nettuno. A cotal abuso si fecero incontro i poeticoartando la smodata licenza delle decorazioni, preparando con maggior saviezza gli avvenimenti, imbrigliando con certa regola la fantasia del macchinista e dello spettatore. Restò bensì sbandita, siccome era da prima, l’unità della scena; unità la quale allorché divien rigorosa ritarda i progressi dell’arte invece di accelerarli93; ma la licenza che indi ne risultava fu limitata dal buon senso prescrivendo al luogo le stesse leggi che al tempo, e misurando la successione per la permanenza: vale a dire, che siccome alla durata dell’azione si permettono ventiquattr’ ore, così permettonsi al luogo que’ cangiamenti che possono naturalmente avvenire camminando una giornata intiera. Tutto ciò che oltrepassa l’accennata regola è contrario egualmente ai dettami della natura, e a quelli dell’arte. Per la stessa ragione fu anche levato via il costume di chiuder con un coro ciascun atto del melodramma. Siffatta usanza era incompatibile colle mutazioni della scena, e vi voleva appunto tutta la corruzione del gusto di que’ tempi per non riflettere che o cangiandosi la scena, rimaneva lo stesso coro stabile, e allora diveniva un assurdo, o si cangiava anche il coro insiem colla scena, e allora bisognava stiracchiar l’orditura del dramma acciò che vi fosse infine d’ogni atto una situazione la quale rendesse necessaria, o almen verosimile, l’esistenza del coro. Invece non per tanto di questo fu introdotto il costume di finire gli atti con un’aria o con un duetto, onde si colse il doppio vantaggio e di togliere una inverosimiglianza che saltava agli occhi e di approfittarsi vieppiù delle squisitezze della musica, le quali spiccano molto più nella monodia e nel duetto che nelle partizioni d’un coro. Riserbandosi poi questo per alcune occasioni, dove la verità della storia o la pompa dello spettacolo o l’ingresso d’un principe trionfante o qualche altro pubblico evento sembravano giustificare la radunanza di molte persone in un luogo; al quale riflesso per non aver posto mente i Greci, e per essersi lasciati strascinare da un invecchiato costume, caricarono (checché ne dica in contrario la prevenzione) le loro tragedie di mille sconvenenze a fatica ricompensate colle originali bellezze, che dopo venti e più secoli siamo pur costretti ad ammirare nei loro scritti drammatici.
[10] Siffatta riforma venne al melodramma per opera de’ più celebri poeti a quel tempo, de’ quali io non nominerò se non quelli che in qualche modo al cangiamento concorsero, lasciando le ricerche più minute a coloro che stimano aver fatto gran via nella carriera del gusto allorché sanno dirci appuntino il giorno della nascita e della morte, il numero e il titolo delle opere di tanti autori che il pubblico ha dimenticati da lungo tempo senza far loro alcun torto. e scrissero parecchi drammi ne’ quali se ben l’uno e l’altro partecipano del cattivo gusto nei vezzi soverchi, e ne’ caratteri manierati pur qualche regolarità e qualche gusto ne aggiunsero. Il lavorò alcuni dove si scorge poesia più fluida e musicale con ispeditezia d’intreccio. romano poeta cesareo ne compose molti, e quasi tutti di carattere storico. Alcuni scrittori pretendono che quest’autore fosse il primo a volgere di tristo in lieto il fine della favola, ma il vero si è che l’usanza di finir lietamente i drammi è tanto antica in Italia quanto il dramma stesso. Io l’ho fatto vedere parlando della Euridice del , e l’ho trovata costantemente osservata in quanti mi sono capitati alle mani di quel secolo. Lo merita bensì qualche distinzione non già per questo, ma per essere stato uno de’ primi a purgar il melodramma della mescolanza ridicola di serio e di buffonesco, degli avvenimenti intrigatissimi e del sazievole apparato di macchine. Per altro il suo stile è secco e privo di calore. Ignora l’arte di render armonioso il recitativo, e più ancora quello di render le arie musicali. La caduta dei Decemviri è il più passabile de’ suoi componimenti. Il , poeta cesareo parimenti, e fiorentino, seguitarono l’esempio dello con qualche credito allora, ma i loro nomi coi drammi loro non riceveranno dalla posterità altro premio se non se quello di far serie nei voluminosi tomi del . Il marchese nella Ninfa fida fece vedere che i talenti per la poesia tragica sono diversi dai talenti per la poesia musicale, imperocché niun crederebbe che l’autore di quella pastorale scritta senza interesse, senza dolcezza di stile e senza spirito teatrale fosse lo stesso che avea composto la bellissima Merope. Lo stile dei drammi di bolognese è vago, ricercato e fiorito, ma l’autore disegna bastevolmente i caratteri e lavora qualche aria di buon gusto. nell’Aci e nel Dafni a lui attribuiti si mostra ben lontano dalla maravigliosa cultura d’ingegno che risplende nelle sue liriche poesie, e principalmente nella canzone Donna negli occhi vostri, la quale è al mio avviso il più ricco gioiello del moderno parnaso italiano.
[11] Più benemerito si rese, e maggior celebrità acquistò candioto poeta e storico dell’imperator Carlo VI. Quest’uomo infaticabile giornalista sensato, raccoglitor diligente, erudito senza pedanteria, e antiquario senz’affettazione può chiamarsi a ragione il del teatro lirico. Tra le molte imprese a cui porse mano con gran vantaggio della sua nazione, una fu quella di migliorare il dramma. Egli prese a correggere i licenziosi, o piuttosto sguaiati costumi ond’esso veniva macchiato, e ovunque trovò nel vasto campo della storia, nella quale era versatissimo, esempi luminosi o d’amor della patria, o di brama virtuosa di gloria, o di costanza generosa nell’amicizia, o di gentilezza con fedeltà nell’amore, o di compassione verso i suoi simili, o di grandezza d’animo ne’ casi avversi, o di prudenza, di fortezza e tali altre virtù tutte ei le ritolse par fregiarne il teatro. Ovunque fatto gli venne di rinvenire caratteri grandi e forti gli dipinse felicemente senza confonderne le copie. Eppure oltre a sessanta ne scrisse tra occupazioni per lo più contrarie al poetico genio. Il suo stile è corretto e sostenuto, l’invenzione varia, gli avvenimenti preparati meglio che per l’addietro non si faceva, e il tutto procede con regolarità. Le cose sacre principalmente furono da lui maneggiate con maestria, e decenza sconosciuta fino a suoi tempi, poiché gli oratori spirituali, genere di componimento inventato in Roma da San e da illustrato, giacevano allora nell’avvilimento abbandonati alle penne triviali. vi porse mani aiutatrici, e gli rivestì di quella maestà che conviensi al linguaggio delle divine scritture. Sisara, Tobia, Naaman, Giuseppe, le Profezie d’Isaia, Daniello, Davide umiliato, Gerusalemme convertita, l’Ezechia colle altre saranno sempre le migliori rappresentazioni che abbia l’Italia fino a’ tempi di . E siccome il suo carattere naturalmente il portava più a quel genere di stile che a qualunque altro, così in un altro luogo s’esprime con egual robustezza. Sentasi qual grandiosità di sentimenti metta egli in bocca a Sisara allorché, promettendo la salvezza al solo Abner, minaccia all’intiero popolo d’Israele totale eccidio.
«A voi pace:Ai contumaceIsraeleGuerra orribile, e crudeleIl mio braccio arrecherà.Torri eccelse a terra andrannoSorgerannoMonti d’ossa, e di ruine:E squarciateLacerateSeno, e crineEbrea madre piangerà»
[12] Maggiore si è ancora il vigor profetico con cui Daniello annunzia l’ira tremenda dell’altissimo al popolo della Persia in presenza di Amiti.
«Guai, Amiti, agl’imperi,Cui dio faccia assaggiar del suo tremendoFuror l’amaro Calice. Beete.Empietevi, e cadete,Dirà il dio d’Israel; né sia chi sorga,Dal lampo della spada,Che strisciare su voi farà il mio sdegno.Che se dove s’invocaL’alto mio nome alzo la verga, e batto:Voi sol quasi innocentiNe andrete immuni? No:Immuni non andrete, o miscredenti.Più di leon feroceDarà dall’altoDio la sua voce:E della terraL’estremo litoDel suo ruggitoRisuonerà:In sacco, e ceneriGrida urli, e gemitiDate, o pastori:Il giorno è questoNero, e funesto,Che ovili, e pascoliVi struggerà.»
[13] La scerta italiana non era per anco avvezza a sentir una poesia cotanto severa e robusta. Le commedie musicali eziandio, ovvero siano le opere buffe, ricevettero maggior lume dalla sua penna, tra le quali merita particolar menzione il Don Chisciotte benché i caratteri vi si dipingano con troppo languidi colori a paragone dell’immortale spagnuolo autore di quel romanzo.
[14] Con siffatti pregi codesto poeta è nondimeno assai lontano dall’aver toccata la perfezione. Egli dee piuttosto chiamarsi un uomo di talento che un uomo di genio, e tra i componimenti suoi e quelli del passa a un dippresso la medesima differenza che passerebbe tra amena e frondosa valle veduta al languido lume della luna e questa stessa rischiarata da’ raggi del sole nel più puro mattino di maggio. La fretta con cui gli lavorava, poiché spesso appena otto giorni spendeva in comporli, come asserisce il Marchese nella prefazione al teatro italiano, lo condusse a cadere talvolta in alcune inesattezze anche di stile poco elegante. Egli non conobbe abbastanza la rapidità che esige il melodramma; perciò le scene sono troppo lunghe, le favole troppo composte, e troppo cariche d’incidenti: talmente che v’ha di quelli fra i suoi drammi che fornirebbero ampia materia di lavoro a due o tre compite tragedie. Ciò non poteva fare a meno di non cagionar lentezza e languore sì nell’azione che nella musica. Non era nemmeno dotato d’orecchio bastevolmente dilicato; quindi il suo recitativo riesce alquanto duro, e non è molto felice nella composizione delle arie. Talvolta gli cadono dalla penna alcune che si direbbe essere state lavorate colla morbidezza metastasiana, come, per esempio, questa:
«Dove sei tuRobusta gioventù?Almen potessi anch’ioSeguirti o del cor mioParte migliore.Al tuo bel sen fareiScudo di questo Core:E a costo di mia vitaLa tua difenderei,Mio dolce amore.»
[15] Talvolta vengono fuori delle altre cose animate, che difficilmente potrebbe uguagliarle la stessa musa tragica del gran . Per esempio nell’Andromaca, allorché si vede ridotto Ulisse all’estremo di doverne scegliere tra due fanciulli che gli vengono presentati avanti per condannar l’uno di essi alla morte, e ch’egli ignora quale tra loro ne sia il proprio figliuolo, e quale il figliuolo d’Andromaca, sentasi con qual energia s’esprime la madre che si trova presente alla fatale scelta, e che appieno comprende la scaltrezza e la crudeltà d’Ulisse.
«Guarda pur: o quello o questoÈ tua prole, e sangue mio.Tu nol sai; ma il so ben io,Nè a te, perfido il dirò.Chi di voi lo vuol per padre? Ai fanciulliV’arrettrate? Ah! Voi tacendoSento dir: tu mi sei madre,Nè colui mi generò.»
[16] Si confronti codesta situazione con quella di Foca in , che è presso a poco la stessa, e la maniera di esprimersi di Leontino con questa di Andromaca, e si vedrà (sia detto con pace del pregiudizio) quanto il tragico francese sia rimasto inferiore al drammatico italiano. Ma siffatti esempi sono tanto rari che non bastano a sottrarlo dal difetto appostogli. Anche nella scelta de’ nomi fu poco avveduto. Orvendillo, Teuzzone, Ildegarde, Ormisda, Engelberta, Ganguir, Svanita, Lapidot, Nabot, Illel, Azanel con più altri ruvidi vocaboli sono più acconci a mettersi in una dichiarazione di guerra vandalica che in un melodramma. Altri l’accuserà forse di scarseggiare d’affetto e di non saper molto avanti nella dilicata filosofia delle passioni.
[17] Insiem colla poesia ne ricevette anche particolari accrescimenti la prospettiva teatrale. L’arte di far comparire spaziosi e grandi i luoghi ristrettissimi, l’agevolezza e rapidità di volger in un batter d’occhio le scene, la maniera di variar artificiosamente il chiarore dei lumi, e soprattutto l’invenzione dei punti accidentali, ovvero sia la maniera di veder le scene per angolo, condussero la scienza della illusione al sommo cui possa arrivare. Come il gran segreto delle belle arti è quello di presentar gli oggetti in maniera che la fantasia non finisca dove finiscono i sensi, ma che resti pur sempre qualche cosa da immaginare allo spettatore allorché l’occhio più non vede e l’orecchio non sente, così il discostarsi talvolta dalle prospettive che corrono al punto di mezzo, che sono, per così dire, il termine della potenza visiva e della immaginativa, fu lo stesso che aprire una carriera immensa alla immaginazione industriosa e inquieta di coloro che guardano da lontano le scene. Di siffatto ritrovamento ne fu l’autore bolognese, che grandissimo nome s’acquistò dentro e fuori della sua patria, e che venne meritamente chiamato il Paolo Veronese del teatro. Allora la prospettiva fu impiegata non più a esporre sotto gli occhi esseri fantastici, che non hanno alcuna relazione con noi, ma a rappresentare ed ingentilire gli oggetti reali dell’universo. Ed allora il dramma sortì dalla schiavitù dove lo tenevano oppresso i macchinisti e gli impresari, e prendendo per compagne, e non mai per sovrane, la decorazione e la melodia, ei comparve fregiato di tale splendore quale non ebbe mai da’ Greci in qua nel lungo corso di molti secoli. Mancava, nonostante, all’intiero compimento, il gran .
Capitolo undecimo §
Epoca di . Vantaggi recati da lui alla poesia e lingua italiana. Esame de’ suoi pregi. Riflessioni sulla sua maniera di trattar l’amore. Suoi difetti. S’abbia egli condotto il melodramma al maggior grado di perfezione possibile.
[1] Nel prender la penna per cominciar il presente capitolo io sento più che mai la difficoltà dell’impresa che mi sono forse imprudentemente addossato. Osar uno sconosciuto oltramontano chiamar in giudizio? Quel cioè, l’autore favorito del secolo, il cui nome scorre glorioso da Cadice fino all’Ukrania, e da Copenhagen fino al Brasile94 interessando in suo favore non solo i letterati, ma quel sesso altresì da cui sovente dipende l’applauso come tante volte il destino degli uomini? Osarlo in mezzo all’Italia! In quella nazione cioè dove per poco non s’innalzanda per tutto gli altari al sublime genio del ; dove i suoi versi sono oggimai divenuti proverbi, cantandosi nelle bocche di tutti, come già si faceva nella Grecia di quelli di e di ; dove tante penne di rinomati scrittori si sono per l’addietro stancate e si stancano tuttora nel celebrarlo; e dove così male è tornato a quei pochi meschini, che ardirono disturbare anche in menoma parte la sua luminosa e pacifica gloria? Ora tutto ciò io sapendo, con qual coraggio dovrò accingermi all’inutile impegno di portar legni al bosco lodandolo o al pericoloso cimento di sfrondarne i venerati allori che maestosamente germogliano dintorno alla sua statua? Ma cotai pensieri utili forse allorché si era in tempo di non intraprenderne il corso sono oggi mai divenuti tardivi trappassata che abbiamo la metà dell’arringo. né minor vituperio sarebbe il rimuovere la man dal lavoro dopo averlo una volta incominciato di quello che fosse saggio divisamento l’astenerci dal favellare di . Però senza pretender che il mio giudizio faccia autorità, anzi lasciando il lettore in piena libertà di non dargliene alcuna, io seguiterò ad esporre le mie riflessioni su questo punto colla stessa schiettezza e imparzialità, che finora ho procurato di fare sugli altri argomenti.
[2] A fine di conoscer meglio le singolari prerogative di questo poeta, e di render ragione di quell’universale diletto che arrecano i suoi componimenti, non fa d’uopo fermarsi sulle proposizioni generali, che possono a chicchessia convenire, ma esaminar bisogna paratamente i mezzi ond’egli è arrivato a rendersi lo scrittore unico e privilegiato dei musici, e la delizia delle persone gentili. Questa è al mio parere la sola maniera di render utile ed instruttiva la critica d’un grande autore, quella cioè di tesser la storia de’ suoi pensieri coll’indicare le strade battute da lui nella carriera del gusto, per le quali poscia inoltrandosi chiunque ha vaghezza d’imitarlo sappia trarne egualmente vantaggio dagli errori e dai lumi di chi l’ha preceduto. Ma dovendo comporre per musica sarebbe una ingiustizia il giudicarlo con altri principi che con quelli che esigono le composizioni di cotal genere, come grave torto farebbe a chi invece di esaminare l’Eneide colle leggi del poema epico la citasse inanzi al tribunale degli storici e degli oratori. Per il che supponendo che il lettore non si sia per anco dimenticato di quanto si è detto nel capitolo primo di quest’opera circa le leggi che distinguono il melodramma dalle altre produzioni teatrali, passerò a ragionare paratamente dello stile, della orditura, della filosofia e dell’affetto che spiccano a meraviglia negli scritti del celebre allievo del . Non farò discorso se non per incidenza di quella parte che spetta il costume de’ suoi personaggi, non già perch’io non la creda utilissima anzi necessaria al sommo in un poeta drammatico, né perché stimi che siasi mostrato in essa più trasandato che nelle altre, ma perché dovendo restringermi fra i limiti di quella discreta brevità, che richiede il mio metodo, non potrei trattare se non di volo una materia, la quale avrebbe per esser collocata nel suo vero lume bisogno di lungo esame e d’indagine più circostanziata. Tanto più che a cotal impegno si è soddisfatto egregiamente dal Signor in una dissertazione sulle opere drammatiche di questo poeta, alla quale non può forse altro difetto apporsi se non quello che già fu apposto ad un greco pittore, il quale dovendo far il ritratto di Antigono re di Macedonia ch’era mancante d’un occhio il dipinse con ingegnosa adulazione da una sola banda acciò che guardandolo gli spettatori, ammirassero le maestose sembianze senza punto accorgersene del difetto dell’originale.
[3] E incominciando dallo stile, il primo pregio che apparisce è quello d’una maniera d’esprimersi, dove con felicità, di cui non è facile rinvenir l’esempio in altri autori, si vede accoppiata la concisione colla chiarezza, la rapidità colla pieghevolezza, coll’uguaglianza la varietà, e il musicale col pittoresco. Tutto in lui è facile, tutto è spedito: vi par quasi che le parole siano state a bella posta inventate per inserirsi dov’ei vuole, e della maniera che vuole. Niuno meglio di lui ha saputo piegar la lingua italiana all’indole della musica ora rendendo vibrati i periodi nel recitativo; ora scartando quelle parole che per esser troppo lunghe o di suono malagevole e sostenuto non sono acconcie per il canto; ora adoperando spesso la sincope e le voci che finiscono in vocale accentuata, come “ardì”, “piegò”, “sarà”, lo che molto contribuisce a lisciar le dizioni; ora framischiando artifiziosamente gli ettasillabi cogli endecasillabi per dare al periodo la varietà combinabile coll’intervallo armonico e colla lena di chi dee cantarlo; ora smozzando i versi nella metà affinchè s’accorcino i periodi, e più soave si renda la posatura; ora usando discretamente ma senza legge fissa della rima servendo così al piacere dell’orecchio e a schivare la soverchia monotonia; ora finalmente adattando con singolar destrezza la diversità de’ metri alle varie passioni, facendo uso dei versi curti negli affetti che esprimono la languidezza, allorché l’anima, per così dire, sfinita non ha forza che basti a terminar il sentimento. Come sono questi:
«Oh che felici pianti!Che amabile martir!Purché si possa dir:Quel core è mio.Di due bell’alme amantiUn’alma allor si fa,Un’alma, che non haChe un sol desio.»
[4] Dei pieni, rapidi e volubili dove si esprime il coraggio
«Fiamma ignota nell’alma mi scende,Sento il nume: m’ispira, m’accende,Di me stessa mi rende maggior.Ferri, bende, bipenni, ritorte,Pallid’ombre compagne di morte,Già vi guardo, ma senza terror.»
e così via discorrendo. Niuno ha saputo meglio di lui adattare sulla lira italiana le corde della greca investendosi di tutta l’anima dei greci poeti più felicemente di quanti il precedettero in Italia finora senza eccettuar il , uomo grande al certo, ma cui mancò nell’imitazione il vero spirito filosofico; I quali si credevano di essere novelli divenuti allorché fatta avevano una sregolata canzone divisa in strofe, antistrofe ed epodon piena d’“auro-crinito”, “chiom-acquose”, “ombri-lucente”, ed altre parole sesquipedali, ma vuota di vero genio pindarico, senza costume né carattere greco, e soprattutto non cantabile, quando si sà che le greche non mai si scompagnavano dal canto e dal suono. Lo stesso dico della maggior parte delle chiamantisi Anacreontiche, le quali sono tanto lavorate sul gusto di quell’autore quanto sono conformi alla natura i ridevoli sistemi dei filosofi. All’opposto chiunque abbia un pò d’anima e di gusto non pedantesco riconoscerà immantinente la vera indole greca in quest’aureo inno di :
«Del forte LicidaNome maggiorD’Alfeo sul margineMai non suonò.Sudor più nobileDel suo sudorL’arena OlimpicaMai non bagnò.L’arti ha di Pallade,L’ali ha d’AmorDi Apollo, e d’Ercole.L’ardir mostrò.No, tanto meritoTanto valorL’ombra de’ secoliCoprir non può.»
non meno che l’indole del famoso cantore di Batillo in quest’altro tratto dall’Achille in Sciro:
«Se un’alma annodi,Se un core accendi,Che non pretendiTiranno Amor?Vuoi, che al potereDelle tue frodiCeda il sapere,Ceda il valor.Se in bianche piumeDe’ numi il numeCanori accentiSpiegò talor;Se fra gli armentiMuggì neglettoFu solo effettoDel tuo rigor.De’ tuoi seguaciSe a far si vieneSempre in tormentiSi trova un cor.E vuoi, che baciLe sue catene,Che sia contentoNel suo dolor.Se un core annodi,Se un’alma accendi,Che non pretendiTiranno Amor?»
[5] Non vi par egli che la sua musa sia la colomba di Venere, che viene a dissetarsi nella coppa di Anacreonte?
[6] Con non minore felicità, ha egli trasfuse nel suo linguaggio le sublimi bellezze della ebraica poesia, siccome può vedersi nel cantico di Giudita nella Betulia liberata, dove pochi poeti sono arrivati a dipingere l’onnipotenza del dio degli eserciti con colori tanto grandiosi.
«Lodi al gran Dio, che oppresseGli empi nemici suoi:Che combattè per noi,Che trionfò così.Venne l’Assiro intornoColle falangi Perse:Le valli ricoperse,I fiumi inaridì.Parve oscurato il giorno,Parve con quel crudeleAl timido IsraeleGiunto l’estremo dì.Fiamme, catene, e morteNe minaciò feroceAlla terribil voceBetulia impallidì.Ma inaspettata sorteLo estinse in un momento,E come nebbia al ventoTanto furor sparì.Dispersi, abbandonatiI barbari fuggiro.Si spaventò l’Assiro,II Medo inorridì.Né fur Giganti usatiAd assalir le stelle,Fu donna sola, e imbelleQuella, che gli atterrì.»
[7] Nel che è da osservarsi l’artifizio del poeta, il quale ritogliendo dalla orientale poesia tutto ciò che ha di magnifico, ha tralasciate quelle frasi, le quali comechè siano bellissime nell’originale ebraico perché idiomatiche e perché proprie di quella lingua, diverrebbero forse ampollose e gonfie se trasferite fossero nell’italiana.
[8] Niuno meglio di lui ha conosciuta l’indole dell’opera in musica accomodando lo stile lirico alla drammatica in maniera che né gli ornamenti dell’uno nuocono punto all’illusione dell’altra, né la naturalezza di questa s’oppone al pittoresco di quello. Osservisi com’egli adoperi sobriamente lo stil figurato nelle narrazioni e nelle pitture, e lo tralasci del tutto ove parla l’affetto, o si richiede consiglio, o sentenza; Come rado o non mai introduca le comparazioni nel recitativo lasciandole alle ariette quando la musica vuol calore o immagine; Come siano esse per lo più connesse colla scena in maniera che prima di sentirle di già l’uditore ha prevenuto il poeta, antiveggendo qual similitudine debba venir in campo, la qual cosa non accaderebbe se niuna relazione avessero queste colla situazione attuale del personaggio; Come riescano tutte di un’aggiustatezza, varietà, e bellezza sorprendente. Volete la versatile pieghevolezza di ? Vedetela:
«L’onda dal mar divisaBagna la valle, e il monte:Va passaggiera in fiume,Va prigioniera in fonte:Mormora sempre e gemeFinchè non torna al mar.Al mar dov’ella nacque,Dove acquistò gli umori,Dove da i lunghi erroriSpera di riposar.»
[9] La dilicata, e nobile eleganza virgiliana? Sentitela:
«Rondinella, cui rapitaFu la dolce sua compagna,Vola incerta, va smarritaDalla selva alla campagna,E si lagnaIntorno al nidoDell’infidoCacciator.Chiare fonti, apriche rivePiù non cerca, al dì s’involaSempre sola,E finché viveSi rammenta il primo amor.»
[10] Vi piace il fuoco di ? Ravvisatelo in queste poeti cissime strofi:
«Talor se il vento fremeChiuso negli antri cupiDalle radici estremeVedi ondeggiar le rupi,E le smarrite belveLe selveAbbandonar.Se poi dalla montagnaEsce dai varchi ignoti,O va per la campagnaStruggendo i campi interi,O dissipando i votiDe’ pallidi nocchieriPer l’agitato mar.»
[11] V’aggrada piuttosto la foga di , ma senza le sue sregolatezze? Ulisse vi somministra la pruova nell’Achille in Sciro:
«Del terreno nel concavo senoVasto incendio se bolle ristretto,A dispetto del carcere indegnoCon più sdegno gran strada si fà.Fugge allora, ma intanto chi fuggeCrolla, abbatte, sovverte, distruggePiani, monti, foreste e città.»
[12] Nei quali esempi, come generalmente nelle poesie di , è da osservarsi la destrezza colla quale ha egli saputo dare a’ suoi versi quel grado di armonia che è necessaria affinchè la melodia musicale vi si possa insieme accoppiare senza renderli troppo sostenuti e sonori, come sono comunemente i versi dei poemi non cantabili. La morbidezza non per tanto dello stile, una certa mollezza nelle espressioni non meno che nelle immagini, un ritmo facile senza che divenga soverchiamente numeroso, tutte queste cose unite ad una mischianza felice de’ suoni nell’ordine e combinazion delle sillabe sono le qualità che richieggonsi nelle poesie musicali, e sono appunto le doti che caratterizzano lo stile di .
[13] Passando poi all’orditura ed alla scelta de’ suoi argomenti, maraviglioso è il cangiamento introdotto da lui nel dramma musicale. Si pensava per l’addietro che questo fosse un poema consecrato alle favole e da cui per istatuto se ne dovesse sbandire il buon senso. Lo , lo , e più di tutti il hanno smentita la comune opinione facendo vedere che l’opera è capevole di tutta la regolarità, e che i soggetti storici senza sminuirle vaghezza le assicurano una perpetuità che senza essi non avrebbe, cosicché non sono più i deliri dell’antica mitologia, ma la verità, ma la sensatezza quelle che costituiscono la natura del dramma. l’ha avvicinato fino alle soglie della tragedia, né non è questo un picciol trionfo riportata dalla filosofia sulla immaginazione e sul pregiudizio. Osservisi la disinvoltura dell’autore nel presentare gli avvenimenti. Un sol verso, una sola parola gli basta alle volte per far capire ogni cosa. Osservisi l’arte colla quale informa gli spettatori in sul principio di ciò ch’è lor d’uopo sapere, esponendo le circostanze passate e presenti, e preparando per le future senza impaccio, né stiracchiatura, ma con un’agevolezza che fa restare. La prima scena del Temistocle e dell’Artaserse sono in questo genere due capi d’opera di sagacità teatrale. Osservisi come s’affretti sempre allo scioglimento fermandosi sulle varie circostanze quel tanto, e non di più, che conduce a tal fine. Notisi ancora la mirabile sua strettezza e precisione nel dialogizzare quando lo richiede il bisogno, dote la quale contribuisce moltissimo alla bellezza di quelle scene non solo perché tende a schivare le lunghe dicerie dei tragici del Cinquecento, e gli ambiziosi ornamenti di moderni Francesi, ma perché risveglia maggiormente l’attenzione degli uditori, perché ravviva il loro interesse mettendo più di rapidità nelle circostanze, perché rende la musica più unita, e conseguentemente più energica, e perché la scena diventa più viva frammettendovisi molt’azione. Quella azione, che è l’anima del teatro, e la quale sola ha rendute durevoli molte produzioni per altri versi ridicole.
[14] La filosofia è altresì una dote rilevantissima
dell’illustre autore. Non già quella filosofia polverosa, che ristora tanti e tanti
dalla perdita del senso comune coll’acquisto d’una dotta ed orgogliosa ignoranza, non
quel gergo inconcludente usato allor nelle scuole, il quale invece di rischiarar
l’intelletto altro non faceva che adormentarlo nel sogno della più sofistica stupidezza,
ma quella aurea e divina che internandosi agguisa dell’anima universale de’ pitagorici
per entro a tutte le facoltà dell’umano sapere non ischiva di travestirsi sotto il
fascino della eloquenza, o sotto i vezzi dell’armonia affine di stillare più soavemente
negli animi la verità. Qual poeta drammatico ha ottenuto ciò finora meglio di ? Se si riguarda la morale, ovvero sia quella parte
della filosofia che disamina e fortifica i doveri dell’uomo, scienza fra tutte le altre
l’unica degna di considerazione, la sola utile alla misera e travagliata umanità, la
sola che meriti di occupar i riflessi di un essere pensante, chi se n’è renduto più
benemerito di lui? Chi ne ha dipinta la virtù con colori più amabili o si ponga mente ai
magnifici esemplari, ch’ei propone alla nostra imitazione, o le massime importanti qua e
là sparse ne’ suoi componimenti, o la persuasiva, irresistibil maniera colla quale
dispone il cuore a riceverli? Havvene sul teatro antico e moderno un carattere
interessante al par di quello di Tito? Non è egli
le delizie dell’uman genere ne’ suoi scritti, come già le fu sul trono? Non apparisce
forse il vero padre de’ suoi vasalli, il modello dei re cittadini, l’uomo insomma, come
altri disse di Traiano95, nato ad onorare l’umana natura e a
rappresentar la divina? Gli encomiatori della libertà (quel fantasma sublime delle anime
elevate) non sentono eccitarsi all’eroismo contemplando il suo Regolo, e
il suo Catone? E Siroe, Timante, Svenvango, Ezio, Arbace, e Megacle non fanno sì che s’abbia in maggior pregio l’umana spezie? Non si
gioisce di esser uomo sapendo di aver avuto per compagno Temistocle? Non sentesi ognuno compreso da meraviglia e da stupore
ascoltando l’elevatezza de’ sentimenti che gli mette in bocca il poeta in una delle
situazioni più dilicate che possano presentarsi ad un eroe? Atene avealo
ignominiosamente bandito dalle sue mura. Atene il perseguita ovunque, vuol ad ogni modo
averlo nelle sue mani o vivo o morto, manda a bella posta un ambasciatore per chiederlo
a Serse. Serse invece di accondiscendere raduna un’oste possente per far la guerra
agli ateniesi, di cui ne adossa il comando a Temistocle. Questi può vendicarsi della sua patria, viene anzi sollecitato
a farlo non meno da i benefizi di Serse che da un ordine assoluto. Temistocle ricusa l’impegno si espone all’implacabile
risentimento del monarca persiano, subisce la nota d’imprudente e d’ingrato per non
divenir traditore di quella città, ove trasse i natali. «E che
tant’ami in lei?»
gli addimanda Serse sdegnato. Alla quale interrogazione ei risponde:
«Tutto o Signor: le ceneri degli avi,Le sacre leggi, i tutelari numi:La favella, i costumi:Il sudor, che mi costa:Lo splendor, che ne trassi:L’aria, i tronchi, i terren, le mura, i sassi.»
[15] Nelle quali parole egli mi sembra così grande, l’eroismo giugne a segno così eminente che se fra noi si dasse un ostracismo poetico, come presso ai Greci era in uso l’ostracismo politico, il Temistocle di correva rischio di esser di nuovo scacciato dai confini della poesia non altrimenti che il Temistocle di Atene lo fu dai domini della repubblica. Ne’ suoi componimenti si verifica non per tanto il concetto di : che se potesse la virtù farsi vedere ignuda agli occhi degli uomini, tosto ne invaghirebbe di sé tutto l’uman genere. Sì: quantunque fosse privo di mille altri pregi, questo solo basterebbe a rendernelo la delizia dei cuori onesti e sensibili. L’immaginazione dell’uom virtuoso attediata dall’aspetto del vizio trionfante, stanca di vagar per un mondo dove altro non s’offre al suo sguardo che oppressori ed oppressi, sbigottita dagli urli della calunnia che soffocano ad ogni tratto i timidi sospiri della innocenza, annoiata insomma dal commercio dell’uomo, quale il ritrova comunemente o debole, o maligno, o piccolo, o brutale, va per consolarsi agli scritti di questo amabile poeta, come ad un mondo immaginario, che la ristora delle noie sofferte nel vero. Ivi gode d’un cielo men tempestoso, ivi respira un’aria più degna di sé, ivi conversa con uomini che fanno onore alla divinità, onde si scorge balenare sugli occhi quella luce primitiva del grande e del bello, che attesta la sua origin celeste.
[16] Riflettasi quanto sia naturale il suo sentenziare e non pedantesco, come quello di , che ti pare un ragazzo sortito or ora dal liceo, o come quello dei francesi moderni che t’intassano a torto e a traverso qualunque argomento con lunghi squarci d’insipida metafisica in ciascuna scena. Al che non poco ha contribuito l’esempio di , sebbene cotal difetto venga nel suo teatro abbastanza ricompensato da altre doti luminose. All’opposto le sentenze di sono opportunissime, tratte sempre dalle circostanze o dalla passione. Alle volte è una conchiusione che si ricava da tutto il dramma, come nel fine dell’Artaserse:
«Della vita nel dubbio camminoSi smarrisce l’umano pensier;L’innocenza è quell’astro divino,Che rischiara fra l’ombre il sentier.»
[17] Alle volte è una serie di riflessioni che nascono spontaneamente in una persona incalzata da quanto ha di più vivo il dolore. Così è naturalissimo che Timante disposto a morire prorompa:
«Perché bramar la vita? e qual piacereIn lei si trova? Ogni fortuna è pena,È miseria ogni età: Tremiam fanciulliD’un guardo al minacciar: Siam giuoco adultiDi fortuna, e d’amor: Gemiam canutiSotto il peso degli anni. Or ne trafiggeLa brama di ottenere: or ne tormentaDi perdere il timore. Eterna guerraHanno i rei con se stessi: i giusti l’hannoColl’invidia, e la frode: Ombre, deliri,Sogni, follie son nostre cure, e quandoIl vergognoso erroreA scoprir s’incomincia, allor si muore.»
[18] L’ubertosa facondia di potrebbe dirlo meglio in un intiero discorso? Altre volte sono brievi sentimenti istruttivi, come:
«Soglion le cure lievi esser loquaciMa stupide le grandi.»
Copiato da :
«Curae leves loquuntur, ingentes stupent.»
[19] Ma s’avverta in qual guisa l’autore applichi ai casi individuali le massime generali, nel che consiste il vero filosofar del dolore, il qual rare volte si esprime per teoremi assoluti, spezialmente allorché è subitaneo e vivo. Così nell’esempio testé accennato la parola “sogliono” rende più adattata e più naturale la sentenza che profferita genericamente, come in , ha l’aria di un apotegma scolastico. Osservisi ancora di qual impareggiabile poetica venustà rivesta egli gli argomenti più astratti della filosofia; come fra le sue mani le cose più spinose fioriscano, avverandosi colla magia della sua musa la favola di Armida che cangiava in giardini i deserti.
[20] È quistione fra i critici illuminati se possano degnamente trattarsi in poesia gli argomenti metafìsici, attesa la difficoltà che si ritrova nel combinare la precisione colla chiarezza, la catena delle idee cogli ornamenti dello stile, e la severità della ragione colle licenze del colorito poetico. né vi mancò un rinomato scrittor francese, che ha sentito molto avanti nella filosofia delle arti immaginative96, il quale condannasse per aver trascelto a soggetto delle sue lettere sopra l’uomo una materia cotanto specolativa ed astratta, parendo a lui che più gran senno avrebbe fatto il poeta inglese e meglio assai provveduto alla propria fama se mai non avesse gettata la falce a coglier tal messe97. Nientedimeno ha fatta vedere che niun oggetto è inferiore alla fecondità della imitazione poetica. Si direbbe che il di lui genio fosse la dea Clori dei Greci, che volando per l’aria spargeva nembi di rose ovunque passava. Quale argomento più profondo e più rigoroso che le prove della esistenza d’Iddio. Qual altro più vero, e insiem più nemico del libertinaggio della immaginazione? Eppure la felicità, con cui se ne spedisce, ha qualche cosa di sorprendente. Il dialogo tra un vero credente e un idolatra è tolto dalla Betulia liberata:
«Achiorre. Ma non ti bastaCh’io veneri il tuo Dio?Ozia. No. ConfessarloUnico per essenzaDebbe ciascuno, ed adorarlo solo.Ach. Ma chi solo l’afferma?Oz. Il veneratoConsenso d’ogni età: degli avi nostriLa fida autorità. L’istesso Dio,Di cui tu predicastiI prodigi, il poter: che di sua boccaLa palesò: che quandoSe medesmo descrisse,Disse: Io son quel che sono: e tutto disse.Ach. L’autorità de’ tuoi produci invanoCon me nemico.Oz. E ben. Con te nemicoL’autorità non vaglia. Uom però sei,La ragion ti convinca. A me rispondiCon animo tranquillo. Il ver si cerchiNon la vittoria.Ach. Io già t’ascolto.Oz. Or dimmi.Credi, Achior, che possaCosa alcuna prodursiSenza la sua cagion?Ach. No.Oz. D’una in altraPassando col pensier, non ti riduciQualche cagione a confessar, da cuiTutte dipendan l’altre?Ach. E ciò dimostra,Che v’è Dio; non ch’è solo. Esser non ponnoQueste prime cagioni i nostri Dei?Oz. Quali Dei, caro Prence? I tronchi, i marmiSculti da voi?Ach. Ma se que’ marmi a’ saggiFosser simboli sol delle immortaliEssenze creatrici; ancor diresti,Che i miei Dei non son Dei!Oz. Sì, perché molti.Ach. Io ripugnanza alcunaNel numero non veggo.Oz. Eccola; un DioConcepir non poss’io,Se perfetto non è.Ach. Giusto è il concetto.Oz. Quando dissi perfettoDissi infinito ancor.Ach. L’un l’altro include;Non si dà chi l’ignori.Oz. Ma l’essenze, che adori,Se son più son distinte, e se distinteHan confini tra lor. Dir dunque deiChe ha confin l’infinito, o non son Dei.Ach. Da questi lacci in cuiM’implica il tuo parlar (cedasi al vero)Disciogliermi non so. Ma non per questoPersuaso son io. D’arte ti cedo,Non di ragione. E abbandonar non voglioGli Dei, che adoro e vedo,Per un Dio che non possoNè pure immaginar.Oz. S’egli capisseNel nostro immaginar, Dio non sarebbe.Chi potrà figurarlo? Egli di partiCome il corpo non costa: Egli in affetti,Come le anime nostre,Non è distinto: ei non soggiace a forma,Come tutto il creato: e se gli assegniParti, affetti, figura, il circonscriviPerfezion gli togli.Ach. E quando il chiamiTu stesso e buono, e grande,Nol circoscrivi allor?Oz. No: buono il credo.Ma senza qualità. Grande, ma senzaQuantità, né misura. Ognor presente,Senza sito, o confine: e se in tal guisaQual sia, non spiego, almen di lui non formoUn’idea, che l’oltraggi.Ach. È dunque vanoLo sperar di vederlo.Ozia. Un dì potrestiMeglio fissarti in lui: ma puoi fra tantoVederlo ovunque vuoi.Ach. Vederlo! E come?S’immaginar nol so?Oz. Come nel soleA fissar le pupille invano aspiri,E pur sempre, e per tutto il Sol rimiri:Se Dio veder tu vuoiGuardalo in ogni oggetto:Cercalo nel tuo pettoLo troverai con te.E, se dov’ei dimoraNon intendesti ancora,Confondimi, se puoi,Dimmi dov’ei non è.»98
[21] Io non so se vagliato che fosse e sceverato il grano che si ritrova nelle opere di e di , che passano per le più profonde in questo argomento99, si potesse ricavare di più di quello, che con tanta scioltezza e precisione dice qui il . Lo stesso si dee dire delle discolpe della providenza inserite nell’Astrea placata, delle accuse e difese delle passioni, dell’apologia dell’amore di se stesso, di quella della poesia e dell’arte drammatica con cent’altri punti di morale filosofia sparsi qua e là ne’ suoi drammi. Insomma è decisivamente (nè se ne sdegni il ) il primo poeta filosofo della sua nazione.
[22] Nè di meno gli è debitrice l’arte della decorazion teatrale. Questo pregio inosservato finora da quasi tutti coloro che leggono meriterebbe un ragionamento a parte per far vedere con quanta destrezza abbia egli meneggiato un ramo così interessante del melodramma. L’uomo di gusto vi osserverebbe con meraviglia la fecondità nell’immaginare i luoghi convenienti alla scena, la maestria con cui fa egli variare le situazioni locali, la dilicatezza nel distinguere quelle che possono dilettar l’immaginativa dello spettatore dalle altre che potrebbero infastidirla, la finezza, il sempre gradevole e non mai repugnante contrasto che mette fra le scene che parlano agli occhi, la varia e moltiplice erudizion che si scorge nella geografia, nei riti, nei prodotti, nelle foggie di vestire di ciascun paese, in tutte quelle cose insomma, che rendono magnifico insieme e brillante un teatrale spettacolo. Il decoratore conoscerebbe con sicurezza il campo che liberamente può scorrere la fantasia nelle invenzioni drammatiche senza rapir i suoi diritti al buon senso, troverebbe nel piano di ciascuno de’ suoi componimenti il segreto ma costante rapporto che dee metter l’arte fra la musica e la prospettiva, o ciò ch’è lo stesso fra l’occhio e l’orecchio ne vedrebbe quante fatiche gliene abbia risparmiato il poeta , qual folla di mezzi indicati a fine di preparare, mantenere, ed accrescere l’illusione, quanti germi d’invenzione, quai lampi di genio pittorico somministratigli ora nei cangiamenti di scena, or nelle pitture vaghissime, che scorgonsi ad ogni tratto ne’ suoi componimenti.
«Sammete assale furioso le guardie reali, e si disvia inseguendone alcune alla sinistra. Intanto fra il baleno de’ frequenti lampi, fra il rimbombo de’ tuoni, e fra il mugito marino, a vista delle navi, e de’ nocchieri, balzati dall’onde e sospinti dal vento si urtano fra di loro, si frangono, e si sommergono in parte; siegue collo strepito di tumultuosa sinfonia nella spiaggia e nel porto ostinato combattimento fra le squadre di Sammete e le guardie reali, vincitrici al fine rincalzando gli altri, lasciano vuota la scena. Verso il fine del combattimento cessa a grado a grado il furore della tempesta, si va rasserenando il cielo, e l’Iride comparisce.»
[23] Ecco un quadro del Le Brun nella galleria della Nitteti:
«Edonide conduce Alcide a seder seco in disparte: e quindi ad un suo cenno si cangia in un istante la scena opaca e selvaggia nell’amena e ridente reggia del piacere. La compongono cappricciosi edifizi d’intrecciate verdure, di pellegrine frutta, e di rari e distinti fiori. Ne variano artificiosamente la vista l’ombre interrotte di nascenti boschetti, o la ravvivano per tutto le diverse acque, le quali o scherzano ristrette ne’ fonti, o serpeggiano cadendo fra i sassi delle muscose grotte liberamente sul prato. È popolato il sito di numerose schiere di geni e di ninfe seguaci della Dea del Piacere, le quali e col canto e col ballo esprimono non meno il contento dell’allegro stato in cui si ritrovano, che la varietà delle dilettevoli occupazioni che le trattengono.»
[24] Ecco un quadro dell’Albano nell’Alcide al Bivio. È da osservarsi generalmente il gran giudizio di nell’esporre agli occhi quei colpi di scena soltanto che possono dignitosamente, e con decoro eseguirsi dagli attori. nell’Iside ci fa vedere una furia, che afferrando pei capegli una fanciulla, la cava fuori del mare cogli abiti bagnati. Non può negarsi che il poeta francese non possegga per eccellenza il talento di parlar agli occhi sul teatro, ma non è questa, a dirne il vero, l’occasione dove lo manifesta. Un italiano non avrebbe osato di esporre una situazione cotanto difficile per non dire cotanto ridicola; egli che ama meglio peccar di monotonia facendo andar a lieto fine tutti i suoi drammi di quello che sia costrigner un protagonista a morir cantando sulle scene a guisa di cigno.
[25] Ma quello che forma il suo carattere dominante, quello che
il rende la delizia delle anime sensibili, quello che esige principalmente l’universale
riconoscenza dei lettori per le lagrime, che ha cavate loro dagli occhi, si è l’arte di
muovere gli affetti. La sua eloquenza è il «lene tormemtum»
di applicato al cuore. Ed è appunto per questo pregio
inarrivabile che l’autore ebbe ragione di dire parlando colla sua cetra.
«Quella cetra ah pur tu sei,Che addolcì gli affanni miei,Che d’ogni alma a suo talentoD’ogni cor la via s’aprì.»
[26] Nessun altro poeta dentro o fuori d’Italia è paragonabile con lui in questo genere. Il solo può contrastargli la preferenza, né io dubito che non si trovino alcuni che la daranno più volentieri al francese, scorgendo forse nel suo poetare stile più lavorato, maggior verità nella espressione, caratteri più forti e più teatrali, piani orditi più destramante, sceneggiare più unito, e sviluppo di passione più continuato e meglio preparato. Ma senza negar cotai pregi a , io non credo già che più facile divenghi per questo la decisione, ripensando al diverso genere in cui scrissero entrambi. La tragedia è fatta per appagar la ragione e il cuore. Quindi dee principalmente badare al collegamento ed unità dell’azione, e alla pompa del dialogo; qualità che apportano seco maggior unione nelle scene, più d’ornamento nei discorsi, e sviluppo più circostanziato nelle cose. E tutto ciò è stato egregiamente fatto dal . L’opera, non iscompagnandosi mai dalla musica, dal canto, dalla danza e da gran decorazione, ha per oggetto il piacere non meno che alla ragione all’orecchio e all’immaginazione. Quindi dee render lo stile più lirico, frammetter gran illusione teatrale, sfuggire i nodi troppo complicati, troncar molte circostanze, passar insomma rapidamente da una situazione in un’altra, acciochè si renda più brillante e più viva l’azione. Lo che il ha mirabilmente ottenuto; Onde la quistione pende dubbiosa, e l’Italia potrà sempre contrapporre ai Francesi il suo senza temerne il paragone.
[27] La felicità, che si manifesta in alcuni squarci delle sue poesie, farebbe quasi credere che questo incomparabil poeta spicasse soltanto nella parte lirica del melodramma; ma quale altissima stima non fa d’uopo concepire de’ suoi talenti in veggendo che egli è anche superiore a se stesso nella parte patetica? Si leggano quasi tutte le scene, s’osservi gran parte de’ suoi recitativi, e in principal modo le arie e i duetti, e si vedrà quai copiosi fonti di espressione, quali miniere inesauribili di tragica sensibilità abbia egli aperte ai compositori che le pongono in musica. Appena in cento si troverà un’aria che non rappresenti una situazione che non isviluppi un carattere, che non esibisca una varia modificazione di affetto. Là senti le disperazioni d’un genitore, che lacerato da più crudeli rimorsi crede di vedersi ad ogni passo l’ombra insanguinata del figlio morto per cagion sua, che l’inacerbisce e l’incalza; qua vedi le smanie di una madre, la quale per comando di disumana legge condotta a morire, niun pensiero si prende del proprio destino, ma sollevando verso il cielo i non contaminati sguardi, chiede ai numi che accrescano al figlio ed allo sposo quegli anni di vita che a lei barbara sorte contende. Ora ascolti il terrore umiliante di un’ambiziosa regina, la quale in faccia allo stesso santuario ch’essa meditava di profanare, sente aggravarsi sul suo capo la mano vendicatrice dell’onnipotente, a’ cui cenni la morte e la natura non che i turbini e le tempeste s’affrettano ad ubbidire; ora ti si appresenta uno spettacolo degno dei numi, cioè il dolore sublime d’un eroe che si vede accusato dal proprio padre in presenza del re, in vista di tutta la corte, e sugli occhi dell’oggetto che adora, di un delitto, del quale il solo reo è lo stesso accusatore. In quella sgorga il virtuoso pianto d’un principe modello de’ regnanti, che obbligato a condannar un amico trovato deliquente si lagna cogli dei perché, lasciandogli il suo cuore, gli abbiano fatto il dono d’un impero; in questa ti laceran l’anima i trasporti misti di rabbia e di pietà, coi quali si esprime una vedova costretta a scegliere uno di questi due mezzi, o di dar la mano di sposo ad un suo odiatissimo nimico, o di vedersi uccider sotto gli occhi l’unico suo figliuolo.
«Prenditi il figlio… Ah no:È troppa crudeltà.Eccomi… oh Dei! Che fo?Pietà, consiglio.
[28] Che quadro energico ed animato per chi ha un cuore sensibile! Andromaca piangente ancora sulla morte di Ettore. Pirro ebbro d’amore per lei e feroce per la conquista di Troia. La fedeltà alla memoria dello sposo, la tenerezza per il figlio, l’odio per il tiranno, lo smarrimento, l’abbandono, l’agitazione dell’una, l’inflessibilità, la ferocia e il despotismo dell’altro. La dubbiezza dell’esito, e il timore su qualunque partito si debba prendere. Il riflesso sulle caducità umane, che riducono talvolta una gran principessa ad uno stato peggior di quello d una schiava. Le lagrime del filosofo sul misero destino della virtù. Le transizioni mentali, le reticenze, i rapidissimi, e pressoché impercettibili passaggi delle passioni… Tutto ciò qual gruppo non contiene di sensazioni e d’idee per l’uditore? Qual varietà d’inflessioni patetiche per il cantante? L’uomo di gusto può bensì conoscerle, ma non s’appartiene che al solo genio il trovarle. Lungo sarebbe anche il voler brievemente accennare tutti i luoghi ove maneggia inimitabilmente le passioni, e con pennello incantatore le colorisce: la maniera con cui tratta l’amore merita nondimeno qualche riflessione.
[29] Da una parte lo spirito di cavalleria sparso in tutta l’Europa dopo l’invasione degli arabi, e dopo i viaggi fatti in terra santa, celebrato da poeti siciliani e provenzali, e rapidamente promosso da quella epidemia di romanzi che facevano pressoché la sola letteratura di quei tempi: Dall’altra il sistema di abbellito prima in Italia dalla gentilissima musa del , indi reso comune pel mezzo dei Greci fuggiaschi che vi si annidarono, aveano nel regno d’amore introdotta un’aria di novità sconosciuta fin’allora negli annali dell’universo. Ne’ pubblici costumi esso era una spezie di adorazione che si tributava alle donne considerate come oggetti pregievolissimi, i quali acquistar si dovessero a forza di eroismo. Una settimana di corteggio e una bagattella bastano in oggi per meritare l’attenzione delle belle: ci voleva in allora la metà della vita, gli errori d’Ulisse e le dodici fatiche d’Ercole. Ne’ libri altro non era che una metafisica sottile assai comoda pei filosofi che vi trovavano aperto un vastissimo campo alle loro teorie chimeriche, e non men utile per i poeti, i quali scorgevano per entro a quelle illusioni dell’affetto una sorgente di bellezze sconosciute ai , alle ed ai , ma egualmente incomoda per le persone troppo sensibili, che risentivano in se stesse principi contrari a filosofia cotanto sublime. Col girar del tempo le circostanze si cangiarono. Sparì lo spirito di cavalleria coll’abolizione dell’anarchia feudale, e collo stabilimento delle monarchie. Passaron di moda quei romanzi banditi colla sferza del ridicolo dall’immortale autore del Don Chisciotte. I brillanti sogni di si dileguarono, allorchè spuntò sull’orizzonte europeo l’aurora della vera filosofia. Il divinizzato finallora da suoi adoratori si riumanò, a così dire, per mezzo della critica imparziale e della copia de’ confronti. Le donne finalmente stanche di veder sempre l’amore nelle aeree regioni si compiacquero di farlo scendere, e di renderlo men filosofico. Dal che avvenne quello, che suole quando s’abbandona un sistema, cioè che per lo più si prende il partito opposto. Allora l’amore altro non fu che un commercio materiale di voluttà, nel quale i poeti s’ingegnavano di ricompensare i sensi del lungo imperio che aveva sopra di loro esercitato l’astratta ragione. alzò lo stendardo, indi l’, l’autore del Pastor fido con una folla di poeti minori di loro accrebbero la rivoluzione con vantaggio della mollezza e della vivacità, ma con iscapito della dilicatezza e dei costumi. Cercarono bensì alcuni scrittori d’opporsi alla general corruzione, tra gli altri , il , lo e il , insegnando negli scritti loro la foggia platonica di amare, e facendo scender di nuovo tra gli uomini quella vergine celeste, che avea servito di modello al Petrarca, e che esserne dovea l’archetipo delle donne nei versi de’ cinquecentisti. Ma cotal frasario dell’ipocrisia amorosa rimase confinato senz’alcun uso ne’ dialoghi e ne’ sonetti. Il secolo dedito intieramente alla voluttà ed alla licenza ripose tra le favole poetiche l’amore eroico del tempo de’ paladini, e rimandò gli aerei ragionamenti degli scioperati scrittori al mondo della luna, dove lungo tempo si conservarono, e si conservan tuttora accanto al senno d’Orlando, insiem coi servigi che si rendono ai grandi, colle parole de’ politici, colle lagrime delle donne, e colle speranze dei cortigiani.
[30] Fra questi due estremi egualmente lontani dal vero scopo della natura, perché egualmente discosti dall’essenza dell’uomo, il quale composto da due sostanze diverse non ha affezione che non sia mista, né esigenza che non partecipi della influenza di entrambi principi: fra questi estremi inapplicabili l’uno e l’altro alla imitazion teatrale, quello perché troppo spirituale e forse chimerico, e questo perché troppo sconcio ed abietto; il ha trovato il solo mezzo che conviene al teatro, che è quello di depurar la natura, e di combinar la ragione con la sensibilità riponendo la forza di codesta inesprimibile e seducente passione non meno nelle attrattive della virtù che in quelle della bellezza. Col quale avvitamento tanto più agevolmente è divenuto signore degli animi quanto che le persone gentili gli appone il loro spontaneamente, nulla temendo da lui che allarmar possa il loro pudore, anzi trovandovi dipinta al vivo la propria situazione artifiziosamente scolpata. è quell’autore favorito cui tutti hanno vaghezza di leggere. Gli uomini perché vi ritrovano la vera copia dell’originale che hanno dentro di sé. Le donne perché niun altro scrittore fa loro conoscer meglio la possanza sorprendente della bellezza e l’ascendente del loro sesso. Difatti veder umiliato a’ piedi di Deidamia quell’Achille lo spavento di Troia e l’oggetto il più caro delle premure dei numi; osservar pendente dai cenni di Fulvia quell’Ezio che rassicurò il volo delle aquile romane sbigottite dal furore di Attila; sentir sospirare fra gli allori trionfali un Cesare arbitro del destino del mondo, e di quello di Catone; contemplar un Alessandro innanzi al cui cospetto la terra s ammutolì, fermar il rapido corso delle sue conquiste per disputare contro un barbaro re il possesso di un cuore; scorger la virtù, la sapienza, la grandezza, il valore, in una parola quanto avvi fra gli uomini di più cospicuo, e di più rispettabile prostrato innanzi al simolacro della bellezza tributarle fiori ed incenso, offrirsi volontariamente al servaggio, baciando inoltre la mano che l’incatena. Qual motivo non è mai questo d’inesplicabile compiacenza per un sesso, che ritrova nelle proprie attrattive la ricompensa della sua dipendenza, e che mai non si piega a servire se non per meglio signoreggiar sul padrone?
[31] Niuno ha sentito tanto avanti quanto nella filosofia dell’amore, filosofia la quale benché facile sembri a comprendersi, perché comune alla maggior parte del genere umano e perché appoggiata sul sentimento, è tale, nonostante, che da sommi poeti drammatici non è stata conosciuta abbastanza: eppure erano , e . Niuno l’ha dipinto con più genuini colori ora rendendo visibili i sentimenti più ascosì, ora simplificando i più complicati, ora smascherando le più illusorie apparenze. Basta non che altro leggere l’Asilo d’Amore per ravvisarvi dentro un compiuto filosofico trattato, dove coi più vaghi colori della poesia tutti si veggono espressi i morali sintomi di questa passione con finezza e verità superiori di gran lunga al pomposo e inintelligibile gergo con cui vien trattata da la stessa materia nel suo Simposio. Niuno l’ha egualmente ingentilito rimuovendo da esso ogni basso interesse, appoggiandolo sulla base fondamentale dell’animo e accomunandolo colla dilicatezza cortigianesca. Niun’altro possiede un sì alto grado l’eloquenza del cuore, né sa meglio di lui porre in movimento gli affetti, inviluppar gl’interessi e metter l’uno a cimento coll’altro, rilevar distintamente le circostanze che concorrono in un’azione, radunarle poi tutte nell’occasione, spiar i motivi più immediati, i più spediti, i più confaccenti col carattere della persona e più legati col suo particolar interesse. I suoi tocchi sono sempre da gran maestro chiari insieme e profondi, teneri e sublimi. Egli è leggiero come , dilicato come , insinuante come , conciso e grande come . Egli accorda coll’armonia della greca lira i caratteri romani, l’urbanità francese e l’italiana sensibilità.
[32] Mosso da tali ragioni il Signor irlandese in un libro italiano, il quale ha per titolo Consigli dati ad un giovine poeta, non ha dubitato di asserire che fosse il maggior poeta che abbia mai veduto l’Italia dirimpetto ancora all’ ferrarese. Un colto veneziano rapito poc’anzi alle lettere che scrisse tre lettere in risposta contro di lui, mostrò scandalezzarsi di siffatta asserzione a segno di creder quasi ingiurioso all’ il solo confronto col . Un pò troppo di prevenzione a favor degli antichi, e il pregiudizio di certa classe di letterati contro il genere in cui si esercitò , regolarono senza dubbio in questa critica la penna dell’abate . Non può negarsi che riflettendo a quella fecondità prodigiosa dell’, che fila sì complicate e moltiplici per la lunga e difficil carriera di quarantasei canti continui è costretto a condurre: a quella varietà che maneggia tutti gli stili, che dipinge tutti i caratteri e che trascorrer fa il lettore dal sommo all’infimo con fortunatissimo volo; a quella evidenza di pennello, che atteggia ogni movimento, che colorisce ogni muscolo e che ti fa quasi vedere e toccare le cose rappresentate; a quella forza che pareggia in alcuni caratteri quella d’, e che supera in molti la forza di ; a quella brillante ed ardita immaginazione, la quale tante e sì maravigliose stranezze gli fa trovare per via, e che sì eccellente il rende in ogni genere di descrizioni; a quella inarrivabile schiettezza di stile aureo sempre ed ingenuo, onde s’arricchisce di mille forme diverse la patria lingua, si dilatano i confini della elocuzione poetica, e il più compito esemplare si ricava d’imitazione. Riflettendo, io dico, a tutto ciò, pare che la bilancia del genio dovesse senza contrasto piegare verso il gran cantore di Orlando. Ma dall’altra parte egli è vero altresì che quanto è più difficile a dipinger bene l’anima combattuta di Regolo che il corpo ignudo d’Olimpia, la clemenza sublime di Tito che i colpi di Mandricardo, la situazione di Temistocle nella reggia di Serse che le pazzie del Signor d’Anglante per le campagne; quanto è più pregievole strappar dal cuore gli affetti che descrivere i palagi incantati, penetrare ne’ più intimi nascondigli dell’animo umano che crearsi un mondo fantastico nel globo della luna, far parlare ed agir la natura che scioglier pazzescamente la briglia alla immaginazione; quanto è più utile richiamar il bel sesso col mezzo d’una incantatrice eloquenza alla imitazione di Beroe e d’Aristea che il prostituire i più trillanti colori della toscana poesia dipingendo gli osceni atteggiamenti di Fiammetta, e di Alcina, l’intrecciar cogli eterni fiori della virtù il talamo coniugale di Zenobia, e di Dircea che l’avvilir la dignità d’un poema cogli infami racconti di Medea e di Argia, il rapir dal crine le sue rose alla voluttà per incoronare l’innocenza che il sacrificar questa ad ogni passo sull’altare della dissolutezza; quanto è più interessante un poeta che soddisfa nel medesimo tempo a più facoltà dell’uomo che un altro che non soddisfa se non a poche, uno che rinforza e riunisce i piaceri di tutte le belle arti che un altro che diletta col solo mezzo della poesia, uno che alle difficoltà del genere drammatico accoppia quelle che nascono dalla influenza della musica e della prospettiva sulla tragedia che un altro il quale ne schernisce ogni poetica legge, ne deride ogni esempio, e ne soverchia ogni regola, tanto più il paralello fra ed divien favorevole al primo. Egli sarebbe forse miglior consiglio trattener il suo giudizio intorno a siffatto confronto, essendo più agevole il dubitare che l’asserir qualche cosa, e mettendo la diversità del poetico genere un inciampo non lieve a chi sensatamente ne volesse giudicar dei poemi. Ad ogni modo però se qualcheduno m’addimandasse il mio sentimento; se non mi fosse permessa la scelta fra la prudenza che ne schiva il cimento e il comando che rende indispensabile l’ubbidienza; se dopo di avere lungo tempo tacciuto io fossi pur costretto a decidere, illustre ! onor d’una nazione, che t’adorava nella tua vecchiaia dopo averti abbandonato nella tua giovinezza, e che vide con giubbilo premiati in un altro paese quei rari talenti ch’essa avrebbe dovuto conservare nel proprio, sì, tu saresti la Venere cui donerei il pomo della bellezza.
[33] E tanto gliel donerei più volentieri quanto che la sua
influenza sul gusto italiano e su quello delle altre nazioni è stata maggiore di quella
dell’ e di qualsivoglia altro poeta.
L’Italia non dee considerarlo soltanto come scrittore
eccellente di melodrammi, nel qual genere non ha avuto l’eguale finora, ma gli è
debitrice in parte eziandio di quella perfezione alla quale giunsero nella trascorsa età
e nella presente le arti del canto e della composizione. I , i , i , i , i
, i , i , e tanti altri insiem
coi Farinelli, coi Caffarielli, coi Gizzielli, coi
Guarducci, coi Guadagni, e coi Pacchiarotti
possono con qualche ragione chiamarsi gli allievi del , essendo certo che a tanta maestria non sarebbero giammai
pervenuti se non fossero stati riscaldati dal di lui fuoco, e perfezionati non avessero
nelle opere sue i propri talenti. La poesia e la musica sono come il testo
d’un’orazione, e il commento; ciò che dice questo non è che un’amplificazione, uno
sviluppo di quanto accenna quell’altra, e siccome è impossibile o almeno difficile
lavorar una musica espressiva su parole insignificanti, così un compositore ed un
cantante trovano per metà risparmiata la fatica qualora il poeta somministra loro
varietà e ricchezza d’inflessioni musicali. Siamo nel caso di colui che dovendo
fabbricar un palazzo, si vede costretto a sceglierne tra i disegni d’un maestro
dozzinale, o tra quelli d’un valente architetto. Se la sua cattiva sorte il fa
inciampare in alcuna dei primi, per quanto ingegno abbia egli sortito dalla natura, per
quant’arte ne adoperi nell’abbellir l’edifizio sempre si scorgeranno nella esecuzione i
vizi dell’esemplare. All’opposta se lavora su qualcheduno degli altri, egli sentirà
svegliarsi in lui le idee sublimi del bello, le proporzioni verranno a combinarsi
spontaneamente nella sua mente, le vaghezze, e gli ornamenti gli si presenteranno
innanzi senza contrasto, ed ei si crederà di esser grande per aver battuta la strada
additatagli da un altro più grande di lui. Il paragone non può camminar meglio.
è il Palladio e il Vignola, e i maestri
sono gli esecutori. Quindi con non minor verità che eloquenza si espresse il filosofo di
Ginevra parlando coi giovani che desiderano di conoscere se la benigna natura ha loro
trasfusa nell’anima alcuna particella di quella fiamma celeste, che vien compresa sotto
il nome di genio. «Voi tu saperlo?»
egli dice. «Va, corri a
Napoli, ascolta i capi d’opera di , di , , e . Se
i tuoi occhi sono inondati dalle lagrime; se senti palpitarti in petto il cuore; se i
singhiozzi soffocano il tuo respiro, prendi il , e lavora. Il suo genio riscalderà il tuo; tu sarai creatore
al di lui esempio, e gli occhi altrui ti renderanno ben tosto quei pianti ch’egli ti
avrà costretto a versare.»
101 Ma per risentire
cotali effetti fa d’uopo avere uno spirito analogo a quello dell’autore che si prende
per guida; fa d’uopo esser invaso da quella energica e rispetabile follia del bello, che
caratterizza gli amabili favoriti della natura. Bisogna saper versare delle lagrime per
tenerezza, come avvenne a componendo la
sua Olimpiade, e rendersi capace di quell’astrazione imperiosa che rapiva
il Parmigianino a se stesso, il quale nel sacco
dato a Roma a’ tempi di Clemente
Settimo non sene accorse dei soldati ch’erano entrati a depredar la sua
casa, mentre stava egli pacificamente dipingendo nel suo gabinetto.
[34] Ecco ciò che può rapidamente dirsi circa il merito di . Nessuno m’incolperà con ragione o di non averlo conosciuto abbastanza, o di averlo malignamente tacciuto. L’entusiasmo cui mi sono abbandonato lodandolo, mi metterà, cred’io, al coperto di siffatta accusa. Ma io non avrei che per metà eseguito il disegno di quest’opera se dopo averne additate ai giovani le virtù che possono imitare nel nostro amabil poeta, non avesse anche il coraggio d’indicar loro i difetti, dai quali debbono tenersi lontani. I vizi dei grandi artefici sono più pericolosi degli altri ai progressi dell’arte, perché autorizzati da un più eccellente esemplare. Allora l’errore confuso colla verità si divinizza insieme con essa sulle are del pregiudizio, e lo stolido volgo dei lettori somigliante agli antichi abitatori dell’Egitto adora il fango del Nilo credendolo un germe di divinità. Osiamo dunque esser giusti per amore del vero. Esaminiamo se quest’idolo della Italia dia contrassegni di esser uomo da qualche banda. E se nelle nostre ricerche venisse a disturbarci alcun senso di timidezza, ricordiamoci che mai non fu riputato sacrilegio per chi che fosse il riguardar con occhio di artefice i simolacri dei numi, e che niuno s’avvisò di accusare di fellonia quel filosofo che osò il primo di tutti descriver la carta astronomica delle macchie del sole.
[35] Altri disputeranno se il debba dirsi unico nel suo genere, o s’abbia trovato in un rivale degno di contrastargli la gloria. Io, che non voglio entrare in litigi di preferenza tra due nazioni così rispettabili, mi contento di dire che sebbene il sia un autore grandissimo vituperato a torto dal satirico ; sebbene sia preferibile al nella invenzione, avendo egli creato da pianta in Francia il dramma musicale, che trovò di già molto avanzato e ripolito in Italia per opera massimamente di ; sebbene l’adegui nel numero, armonia, rotondità e pieghevolezza del verso per quanto lo comporta l’indole della lingua francese più ruvida dell’italiana; sebbene la prospettiva, e tutto ciò che appartiene alla decorazione, abbia, generalmente parlando, più luogo nei drammi dell’autore di Armida, e di Orlando che in quelli dell’allievo di , nonostante questo il è molto al di sotto di non solamente nel maneggio d’una lingua più bella, ma nella scelta ancora degli argomenti più fecondi di passione e più atti alla melodia, nella pittura dei caratteri più difficili e più interessanti, nell’uso delle sentenze e della filosofia pressoché sconosciuta a , nella sensatezza del piano, nella regolarità dell’andamento e nella rapidità delle scene. Veggasi da un solo esempio il carattere poetico di entrambi:
«Régnez, divin sommeil, régnez sur tout le monde,Répandez vos pavots les plus assoupissants:Calmez les soins, calmez les sens.Retenez tous les cœurs dans une paix profonde.Coulez, murmurez, clairs ruisseaux;Ne faites point de violence:Il n’est permis qu’au bruit des eauxDe troubler les douceurs d’un si charmant silence.»
[36] Chi gusta la lingua francese troverà questi versi d’un’armonia e pienezza mirabile. Ma con quanto maggior grazia, brevità e disinvoltura si dice lo stesso dal ?
«Mentre dormi Amor fomentiIl piacer de’ sonni tuoiColl’idea del mio piacer.Muova il rio passi più lenti,E sospenda i moti suoiOgni Zeffiro leggier.»
[37] Così si vincono gli autori imitandoli. Una cosa che non dee tralasciarsi in favor suo, si è la preferenza che ha egli sul poeta francese nella parte più interessante di questo genere di poesia, qual è senza dubbio la composizione dell’aria. I drammi del altro non sono che un continuato recitativo. In quanto alla spezie di canto compreso in due o più strofi liriche, le quali chiudono un sentimento preciso su cui si forma poscia il motivo musicale, e che dee con ragione chiamarsi il capo d’opera del teatro drammatico, si può assicurare ch’egli appena lo conoscesse; circostanza che renderà a poco a poco pressoché inutili i suoi componimenti non potendosi accomodare senza guastarli al genio della odierna musica.
[38] Altri esamineranno se sia da imitarsi senza precauzione quel suo stile sempre liscio e sempre in cadenza, quei sensi mozzi e tronchi per lo più nella stessa cesura, quei periodi troppo uniformi e ristretti alla foggia francese, e se debbano commendarsi senza eccezione certe sue frasi, come sarebbe a dire:
«Svenare gli affetti,Opprimere in seno la fiamma adorata del cuore,Tu sei l’ornamento de miei sudori,Quel segreto è un arcano,Riandando l’idea,Troncar il canape reo dei legni»,
e tali altri modi di dire, che da qualcuno si riputerebbero di gusto
poco sicuro, e niente conforme alla maniera di scrivere osservata da buoni autori. A me,
che sono oltramontano e conseguentemente non abbastanza inoltrato nella cognizion della
lingua, fa di mestieri andar a rilento nel decidere siffatta questione. Però senza
ammettere cotali accuse, né rigettarle, mi contento di dire che sebbene a imparar, come
va, la lingua toscana, e a formarsi uno stile elegante e robusto fosse miglior pensiero
l’appigliarsi ad altri scrittori che non a ; non per ciò lascia d’essere pedanteria ridicola il vituperarlo
per non aver fatto uso dell’“quanco”, del “piùe”,
del “chente”, e di simili altre leziosaggini dell’antico parlar
fiorentino. In una nazione dove non si è convenuto finora quale sia la vera lingua degli
scrittori; dove la sanese contrasta il primato alla fiorentina e la romana vorrebbe
sottrarsi dal giogo di entrambe; dove la lombardia vanta anch’essa scrittori di sommo
grido proposti come modelli nel frasario generale della nazione; dove la diversità dei
popoli, dei governi e delle leggi, l’affluenza di persone e di libri stranieri, i gusti
ognor rinascenti e ognora cangiantisi rendono vario tuttora e indeterminato il gusto
comune di parlare e di scrivere; dove una porzione di letterati adoratori della
veneranda ruggine del Trecento e della battologia per lo più insipida del Cinquecento è
sempre alle busse coll’altra porzione di colte persone, le quali amando la moderna
foggia di esprimersi più disinvolta e meno impacciata, più spedita e men boccacevole, ne
deridono l’antica superstizione e s’appigliano al detto d’, che la fuga delle lingue è come quella delle stagioni, le quali
veggono sfrondarsi nell’autunno quegli alberi, che aveano osservato vestirsi di foglia
nella primavera, in questa nazione, io dico, non può così di leggieri condannarsi un
autore per ciò solo che non abbia scritto secondo la Crusca. Anche negli scrittori
approvati da questa si ritrovano non pochi modi di favellare che sarebbero scorretti
attendendo alle regole, ma che furono poscia autorizzati dal tempo e dalla fama degli
autori. Così la posterità, la quale riporrà certamente in un seggio di gloria vieppiù luminoso di quello dei , dei , dei
, dei , dei , dei , e dei , o
adotterà quelle formole mosse dall’autorità dell’inventore o gli perdonerà volentieri
qualche neo di stile e di lingua in grazia degli affetti che sentirà strapparsi dal
cuore. E prenderà maggior diletto gustando la mollezza, la vivacità e la chiarezza di
espressione che spiccano nei componimenti drammatici del , che nella insignificante purità del Dicta mundi di
, del Tesoro di
Ser , del Malmantile di Messer
, dei Capricci del
, o di tali altri libri canonici per quella
classe di persone, le quali povere d’ingegno e sterili di fantasia credono esaurita dal
Vocabolario di un’Accademia tutta la fecondità dell’umano spirito, e
per cui non istà che le lingue e il sapere degli uomini non rimangono perpetuamente in
una barbara infanzia. Quantunque la lettura di quelli autori contribuisca in oggi tanto
agli avanzamenti del gusto quanto giovano alla vera cognizione dell’Antichità le
ricerche sulla struttura delle bracche che portava , o le fatiche di quel buon monaco bolognese che scrisse una lunga
dissertazione investigando qual fosse la costa che Iddio staccò dal fianco di Adamo per
fabbricar il corpo della madre Eva. Ad onta però degli stitici e freddi grammatici, ad
onta di quei pedanti accigliati che vorrebbero arrestar il volo del tempo e imprigionar
la ragione fra lacciuoli tessuti di tela di ragno, i progressi della filosofia, che
annunziano una vicina rivoluzione nelle idee della nazione, promettono anche un
cangiamento nell’indole dell’idioma. «Resta a fissarsi», dice
un ameno ed elegante scrittore, «la lingua viva ed a farsi universale ad uso
di tutti, come incomincia da qualche tempo. Il genio a ciò far destinato sembra esser
.»
102 Oltracchè le regole dello stile proprio
del dramma musicale non debbono misurarsi per quelle degli altri componimenti, esigendo
la natura del recitativo e del canto un tornio di espressione, una certa combinazione di
vocali e di consonanti, una cadenza di periodo particolare quale non si richiede dalle
altre poesie fatte per esser lette, o semplicemente recitate. Io credo di averlo
dimostrato abbastanza in altri luoghi di quest’opera per non abbisognar qui di nuove
parole.
[39] Altri finalmente decideranno se il abbia sempre cavato dal proprio fondaco o dall’altrui i suoi pregiatissimi drammi; se l’imitazione de’ Greci, Inglesi, Francesi e Italiani sia abbastanza nascosa, o troppo visibilmente marcata; s’abbia tolta l’arte d’intrecciar gli accidenti da , autore ch’aveva tra i suoi libri e che a ragione veniva da lui stimato moltissimo a confusione di tanti saccenti, i quali intieramente lo dispregiano senz’averlo neppur veduto. Se si vegga espressa Donna Ines de Castro della nel Demofoonte, l’Atalia di nel Gioas, il Cinna di nella Clemenza di Tito, il Temistocle di nel suo, e così via discorrendo. Checché sia di ciò, una tale riprensione non può darsi a senza stenderla ancora ad altri ingegni grandissimi. Gli obbietti dell’universo hanno dapertutto certe relazioni comuni, le passioni hanno parlato in tutti i secoli lo stesso linguaggio, la bellezza di quelli e l’energia di queste è stata espressa da alcuni scrittori in guisa tale, che non possono ritoccarsi senza guastarle. Qual meraviglia è dunque se chi dopo loro si scontra nel medesimo obbietto, o nella medesima situazione, non potendole migliorare le ricopia, o le riveste alla sua foggia? , , , e fecero senza biasimo alcuno anzi con molta laude lo stesso. Non può negarsi che non abbia in alcuni luoghi portata l’imitazione fino ad involar le parole stesse non che i sentimenti, ma generalmente parlando, egli ha l’arte di adattare i pensieri che imita dall’altrui genere al proprio, la qual cosa basta per dare agli oggetti imitati quell’aria di novità, che gli rende pregievoli. I miei lettori amerebbero forse che se ne facesse in questo luogo il confronto di alcun componimento d’un altro autore preso ad imitare da . Ma questo, oltracchè l’esame riuscirebbe troppo prolisso, è stato di già felicemente eseguito da parecchi scrittori, e s’esseguisce al presente da una radunanza di letterati impiegati nel far dei commenti a ciascuno dei drammi di questo poeta, e che verranno dati alla luce dalla Società tipografica di Nizza.
[40] Molto più mi rincrescerebbe il non poterlo scolpare da altri difetti, i quali imitati incautamente dai giovani potrebbero condurli alla rovina del buon gusto. Incominciamo dal più frequente e più ovvio, che è quello di aver ammollito, anzi effemminato il dramma in musica introducendovi l’amore, e introducendolo in maniera poco conveniente allo scopo del teatro. Non v’è un solo fra suoi drammi, (s’eccettuati non vengano gli oratori e qualche altro breve componimento) dove questa passione non abbia luogo. Il Catone, il Temistocle, il Regolo, dove certamente non doveva aspettarsi, non ne vanno esenti. né si contenta di frammettere uno o due intrighi amorosi, in molti vi sono anche tre e quattro. Ci è qualcheduno, come la Semiramide, dove tutti quanti i personaggi sono innamorati. E pazienza se quest’amore fosse sempre la passione primaria, sulla quale poggiasse tutto il nodo della favola, e da cui ne dipendesse lo scioglimento, se fosse una passione abbastanza forte, seria, e terribile per rendersi teatrale. Ma più volte l’autore non ha avuto in vista né l’uno né l’altro. L’amore in molti suoi drammi altro non è che un affetto puramente episodico e subalterno, un riempitivo, un cerimoniale di scena. Dal che avviene non di rado che non solamente illanguidisca l’affetto, ma che rattenghi eziandio la foga e rapidità dell’azione principale.
[41] La pittura di questa passione sul teatro non ha mezzo. Essa è come il governo dei tiranni, i quali o regnano dispoticamente fra la strage e il sangue, o perdono il trono e la vita. O l’amore trionfa solo fra i tumulti e le peripezie, o tenendo il secondo luogo diventa una occupazione frivola e insipida103. La passione per esempio di Fedra nella tragedia di è interessantissima, perché forma il tutto della favola, ed è la cagion primaria della disgrazia di tutti; quella d’Ippolito e di Aricia è fredda, e quasi senza effetto perché subalterna. Mi fa tremare l’amore di Mitridate scortato dai furori, mi raffreddano le scene di pura galanteria tra Monima e Siffare. Così nel io applaudisco alle amorose smanie d’Ipermnestra, piango nella tenera, viva e veramente tragica passione di Timante e Dircea, tremo per l’amante e virtuosa Zenobia perseguitata dai sospetti dell’impetuoso e feroce Radamisto. Ma qual interesse ho a prendere per gli affettati sospiri di Amenofi, di Barsene, di Cleofile, di Selene, di Megabise, di Tamiri e di tanti e tante che s’amano puramente per formalità e per usanza teatrale, non altrimenti che Don Chisciotte amava Dulcinea da lui non mai veduta né conosciuta, soltanto per non contravenir alle leggi della errante cavalleria, le quali volevano che ogni cavaliere avesse la sua bella? Quali affetti mi desteranno i languori di Barce accanto al sublime carattere di Regolo? Le debolezze di Serse rimpetto alla generosità incomparabile di Temistocle? Le fredde gelosie di Arbace in faccia all’indomito repubblicano Catone? Gli stessi, che risveglierebbono in un selvaggio del Canadà i lamenti di quel Sibarita, il quale non avea potuto in tutta la notte riposare pel disagio recatogli da una foglia di rosa, che gli si era sotto il fianco ripiegata.
[42] Cotali riflessioni si rinforzano maggiormente ripensando alla influenza che ha avuta l’accennato diffetto sui componimenti del . Essa è la cagion principale di quella effemminatezza, di quelle tinte alterate perché rammorbidite all’eccesso, onde vengono sformati i caratteri di molti suoi personaggi. Basta una semplice occhiata per ravvisar in loro non già un assirio, un tartaro, un africano, un chinese che parlino, ma bensì il poeta, il quale presta loro spesse fiate i propri sentimenti e il pensare attuale del proprio secolo. Non si sà, per addurne un qualche esempio, capire come Amilcare ambasciatore di Cartago in mezzo alle cure di una importantissima commissione fra le due repubbliche, abbia l’agio di sospirare tranquillamente per una schiava sugli occhi degli emoli ed austeri Romani; come Fulvio inviato da Roma per decider sul destino del mondo fra Cesare e Catone possa, senz’abbassar il proprio carattere, amoreggiar sul teatro la vedova del gran Pompeo; come Cesare, che tutt’altra cosa dovea rivolgere allor nel pensiero fuorché il badare ad una galanteria inutile, pur s’intertenga anch’egli a far il cascante, esprimendosi colla bella non altrimenti che far potesse un Celadone od un Aminta.
«Chi un dolce amor condannaVegga la mia nemica,L’ascolti, e poi mi dicaS’è debolezza Amor.Quando da sì bel fonteDerivano gli affettiVi son gli eroi soggetti,Amano i numi ancor.»
[43] Se tali fossero stati i sentimenti di Cesare in così critiche circostanze, il sangue del gran Catone non si sarebbe versato sulla tomba della romana libertà, né gli avanzi della più sublime virtù, che abbiano ammirata giammai il patriotismo e la filosofia, sariano divenuti il pomposo trofeo di un usurpatore fortunato.
[44] Nè può piacere al buon senso che uomini nati fra gli scogli
della Mauritania, o sulla riva del Gange,
che Alessandro, Ciro, Semiramide, ed altri celebri
conquistatori dell’Antichità, presso a’ quali l’amore fu piuttosto un bisogno materiale
dei sensi che un raffinamento della immaginazione, si siano all’improvviso cangiati in
altrettanti belli spiriti de’ nostri tempi «struggendosi al fulgore de’ bei rai,
facendosi del core un nido»
, morendo di languore «accanto alle vezzose
stelle, al mio bel nume, all’Idolo adorato»
con mille siffatte lambiccate
espressioni che sogliono udirsi frequentemente in bocca ad uno scialante Zerbino
allorché siede mezzo sdraiato sul sofà vicino a qualche ammorbidita fanciulla. Chi può
soffrire che un feroce principe dei Parti venga fuori con questa scapata amorosa, che
starebbe assai meglio negli stemperati endecasillabi del , ovvero del ?
«Già presso al termineDe’ suoi martiriFugge quest’animaSciolta in sospiriSul volto amabileDel caro ben.Fra lor s’annodanoSul labbro i detti;E il cor, cbe palpitaFra mille affettiPar che non tolleriDi starmi in sen.»
[45] Chi non istupirà nel sentire quel Romolo violente rozzo e feroce, che riponeva ogni sua ragion nella forza, che si sdegnava al menomo ostacolo, e che pell’ardenza del suo temperamento si rendeva insopportabile a tutti, parlare da sé solo intorno all’amore che ha per Ersilia nello stile del più alambiccato platonicismo?
«Romolo! E come maiFra le minacce ostili, in mezzo a tanteCure del nuovo impero ha nel tuo pettoPur trovato ricettoL’amor così? Tal debolezza! Ah sempreDebolezza non è. Cangia naturaAllor che amor con la ragion congiura.Quel che ad Ersilia in fronteIo veggo scintillar de’ miei pensieriAstro regolator, cosa mortaleCerto non è.»
[46] E chi non riderebbe ascoltando quel Polifemo, che gli antichi chiamarono «mostro
smisurato, orrendo e deforme»
, quel Ciclope di cui ci dà una idea
così spaventevole e disgustosa, quel gigantaccio, la cui sola immagine farebbe tremar i
fanciulli più di quella dell’orco e della Beffana, apostrofar
oratoriamente al suo cuore in un’arietta, sviluppando i punti più fini della passione,
come potrebbe farlo un od un ?
«Mio cor, tu prendi a schernoE folgori, e procelle,E poi due luci belleTi fanno palpitar.Qual nuovo mota internoPrendi da quei sembianti?Quai non usati incantiT’insegnano a tremar?»
[47] Non incorse in questo difetto l’inimitabil , il quale, introducendo lo stesso personaggio a spiegar il suo amore verso Galatea, il fa parlare in guisa ben diversa:
«O bianca Galatea, bianca all’aspettoPiù che giuncata, e più che agnello tenera.Più d’un vitello superbetta, e acerbaPiù dell’uva immatura. Tu soventeTen vieni a me qualor m’occupa il sonno,E poi da me col sonno via ten parti.Nè altramente da me ritrosa fuggiChe pecorella dechine dal lupo,Cui l’età vecchia i bigi peli imbianchi.Io fanciullo di te m’innamoraiQuando la prima volta in compagniaDella mia madre ten venisti al monteA cogliere le foglia di giacinto,E del sentier io n’era scorta e guida.Allor ti vidi, allor divenni amante.E da quel giorno in poi fino al presenteNon trovai pace, o tregua al mio martoro.E tu crudele l’amor mio non curi? ec.»
[48] Qual semplicità pastorale, qual verità di carattere nei sentimenti del greco poeta! Che raffinamento in quelli dell’italiano! Il primo ti fa vedere il ciclope selvaggio di , il Polifemo originale, come lo troviamo nella storia. Il secondo ti rappresenta un Polifemo del secolo dieciottesimo, un gigante ricciutello che ha imparato dal romanzo dell’Astrea o della Clelia l’arte di comporre soliloqui amorosi. Mi si dirà che il protagonista di sarebbe meno a proposito per la musica di quello di . Lo concedo. Ma qual bisogno ci era di snaturar Polifemo per renderlo soprano del teatro di San Carlo, o di quello di Argentina?
[49] Come una conseguenza di ciò che abbiamo indicato ne deriva un altro diffetto, dal quale il nostro poeta non ha potuto liberarsi abbastanza. Questo è il sostituire ch’egli fa, tante volte, lo stile della immaginazione a quello dell’affetto, e il preferir al linguaggio della natura gli sfoggiati ornamenti dello spirito. Nulla di più comune ne’ suoi componimenti quando il sentir i personaggi, allorché danno un consiglio o sono agitati da qualche passione, trattenersi tranquillamente a paragonar se medesimi alla nave, al fiore, al ruscello, alla tortora, allungandone la comparazione per sei e otto, alle volte per dieci e dodici versi. Chi ha la serenità d’animo che basta per descriverci così alla minuta gli oggetti esterni, muove un forte sospetto d’ipocrisia nel suo dolore. E più frequenti del bisogno sono quei casi dove gl’interlocutori si sentono far uso di quelle antitesi e ritornelli di parole proprie dei madrigali del Seicento, e così poco care ai sensati maestri. Per esempio Elisa nel Re Pastore:
«Dal dì primieroChe ancor bambina io ti mirai, mi parveAmabile, gentileQuel pastor, quella greggia, e quell’ovile,E mi restò nel cuoreQuell’ovil, quella greggia, e quel pastore»
ovvero in quell’inno che Alceste e Cleonice nel Demetrio intuonano ad Appolline, allorché riconosciuto quello esser il vero erede del regno della Siria, si danno scambievolmente la mano di sposi:
«A duo. Deh! risplendi, o chiaro numeFausto sempre al nostro amor.Alceste. Qual son io tu fosti amanteDi Tessaglia in riva al fiume,E in sembianza di Pastor.Cleon. Qual son io tu sei costante,E conservi il bel costumeD’esser fido a i lauri ancor.»
[50] È egli mai questa (che dio ci aiuti! ) l’occasione di trovar una serie di rapporti così delicati tra Alceste ed Appolline? Non è una riflessione puerile di Cleonice quella di paragonarsi al nume perché serba fedeltà ad un lauro? Vorrebbe forse il poeta darci ad intendere che se per istrana metamorfosi Alceste fosse cangiato in eliotropio od in mirto, dovesse Cleonice esser fedele ad una pianta? Cotal fantasia scusabile al più in un epigramma o in un poema simile a quello delle trasformazioni d’ è assolutamente indegna della gravità, che esige un componimento drammatico. Peggio poi quando all’affettazione s’unisce la falsità del pensiero. Così nel Catone allorché Fulvio spiega intempestivamente ad Emilia la passione che ha per lei, e ch’essa gli risponde:
«Qual mal può dartiSperanza un’infeliceCinta di bruno ammantoColl’odio in petto, e sulle ciglie il pianto?»
[51] Fulvio, prevalendosi delle ultime parole, s’appiglia per redarguirla ad un contrapposto il più ricercato e meno a proposito che in simili circostanze poteva attendersi.
«Piangendo ancoraRinascer suoleLa bella Aurora,Nunzia del Sole;E pur conduceSereno il dì.»
[52] Nel che ognuno scorge subito la falsità del sentimento,
poiché il pianto di cui parla Emilia è vero e
reale, e quello dell’Aurora non è che
metaforico. La risposta non per tanto di Fulvio è
un bisticcio somigliante a quello che un drammatico francese mette in bocca ad un suo
personaggio: «Il mio sangue esce dalla ferita fumante di collera, perché fu
sparso per altri che per la Dama»
, o come quello di , che, volendo persuader alle donne non dover elleno render venali
le grazie loro, adduce tra altre ragioni che nulla giova il rigalar con danari Cupido, poiché andando egli sempre ignudo, non ha
bisaccia dove custodirli104.
[53] Dalla medesima cagione provengono quelle tante scene inutili, e di puro riempitivo, inserite a forza fra le altre solo per non perder l’usanza di metter da per tutto l’amore. Le quali lontane dallo spinger, come dovrebbero, l’azione verso l’oggetto principale, e di prepararne lo scioglimento, altro non fanno che romper l’unità, diviar le fila che tendevano al centro, e nuocer alla energia delle situazioni più vive. Quindi i tanti personaggi posticci che solo servono a spandere il languore, e che manifestamente si veggono introdotti dal poeta per sovvenir ai bisogni della favola e alla sterilità dell’invenzione. Quindi le frequenti inverosimiglianze, alle quali dà luogo l’adottato sistema, come sarebbe a dire che i buoni genitori vadino via dalla presenza delle figlie per non distornarle dal carezzar i loro amanti; che i prigionieri destinati ai ceppi, o alla morte restino soli lungo tempo in sulla scena per dir delle tenerezze alla bella; che i personaggi invece di badar agli avvenimenti che hanno sotto gli occhi, s’intertengano insieme a far delle lunghe dicerie sulla galanteria, sulla possanza del sesso, sulla miseria degli amanti, o su altri oggetti estranei del tutto a ciò che si rappresenta. Del che fra i molti esempi che potrebbero addursi, basti per breve saggio la scena prima dell’atto secondo dell’Adriano in Siria. L’uditore, che sa lo scambievole amore tra Farnaspe ed Emirena promessi sposi sotto gli auspizi del padre che sa gli ostacoli che frappone alla loro unione il conquistatore Adriano; che ha veduta la disgrazia di Farnaspe caduto in mano dei Romani e incatenato da loro per esser creduto l’autore di un incendio eccitato da Osroa nel palazzo imperiale a fine di bruciarvi dentro l’imperatore, che si è trovato presente al tenerissimo rincontro degli amanti in così lagrimevole occasione, e che legge nell’anima di Emirena lo smanioso dolore onde vien giustamente lacerata; non s’aspetterà, cred’io, di doverne ascoltare in mezzo ai sentimenti tragici che ispira una situazione cotanto feconda, delle lunghe dispute sull’accortezza, delle donne paragonata con quella dei cortigiani. Eppure tal ne è l’argomento che serve di materia a’ discorsi di Emirena e di Aquilio. Esorta quel romano la bella prigioniera, a prevalersi dell’amore del monarca a pro di Farnaspe. Ella animata da quella nobile fierezza che siede così bene alla virtù combattuta, risponde:
«Em. A me non giovaPerché non l’amo.Aquil. È necessario amarloPerch’ei lo creda?Em. E ho da mentir?Aquil. Neppure.È la menzogna ormaiGrossolano artifizio, e mal sicuro.La destrezza più scaltra è oprar di modo,Ch’altri se stesso inganni: un tuo sospiroInterrotto con arte: un tronco accentoChe abbia sensi diversi: un dolce sguardo,Che sembri a tuo mal gradoNel suo furto sorpresso: un moto, un riso,Un silenzio, un rossor, quel che non diciFarà capir. Son facili gli amantiA lusingarsi. Ei giurerà, che l’ami:E tu quando vorraiSempre gli potrai dir: nol dissi mai.Em. Non so dove s’apprendaTal arte a porre in uso.Aquil. Eh che pur troppoVoi nascete maestre. Aver sul ciglioLagrime ubbidienti: aver sul labbroUn riso che non passiA’ confini del sen: quando vi piaceImpallidirvi, ed arrossir nel viso,Invidiabili sonoPrivilegi del sesso: in dono a voiGli ha dati il Cielo, e costan tanto a noi.Em. Tu che in corte invecchiastiNon dovresti invidiarne. Io giurerei,Che fra pochi non sei tenaci ancoraDell’antica onestà. Quando bisognaSaprai sereno in voltoVezzeggiar un nemico: acciò vi cadaAprirgli innanzi il precipizio, e poiPiangerne la caduta. Offrirti a tuttiE non esser che tuo: Di false lodiVestir le accuse ed aggravar le colpeNel farne la difesa: ognor dal tronoI buoni allontanar: d’ogni castigoLasciar l’odio allo scettro, e d’ogni donoIl merito usurpar: tener nascostoSotto un zelo apparente un empio fine:Nè fabricar che sull’altrui rovine.Aquil. Far volesti EmirenaLe vendette del sesso. Io non credeiDi pungerti così. De’ detti tuoiNon mi querelo; anzi a parlar sincero,Credo ch’io dissi, e tu dicesti il vero. ec.»
[54] Io non vorrei esser tacciato di soverchia stitichezza nei giudicare, ma tradirei i propri sentimenti se non dicessi che tutta questa scena mi sembra una diceria bella bensì, ma fuori di luogo. Invece di Emirena e di Aquilio io quivi non ravviso che 105.
[55] In questo luogo sento all’improvviso interrompermi da un qualche lettore sdegnoso che vuol perorare a favore del . Se non m’inganno nelle mie conghietture le sue ragioni si ridurranno a un dipresso ai capi seguenti, cioè che l’illustre autore è stato costretto di servire alle circostanze; che aspirando ad una rapida e sicura celebrità in una nazione voluttuosa e sensibile, ha dovuto secondar la passione dominante del secolo, e prendersi maggior pensiero di piacere alle vaghe donne e ai giovani innamorati che non agli stitici letterati e ai filosofi incontentabili106; che scrivendo i suoi drammi acciocché fossero rappresentati, non ha potuto dispensarsi dal badare agli usi del teatro, al genio della musica odierna, ed al capriccio dei maestri di cappella, degl’impresari, dei macchinisti, dei cantori, e dei ballerini; e che per conseguenza a tali cagioni anziché all’autore debbano attribuirsi gli accennati difetti. Un più severo di me risponderebbe forse che con siffatta logica potrebbono farsi passare per eccellenti le commedie del , e le tragedie del non che i componimenti di , essendo certo che quei poeti altro non ebbero in vista che di riscuoter gli effimeri applausi di un volgo stolido di spettatori; che l’accomodarsi al gusto pervertito degli ignoranti non tornò mai in vantaggio di nessuno scrittore; che la superiorità di un uomo di talento si conosce appunto dal sollevarsi ch’ei fa sopra gli errori e i pregiudizi dell’arte sua; che l’irrevocabil giudizio della posterità non ha dato finora il titolo di genio se non se a quelli autori sublimi, i quali sprigionandosi dai ceppi delle opinioni e dei gusti volgari hanno imposto la legge alla loro nazione e al loro secolo invece di riceverla; che infinitamente più laude ne avrebbe acquistata il , se lottando contro alle difficoltà che opponevano una imperiosa truppa d’ignoranti e l’invecchiata usanza di quasi due secoli, osato avesse d’intraprender una totale riforma nel sistema drammatico, invece di autorizzar maggiormente i vizi attuali coll’abbellirli; e che niuno poteva eseguir il proggetto meglio di lui non meno per l’ingegno mirabile concessogli dalla natura che pel favore dichiarato della nazione, per la protezione d’una corte imperiale, e pel gran numero di musici eccellenti che avrebbero dal canto loro contribuito a rovesciar l’antico edifizio per inalzarne un novello. Ma senza insistere su ciò che potrebbe rispondersi, io m’appiglio volentieri alle ragioni, che scolpano . Compatisco quel grand’uomo obbligato ad esercitarsi in un genere difettoso per natura, o per l’altrui imbecillità, e me ne sdegno soltanto colle circostanze che lo costrinsero.
[56] Sarà dunque colpa delle circostanze l’alterar ch’egli ha
fatto tante volte il costume, mettendo in bocca a’ suoi personaggi delle allusioni, le
quali, atteso il paese ed il tempo, non potevan loro in veruna guisa convenire. Tali
sono, per esempio, l’uso della mitologia propria de’ soli Greci appresso agli antichi
asiatici, come sarebbe a dire le parole «furie d’Averno»
in bocca d’una
principessa di Cambaia, che rimprovera un re della
Media, «il remo del pallido nocchiero, La sponda del
torbido Lete, La nera face in flegetonte accesa»
in
bocca d’un antichissimo re della Persia che parla a’ suoi
confidenti; Imeneo, che scuote la face invocato
da un coro di babilonesi a’ tempi della celebre Semiramide, quando nato non era per anco il sistema favoloso dei Greci ed
eran nomi sconosciuti Imeneo e la sua fiaccola;
il far che Astiage padre del famoso Ciro sagrifichi un tempio di Diana, ovverossia della Dea triforme, tuttoché questa
falsa divinità, come l’adoravano i Greci, conosciuta non fosse dai Medi se non molti
secoli dopo, cioè dopo la conquista dei Seleucidi107, l’introdurre una donzella nata nella reggia di
Susa a’ tempi d’Artaserse, che fa menzione della Ifigenia in Tauride
tragedia composta molto dopo in Atene da .
«E vuoi ch’io miriQuesta vera tragediaSpettatrice dolente, e senza pena,Come i casi d’Oreste in finta scena?»
[57] L’uso del vetro consigliere, ovvero sia dello specchio di cristallo posto in bocca d’un eroe dei tempi favolosi, cioè d’Ercole al Bivio quando si sa che codesto raffinamento della donnesca vanità non fu ritrovato se non molti secoli dopo il metter sulla scena tre ritiratissime fanciulle cinesi, delle quali l’una forma il piano della tragedia di Andromaca, l’altra recita un’egloga sotto il nome di Licori, e la terza contraffà il personaggio di un viaggiatore che ritorna al proprio paese avendo sempre in bocca la toilette, la charmante beauté con più altre caricature francesi. Tutto ciò non so quanto sembrerebbe conforme ai costumi nazionali in Pecchino; quanto a me credo, che chiunque abbia fior di senno riporrà queste esimili licenze accanto al quadro di quel pittore, il quale dipignendo Gesù Cristo che predicava al popolo, lo fece accompagnar da paggi vestiti alla spagnuola, o insiem con quei versi del portoghese , dove Venere e Bacco vengono in soccorso di un re del Capo di Comorino travagliato dalle armi di Vasco di Gama.
[58] Sarà parimenti colpa del genere, il quale permette forse molte cose che la verosimiglianza non permetterebbe, l’incertezza e la contraddizion che si scorge nel carattere di molti suoi personaggi nata unicamente dal desiderio di ripetere le situazioni medesime, e di mettere in mille guise a cimento una frivola passione. Il Catone in Utica è fra l’altre una pruova luminosa, nonostante la tenerezza con cui il suo autore riguardò mai sempre quel componimento. Appena vi si ritrova un solo personaggio che conservi il carattere che gli vien dato dalla storia, o che sarebbe proprio della sua situazione. Ho già fatto vedere quanto sconvenga all’impiego e dignità di Fulvio legato di Roma il perdersi in vani amoreggiamenti con Emilia, ma non è sconvenenza minore nel suo carattere quella del piccolo ripiego con cui non solo dissimula, ma positivamente finge con essa lei affine di scoprire i suoi disegni intorno a Cesare; finzione poco verosimile in un amante sugli occhi dell’amata, e poco dicevole all’integrità d’un romano. La vedova di Pompeo, che ci viene dagli storici descritta come modello d’eroismo e di grandezza, vi comparisce non solo finta e dissimulata, non solo indagatrice indiscreta degli amorosi sentimenti di Marzia, e usando altresì l’inconseguenza di palesare i suoi disegni a Fulvio, cui ella non amava punto, e della cui fede avea mostrato nella scena settima dell’atto secondo d’aver fondato motivo di sospettare, ma (ciò ch’è peggio) tramando a guisa di vile femminuccia insidiosi agguati contro alla vita di Cesare. Marzia figliuola di Catone, la quale si dipinge sul principio cotanto virtuosa che non vuol nemmeno riconoscere come suo amante Cesare divenuto nemico della patria e del genitore, si dimentica dopo della sua virtù a segno di rifiutare apertamente in faccia a suo padre lo sposo datole da lei, e di vantarsi dell’amore che porta all’odiatissimo suo rivale, in circostanze che rotta ogni speranza d’amichevol pacificamento, Cesare non poteva meno di non essere riguardato da lei come oppressore della libertà e nemico di Catone. Catone stesso, quel seguace così rigido del giusto che la parola di lui aveva presso ai Romani la forza medesima che il giuramento fatto in presenza dei numi, niega a Cesare sotto un pretesto leggierissimo l’udienza che gli aveva dianzi promessa, né si sdegna di mischiare fra le cure pubbliche e in giornata così decisiva il privato affare delle nozze di Marzia sua figlia; egli che scevro d’ogni domestico affetto non era padre, né fratello, né marito, ma cittadino.
[59] Saranno altrettanti requisiti del melodramma che le principesse si travestano sì spesso in pastorelle, e menin la vita loro fra le selve senza contrasto alcuno e senza sospetto; che tanti personaggi vivano sconosciuti, come pare e finché pare al poeta; che tutti si scoprano appunto nelle stesse circostanze, e quasi per gli stessi mezzi; che gl’intrecci siano ovunque e dappertutto i medesimi, cioè una dichiarazio ne d’amore, una gelosia, una riconciliazione ed uno sposalizio, talmentechè chi legge quattro o cinque drammi di può quasi dire di averli scorsi tutti quanti che gli scioglimenti riescano non solo troppo uniformi, ma spesse fiate sforzati o troncati, come già il nodo gordiano colla spada di Alessandro. Il Signor de’ , che nella dissertazione altrove citata ha voluto dileguar quest’accusa, ha destramente sfuggita la difficoltà cambiando l’aspetto della quistione. Il difetto di non è, com’egli suppone, di finir sempre in un paio di sposalizi (la qual cosa, benché più confaccente al genere comico che al tragico, potrebbe nondimeno perdonarsi alla cattiva invecchiata usanza del teatro) ma di condursi a quel fine per mezzi sempre omogenei e consimili, i quali oltre l’annoiar i lettori colla troppa uniformità, fanno vedere la scarsezza d’inventare nel poeta. La ricognizione, quel gran fonte della maraviglia e del diletto teatrale, si fa nascer da lui per vie poco naturali, anzi romanzesche, come sarebbe a dire per mezzo di un gioiello, d’un biglietto o tal altra cosa custodita da un sacerdote, il quale, dopo aver tacciuto l’arcano vent’anni, lo svela appunto nell’atto terzo del dramma. Un foglio è la cagione dello scoprimento nel Demetrio, nella Semiramide, e nella Nitteti; due fogli vi vogliono nel Demofoonte; il gioiello di Argene scuopre Licida nell’Olimpiade; una nota vermiglia impressa nel braccio, e veduta soltanto nell’ultima scena manifesta Egle nella Zenobia, e così via discorrendo. Ove la ricognizione non ha luogo, voi siete sicuro, che lo scioglimento si prepara o perché il personaggio, trovandosi alle strette, si vuol uccidere di propria mano, onde chi sta presente, e non ha il coraggio di vedere sgorgar il sangue, si placa subitamente per levarsi d’impaccio, o perché in un tradimento ordito da un fellone, oppure in un popolare tumulto eccitatosi nella guisa che vuole il poeta il creduto reo si mette dalla banda del padre, o del sovrano che il condannava, col qual atto eroico disingannato alla perfine il barbaro re gli concede il desiderato perdono, o perché l’amata e il vago stanchi delle opposizioni e bramosi di sbrigarsi pur una volta dalla faccenda si cedono scambievolmente al fortunato rivale. Ben di rado avviene che ne faccia uso di altri mezzi. Se questi più volte sono posticci; se condotti non vengono spontaneamente dallo sviluppo naturale dell’azione, ma tratti piuttosto a viva forza dalla usanza; essi almeno sono, come i cavalli di vettura, che si pigliano a nolo dal poeta per trasportar i personaggi fino all’ultima scena.
[60] Finalmente al genere non meno che alle circostanze attribuir si dovrà quella imperizia di sceneggiare, la quale tanto nuoce alla illusione a motivo di non trovarsi giammai la ragion sufficiente di ciò che si vede. Da essa proviene che i personaggi vadino, venghino, si fuggano e s’incontrino in sulla scena non già come richiederebbero le circostanze e la situazione, ma come torna più in acconcio al poeta. Da essa deriva che gli attori parlino ad alta voce, se la intendano e siano intesi dagli uditori senza che il terzo, che è presente, se ne accorga pure d’un solo accento. Da essa nasce che favellino alternativamente con troppo studio imitando l’uno i sentimenti dell’altro, come fanno i pastori nell’egloghe amebee di . E ciò per delle scene intiere, e senza vedersi. Del che basterà addurne in pruova un esempio, giacché a provare distintamente tutte le cose accennate vi vorrebbe un intiero volume. Questo si trova nell’atto III. scena I. dell’Olimpiade. La scena rappresenta una bipartita che si forma dalle ruine di un antico ippodromo, già ricoperte in gran parte di edera, di spini, e d’altre piante selvagge. Megacle trattenuto da Aminta per una parte: e dopo Aristea trattenuta da Argene per l’altra. Ma quelli non veggono queste. Abbiamo sul principio una combinazione di circostanze che può sembrare non poco ricercata. Due persone, ambedue amanti, ambedue che vanno disperate a morire nello stesso luogo, allo stesso tempo, per la medesima via, ambedue trattenute dal rispettivo amico. E notisi di passaggio che l’una di esse è la figlia del re, unica erede del regno, e ricercata quel medesimo giorno in isposa da tutti i principi della Grecia, la quale esce inosservata alla campagna avendo per tutto corteggio la compagnia d’una sua confidentissima pastorella.
«Megacle. Lasciami. Invan t’opponi.Aminta. Ah, torna, amicoUna volta in te stesso. In tuo soccorsoPronta sempre la manoDel pescator, ch’or ti salvò dall’onde,Credimi, non avrai. Si stanca il cieloD’assister chi l’insulta.Megac. Empio soccorso!Innumana pietà! Niegar la morteA chi vive morendo. Aminta, oh Dio!LasciamiAm. Non sia ver.Arist. Lasciami Argene,Arg. Non lo sperar.Megac. Senz’Aristea non possoNon deggio viver più.Arist. Morir vogl’ioDove Megacle è morto.»
[61] Non vi par egli, ch’incominci l’
«Alternis dicetis, amant alterna Camaenae»?
[62] Seguitiamo pure, che non finisce così tosto.
«Am. Attendi.Arg. Ascolta.Megac. Che attender?Arist. Che ascoltar?Megac. Non si ritrovaPiù conforto per me.Arist. Per me nel mondoNon v’è più che sperar.Megac. Serbarmi in vita…Arist. Impedirmi la morte,…Megac. Indarno tu pretendi.Arist. Invan presumi.Am. Ferma. (Trattenendo Megacle che fugge. Per conseguenza Aristea dee fuggir parimente, ed esser trattenuta.)Arg. Senti infelice.Arist. O stelle!Megac. O numi! (Incontrandosi a mezzo il teatro)Aris. Megacle!Megac. Principessa!Arist. Ingrato! E tantoM’odi dunque, e mi fuggi,Che per esserti unitaS’io m’affretto a morir, tu torni in vita?Megac. Vedi a qual segno è giunta,Adorata Aristea, la mia sventura.Io non posso morir. Trovo impediteTutte le vie per cui si passa a Dite.»
[63] Potrebbono rispondersi più aggiustatamente se ciascuno avesse la parte in iscritto?
[64] Nè mi si dica che l’uditore senza tener dietro a coteste maninconie d’ordine, di costume e di scena si dà per soddisfatto ogni qual volta intenerir si sente da quell’aria o da quel recitativo, né ch’egli permetta al poeta di mancare all’ultima esattezza in grazia delle bellezze parziali, dalle quali dipende per lo più l’effetto della poesia e della musica. né mi si arrecchi l’esempio d’altri autori antichi o moderni, i quali splendono assisi tuttora nel seggio della immortalità, avvegnaché poco scrupolosi mostrati si siano nella osservanza di tai precetti. Siffatti ragionamenti, ammessi che fossero una volta, farebbero crollare quel buon senso e quella illuminata ragione che dee pur tutti guidare i lavori dell’ingegno. E qual diletto può gustare uno spettatore in uno spettacolo ove manchi l’interesse e l’illusione? E come mantener questa qualora il poeta non ha l’arte di farlo assister come presente al soggetto di combinar colla scena l’azione e di metter d’accordo fra loto tutte le cose rappresentate? Come ottener l’interesse dove manca la persuasione dove l’occhio è in perpetua contraddizione col sentimento, dove la passione, che ne sarebbe l’effetto, manca di ragion sufficiente che la produca? Se, come dice , in un verso che vale un tesoro,
«Rien n’est Beau que le Vrai, le Vrai seul est aimable»
qual permanenza di gloria attendono quelle composizioni dove il vero non ha luogo, e dove le circostanze, distruggendosi vicendevolmente, palesano ad evidenza la falsità? Un’aria tenera, un recitativo patetico può dilettare per un momento bensì, ma la mancanza d’accordo fra le parti, l’inverosimiglianza che traspira nel tutto farà ben tosto rattiepidire quel calore effimero che non trova materia onde alimentarsi. né l’esempio altrui conchiude altro in favore di se non che ei non è il solo compreso in siffatta accusa, e che invece di sciogliersi la quistione in suo favore, s’impiantano altrettante di nuovo quanti sono gli scrittori che s’addurranno in difesa108.
[65] Ma tanto forse mi sono inoltrato nella critica del
che il lettore si sarà immaginato aver
io preso principalmente di mira quel poeta per censurarlo. Deponga egli (io glielo
prego) se venuto in mente gli fosse cotal sospetto. Protesto ampiamente che la mia
venerazione per l’illustre autore è grandissima, e che niuno il loda più sinceramente di
me, né più volontieri adotta la scuse per quelle mancanze quas
humana parum cavit natura
assai picciole in paragone dell’altre sue
rarissime doti. Ma prima era d’uopo sostener intrepidamente l’impegno addossatomi di non
abbandonare la verità per niun umano rispetto. Inoltre bisognava premunire i giovani,
(se pur di tanto fossero i miei giudizi che meritassero essere ascoltati da essi)
affinchè sappiano prendere il moltissimo di buono e di eccellente che si trova in
senz’imitare altre cose perdonabili in
lui ma che in loro viziosissime diverrebbono. Soprattutto che non lo prendano per
modello di scriver tragedie, siccome alcuni scrittori con appassionato zelo vorrebbono
tuttora persuadere all’Italia. La sublime tristezza della tragedia ha tanto che fare col carattere del dramma in musica
quanto avrebbe la romana madre de’ Gracchi con una ballerina. E il confonder l’una
coll’altra è il più sicuro e più pronto spediente per guastarle ambedue. Con tali
precauzioni accingansi i giovani a studiare il . Riconoscano come eccellenti la Clemenza di
Tito, Achille in Sciro, l’Olimpiade,
Demofoonte, Issipile, Zenobia,
Regolo, Temistocle, la Betulia liberata,
il Gioas con pressoché tutti gli altri oratori sacri; come buone
l’Ezio, l’Artaserse, l’Eroe cinese, il
Demetrio, il Catone, l’Ipermnestra,
l’Adriano, il Ciro riconosciuto, il
Siroe, la Nitteti, il Trionfo di Clelia,
l’Asilo d’Amore, la Contesa dei numi, l’Astrea
placata con pochi altri de’ suoi componimenti drammatici più piccoli. Abbiano
poi qualche indulgenza per il Giustino, la Didone, la
Semiramide, il Ruggiero, l’Alessandro, il
Re pastore, e qualche altro con i suoi sonetti. Ma che tale distinzione
non nuoca punto al merito del portentoso autore, come la critica sulle opere loro non
sminuisce anzi maggiormente assicura la gloria di , , , e ,
co’ quali è paragonabile nel suo genere il .
Egli sarà sempre lume sovrano della sua nazione, e il primo poeta drammatico lirico
dell’universo. La Grecia avrebbe divinizzato il suo nome, come
già fece di quello di Lino e d’Orfeo.
Capitolo duodecimo §
Decadenza attuale dell’opera italiana. Cause generali di essa. Paralello della poesia e musica moderne con quelle dei Greci. Motivi della perfezion degli antichi, e inconvenienti intrinseci del nostro sistema musicale.
[1] Ma le cose umane non possono rimaner lungo tempo nel medesimo grado. Somigliante alla curva che descrivono nella immensità dello spazio i pianeti d’intorno al corpo che serve ad essi di centro, la carriera delle arti ha un origine, un accrescimento ed una decadenza inalterabile e certa, come lo sono le rivoluzioni degli astri. Non si maravigli adunque il lettore se nel dipigner, che farò, lo stato attuale dell’opera più non udrà risuonar que’ gran nomi che tanto splendore alla nazion loro recarono, se troverà le moltiplici parti che concorrono a formar il dramma, tutte per l’addietro ad un sol fine dirette languir in oggi separate e disciolte, se vedrà finalmente rapirsi dalle altre nazioni qualche ramo del fortunato alloro che pareva destinato dal cielo a crescere ed allignare soltanto sul terreno privilegiato della Italia. Si dovrà bensì maravigliare onde avvenga che in tanta luce di gloria, come abbiamo veduto balenare sinora, con numero sì grande di musici pregiatissimi e con tal fervore ed entusiasmo acceso per coltivare le scienze armoniche, pur tuttavia la musica non abbia in Italia prodotta la menoma particella degli stupendi prodigi che produceva in Grecia l’antica. La qual meraviglia tanto dee crescere maggiormente quanto che la sfoggiata ricchezza della nostra colla povertà paragonata di quella dovea renderci superiori in cotal genere. A tutti scioglierne i dubbi paratamente, e a metter chi legge in istato di giudicare della decadenza attuale del melodramma, d’uopo è fermarsi alquanto intorno alle cause generali di essa per discender poscia a delle particolarità più interessanti.
[2] Bisogna richiamar in mente ciò che abbiam detto in altro luogo, cioè che nel risorgimento delle lettere in Italia, come in tutta Europa, le belle arti non furono che un prodotto della imitazion degli antichi. Ciò si vede nell’origine della tragedia, e della commedia, e l’abbiam più chiaramente veduto in quello del dramma. Ma la nostra imitazion distaccata dai principi religiosi, naturali e politici che sostenevano l’original presso a’ Greci, e trasferita ad un sistema di religione, d’usi e di leggi in tutto differente per non dir contrario, non ha potuto produrre effetti simili a quelli che producevano fra loro le medesime cose. Gli uffizi di poeta, di musico, di cantore, di legislatore e di filosofo si videro nella Grecia per molti secoli riuniti in una sola persona, e cotal riunione fu costantemente adoperata come il più possente e immediato strumento per imprimer negli animi degli uomini i sentimenti necessari alla gloria, ed alla sussistenza delle nazioni: ond’è che la persona del musico o poeta era tenuta dal popolo insomma venerazione, e riguardata come il Palladio, o conservatore della pubblica felicità. All’opposto nelle nostre legislazioni che s’aggirano sopra un perno tutto diverso, la musica e la poesia, lontane dall’esser considerate come oggetti di somma importanza, si considerano al più come una occupazion dilettevole bensì, ma sempre inutile al bene religioso e politico degli Stati. Dal quale principio si ricavano alcune conseguenze, che possono a mio giudizio servire a spiegar lo scadimento presso di noi delle belle arti in generale, e più immediatamente di quelle che contribuiscono a formar il melodramma. La prima è che essendo fra noi da gran tempo separate la filosofia, la legislazione, la poesia e la musica, la loro individuale influenza ha dovuto esser minore perché divisa. La seconda, che essendo ciascuno di essi rami rinato dipersè e cresciuto separatamente dagli altri, la loro unione non ha potuto rendersi tanto adattata e pieghevole quanto la medesima lo era presso agli antichi. La terza, che non avendo né il poeta né il musico alcuna ingerenza negli affari dello Stato, anzi riuscendo loro troppo pericoloso il mischiarvisi, non hanno potuto esercitar il loro talento se non se intorno ad argomenti di puro diletto, e di niuna o pochissima utilità. Difatti qual diversità d’impiego non trovasi fra il e lo costretti di servire ai capricci d’un popolo spensierato e voluttuoso con quello d’Orfeo e di Terpandro, i quali o richiamavano al suono della lira i selvaggi erranti per le campagne a fine di riunirli sotto una legge ed un culto, ovver guidavano alla testa delle armate un popolo di eroi animandalo colla poetica armonia ai trionfi ed alle conquiste? Qual distanza infinita tra gli autori d’un libretto dell’opera e i legislatori o generali d’una intiera nazione? Qual differenza non si scorge nell’onorar, che noi facciamo, la memoria del più celebre musico con una iscrizione od un sonetto, e nel collocare, che facevano gli antichi, tra le costellazioni la lira d’Orfeo come degna di venir al paro coi segni celesti, appur inalzando altari al nome d’un poeta, o coniando le pubbliche monete colla sua immagine, o invocandolo nelle calamità del paese, non altrimenti che soglia farsi col nume tutelare, siccome sappiamo aver fatto quei di Mitilene colla celebre ?
[3] Da ciò si vede naturalmente quanto la diversa maniera di prender codesti oggetti ha dovuto influire sulla loro mediocrità. Imperocché ove le cose non hanno altro interesse se non quello che nasce da passaggiero e insignificante divertimento, la misura della lor perfezione altra appunto non è che il capriccio di chi vuol divertirsene. E siccome il privilegio di promuovere e di giudicare degli spettacoli è intieramente dato al popolo se non (come si dovrebbe) a persone distinte per sapere, prudenza e buon senso, così hanno essi degenerato in quell’assurdità e stravaganza che si osserva: quindi lo scadimento del moderno teatro e il niun effetto che fa sopra di noi l’unione di tutte le belle arti benché cospiranti ad un fine. Indarno la storia ci somministra esempi maravigliosi della possanza della musica presso ai Greci; indarno la filosofia, disaminando la relazione che hanno i movimenti dell’armonia col nostro fisico temperamento, stabilisce sistemi e ne ritrae le conseguenze; la sperienza, quello scoglio fatale contro a cui si spezzano tutte le teorie, ci fa vedere che il superbo e dispendioso spettacolo dell’opera altro non è se non, un diporto di gente oziosa che non sa come buttar via il tempo e che compra al prezzo di quattro o cinque paoli la noia di cinque o sei ore. Per iscacciarne la quale non bastando i prestigi e l’illusione di tutti i sensi, s’appigliano al perpetuo cicaleccio, al cicisbeismo, alla mormorazione, alle cene e al giuoco, né prestano attenzione alcuna allo spettacolo se non quando apre la bocca un cantore favorito per gorgheggiar un’arietta. Allor questa s’ascolta con un profondo silenzio, poi con istrepitose e fanatiche esclamazioni di “bravo evviva” accompagnate di battimenti di mano replicate cento volte; indi si torna all’antico dissipamento che ti par quasi di sentire come si lagnava dei teatri di Roma, il vento che rimuggia per entro alle boscaglie del Gargano o i fremiti del mar di Toscana109, nella sua celebre lettera sulla musica francese vorrebbe far l’onore agl’Italiani di non credere che così avvenga ne’ loro teatri, ed attribuisce simili effetti che si veggono costantemente in Parigi, all’indole soporifera e monotona della musica francese. Ma se questo filosofo valicasse presentemente le Alpi per chiarirsene co’ propri occhi di ciò ch’egli immaginava soltanto in sistema, avrebbe veduto che l’Italia non merita in questo punto maggior indulgenza della Francia. Avrebbe veduto che la musica più bella che si canti nelle lingue viventi, né il più bravo poeta dramatico-lirico della Europa, né l’ampiezza e magnificenza de’ teatri, né lo studio perfezionato della prospettiva bastano nel paese delle belle arti a destare in un popolo che cerca solo il piacer passaggiero di poche ore quelle commozioni vive e profonde, quel pathos che pur dovrebbe essere il gran fine di tutte le arti rappresentative.
[4] Niuno crederebbe che la ricchezza appunto della nostra musica fosse quella che la rendesse meno patetica. Eppur questa si è la seconda cagione che prendiamo a disaminare. Noi abbiamo un contrappunto, del quale si dice che gli antichi non avessero alcuna notizia; abbiamo un’armonia via più doviziosa e più raffinata di quella che avevano essi nel tempo in cui s’operavano effetti cotanto maravigliosi; si dice altresì che i moderni strumenti, abbracciando più ottave di quelli, siano più atti a produrre combinazioni più variate di suoni. Ma siffatti presidi, i quali rendono la nostra musica più brillante e più vaga, la rendono parimenti meno acconcia a destar le passioni. Questo, che a prima vista sembra un paradosso, verrà nondimeno facilmente accordato dal lettor giudizioso qualora ei voglia riflettere che la energia de’ suoni musicali nel muovergli affetti non altronde deriva se non se dalla più vicina imitazione della natura, cioè dalla espressione più esatta di quei toni naturali, nei quali prorompe l’uomo allorché si sente oppresso dal dolore, dall’ira, dalla gioia o da qualunque altra passione impetuosa e vivace. Ora egli è certo che quanto più l’armonia diviene artifiziale e complessa, tanto più si scosta dall’accento appassionato, e che a misura che i tuoni acquistano vaghezza e lavoro di note, vano essi deviando dal loro carattere imitativo; sendochè la loro successione nella voce dell’uomo semplice per se stessa e spontanea nulla ha di comune colla successione dei tuoni della musica imprigionata fra i ceppi di tante regole armoniche. Svanendo adunque la rassomiglianza tra la maniera d’imitare e l’oggetto imitato, qual maraviglia è se il cuore, che non ne sente il rapporto, rimane freddo e indifferente in mezzo alle tanto applaudite armoniose ricchezze?
[5] Che se nei suoni non vuolsi considerare la facoltà che hanno d’imitare, ma quella soltanto di agire fisicamente sui nostri nervi, anche a tal fine vedrassi la preferenza d’una cantilena, semplice sopra un’altra più lavorata e composta. Imperocché codesta seconda maniera d’agire dei suoni tanto è più efficace quanto più gagliarde sono le impressioni che per mezzo delle vibrazioni dell’aria comunicano i suoni ai nostro orecchio. Ma una musica troppo raffinata ne infievolisce la energia stritolando di soverchio le note, dividendo e suddividendo i tuoni in porzioni minutissime, indebolendo la voce col tanto assottigliarla e stancando, a così dire, la sensibilità col troppo squisitamente ricercarla. Non havvi che un determinato numero d’inflessioni atte a produrre in tutto il suo vigore un sentimento od una imagine, e cotali inflessioni sono tanto più energiche quanto più fedelmente esprimono la voce della natura. Quindi è che un urlo solo, un gemito, un sospiro d’un infelice tormentato trova subito il segreto d’intenerirci insinuandosi fino a’ penetrali dell’anima. La forza movente della melodia consiste nell’afferrare col mezzo dei suoni quei pochi ma caratteristici tratti, che fornisce l’oggetto preso ad imitare. Tutto ciò che l’arte ne aggiunge non è più il linguaggio dell’affetto, ma una circonlocuzione, una frase retorica dell’armonista. Non è per tanto da stupirsi se la musica moderna, la quale invece di rinvigorir le nostre sensazioni simplificandole, altro non fa che snervarle moltiplicandole all’eccesso, e invece d’afferrar il vero ed unico tuono della passione, non si cura se non di farci sentire trilli, arpeggi, volate con mille altri sminuzzamenti di voce, si ritrova infine come il Mida della favola che moriva di fame in mezzo agl’infiniti ragunati tesori.
[6] La storia ci porge una opportuna conferma della mia proposizione facendo vedere che la musica greca perdette il gran segreto di muover gli affetti a misura che si venne scostando dalla sua semplicità primitiva. Rozza in sul principio come lo erano i costumi degli abitanti, si disse che ratteneva i fiumi, ammansava le tigri e innalzava le muraglie di Tebe al suono della lira per significar con siffatte allegorie la prodigiosa influenza che acquistò sugli animi di quei popoli fra le mani di Lino, d’Anfione e d’Orfeo. Più varia in seguito e più doviziosa, ma semplice ancora e compagna inseparabile della poesia e del ballo animò successivamente i canti d’, d’, d’, di , d’, di e di , s’innestò col carattere e i costumi della nazione, divenne il fondamento della educazion pubblica e il veicolo della religione, della morale e delle leggi. Allora si può dire senza tema di esagerazione che il suono della lira governasse la Grecia collo stesso dispotismo con cui le nostre monarchie si regolano in oggi coi maneggi del gabinetto110. Sorgevano fra i Lacedemoni dissensioni civili? Ecco veniva a placarle senz’altra persuasione, altra forza che quella degli accordi armonici. Un decreto rigoroso vietava sotto pena di morte a qualunque oratore il proporre agli Ateniesi la conquista dell’Isola di Salamina? I canti di Solone fanno andar in tumulto il popolo, se ne abolisce il divieto, se ne allestisce un’armata, e se ne riporta una compita vittoria. Bisognava civilizzare gli Arcadi, perché troppo sanguinai e feroci? Il solo mezzo atto ad ottener questo fine vien creduta la musica. S’adotta un piano economico di pubblica amministrazione fondato sull’armonia si costringono a cantare con certe regole i fanciulli, gli adulti e i vecchi, e l’Arcadia, che dianzi era il soggiorno d’uomini selvaggi, diviene quello della giocondità e della placidezza. Da ciò si rileva il politico fondamento con cui molto prima dello stabilimento della filosofia i governi più illuminati della Grecia vegliavano con tanta cura affinchè la musica perseverasse inmutabile ed incorrotta nella sua istituzion primitiva. Furono singolari fra gli altri quelli di Sparta e di Creta. Tutte le loro canzoni e le loro danze erano, secondo la testimonianza di nel libro settimo delle leggi, consecrate agli dei. Era stabilito qual sorta di sacrifizi doveva assegnarsi a ciascuna divinità, e quali canzoni e cori a ciascun sagrifizio. E se qualcuno si serviva degl’inni e dei cori nel culto degli dei diversi da quelli che sono prescritti dalle leggi, i sacerdoti e i magistrati dovevano scacciarlo dalla comunità. È memorabile ancora su questo proposito il decreto degli Efori di Sparta contro Timoteo, dove codesto musico vien trattato come eretico e corruttore del costume pubblico per aver alterata l’antica musica aggiugnendo due corde di più alla lira. Da ciò si rileva altresì il perché in seguito gli uomini più saggi fra i Greci, persuadendosi che fosse più utile anzi necessario al bene dello stato il moderar le passioni del popolo che il troppo violentemente svegliarle, abbiano appunto nella musica regolata dalla filosofia trovato il segreto d’ottenere siffatta calma. Perciò nei secoli più remoti della Grecia s’introdusse il costume di cantar nei convitti le lodi degli dei e degli eroi affine d’impedire gli affetti della ubbriacchezza tanto più pericolosa a que’ tempi quanto che gli animi non ancor dirozzati si trovavano naturalmente disposti alla violenza. E perciò i generali Spartani allorché erano in procinto d’azzuffarsi in battaglia coi nemici diriggevano la marcia delle truppe loro piuttosto col suono dei flauti che con quello delle trombe, acciocché la temperata dolcezza di quelli correggesse la ferocia dei soldati, il soverchio ardore dei quali mal s’accomodava alla necessaria subordinazione.
[7] Il ritrovamento e progressi dell’arte drammatica siccome
contribuirono ad ampliar le richezze della musica via più raffinandola, così ne
scemarono a poco a poco la sua antica influenza. Sull’origine del teatro le azioni
drammatiche furono talmente considerate dai Greci, che secondo la testimonianza del
giudizioso gl’inventori delle tragedie si
paragonavano coi più gran capitani. «Che giovamento adunque» , dice questo scrittore, «fecero le tragedie cotanto onorate dagli Ateniesi?
La sagacità di Temistocle cinse di mura la Città, la diligenza di Pericle l’abbellì, libera la mantenne Miltiade, Cimane sollevò la sua gloria sopra le altre
repubbliche. Se parimenti la sapienza di ,
la facondia di , e l’impetuosità di
ripararono qualche rovina, ovvero
acquistarono novella gloria ed onore agli Ateniesi, ragion vuole che cotali
rappresentazioni contendano coi trofei che il teatro s’agguagli alla reggia e che il
maestro di siffatte invenzioni al capitano sia paragonato»
111.
[8] Ma guari non andò che la musica affascinata dalle proprie bellezze rinunziò all’imperio che avea fino allora ottenuto sugli animi, contentandosi di vanamente dilettare l’orecchio. La prima epoca della corruttela cominciò dacché sotto il governo degli Anfizioni s’introdussero in Atene le gare fra i ceteratori, cioè fra i poeti che cantavano le proprie poesie accompagnandosi colla cetra, e le sfide fra i suonatori di diversi strumenti. Un certo Polinneste accorciando al suo piacimento, e stangando le corde della lira, fece sentire dei suoni sconosciuti avanti a lui. Alcuni musici, lavorando per domestico diporto alcuni componimenti d’armonia saparata dalle parole, introdussero poscia nei cori dei drammi e in quelli dei giuochi pitici la fatale usanza di render la musica strumentale indipendente della vocale112. Tra poco la danza si separò dalla poesia e dalla musica, e l’una e l’altra non furono più confidate alle mani del legislatore. Allora formando ciascuno di questi rami un’arte da sé, nacque presso a’ Greci la scienza che i moderni chiamano musica, cioè quella combinazione artifiziosa di suoni che può esistere e realmente esiste divisa dalle parole, e che ha i suoi colori, le sue figure, i suoi movimenti, in una parola il suo linguaggio indipendente e proprio; laddove prima di quel tempo l’armonia non era una scienza a parte, ma un rinforzo soltanto della espressione poetica, o per esprimersi con più esattezza, altro non era che l’arte di far valere gli accenti della poesia. Separati che furono codesti rami, divenne necessario il condurli paratamente a quel grado di raffinamento che esigeva la vanità dei professori e la svogliatezza degli ascoltanti. La poesia non ebbe più quel perfetto combaciamento che aveva dianzi avuto colla musica, né questa colle affezioni dell’animo. Invano si tentò di richiamarla alla sua primitiva sorgente: invano e , e , e qualche altro celebre musico e poeta mossero guerra al nascente corrompimento; gli sforzi loro altro non fecero che ritardar per poco la malattia senza impedirne gli effetti.
[9] Il genere ditirambico divenuto alla moda fece coi suoi canti tumultuosi un misero governo della poesia, del ritmo e della musica. I compositori per distinguersi fra gli altri non seppero rinvenir altra via che la novità e la stranezza. Quanto più moltiplicavano essi i capricci dell’arte tanto più si scostavano dalla natura. S’ampliò il numero delle corde e de’ suoni negli strumenti, si confusero insieme le proprietà dei generi, dei modi e delle voci, né più sì conservò per l’avvenire l’applicazione delle cantilene ai loro rispettivi uffizi. Sovente, al dire di , l’armonia non aveva alcun riguardo alle inflessioni della voce, e queste sortivano dalla bocca del cantore senz’osservar la legge degl’intervalli. Al vedere tanti e sì rapidi cangiamenti il comico ebbe a dire che la musica, agguisa della Libia, generava tutti gli anni un qualche mostro di nuova spezie113. Dopo le quali mutazioni di cui , , , , e furono i principali autori, la musica cessò di cagionare i grandi effetti che prima era solita di produrre, e divenuta più artifiziosa e più dotta divenne meno espressiva e patetica. Nella stessa guisa che alla moderna musica, quantunque lontana assai dalle mentovate meraviglie della greca, se pur talvolta riesce di muover gli affetti, ciò non l’ottiene se non se slontanandosi dagli usati metodi per avvicinarsi alla semplicità. Ho udito persone intelligentissime raccontarmi che trovandosi in Roma, ed ascoltando ivi il famoso Miserere del eseguito dai cantori della cappella pontifìcia senz’altro ornamento che quello d’una voce fermata e sostenuta a dovere, si sentivano esse rapire in estasi di divozione e di dolcezza interna, lo che non era loro avvenuto di esperimentare sentendo lo stesso salmo cantato in altre città con tutto lo sfoggio delle moderne scuole. Il celebre asserisce la medesima cosa parlando delle antiche cantilene della Chiesa, fra le quali se si ritrova qualcheduna talmente grave, dolce e maestosa che i moderni durerebber fatica a lavorarne l’uguale, quella riesce appunto così eccellente perché composta con somma semplicità musicale, e perché istituita per una sola voce, e partecipando della natura del recitativo, ma in largo, non è legata a battuta rigorosa114.
[10] Potrebbero l’accennate riflessioni applicarsi con eguale
felicità a molti altri popoli, presso a’ quali la musica
vigorosa e commovente nel suo principio è venuta poi degenerando a misura che acquistava
un maggiore raffinamento; ma basterà per conferma del fin qui detto recar in mezzo
l’esempio dei Cinesi e degli Arabi, nazioni entrambe che hanno al paro dei Greci
conosciuta l’influenza di quest’arte sui costumi e sulla politica. Le tradizioni della
China parlano in guisa dell’armonia che quasi sembrano aver
esse voluto copiar fedelmente le favole greche. , e avean fatto non meno d’Anfione e d’Orfeo rattenere i fiumi e camminare le selve. Credono i Cinesi che
l’antica musica del loro paese avesse fatto scender dal cielo l’intelligenze superiori,
e cavati dall’abisso gli spiriti. Credevano altresì che per mezzo dell’armonia si
potesse ispirar agli uomini l’amore della virtù e della pratica dei propri doveri.
«Si vuol sapere s’un regno è ben governato e se i costumi di coloro che
l’abitano sono buoni o cattivi? Si guardi
il gusto della musica che vi regna»
diceva . Ma quanto siasi fra loro cambiata questa influenza dacché
s’introdusse un maggior artifizio ne’ suoni apparisce fra l’altre pruove dalla
dichiarazione fatta dall’imperatore Ngaiti, che sali sul trono l’anno 364 dell’era
cristiana, nella quale, lagnandosi che le musiche tenere, artifìziose, ed effemminate
ispirino il libertinaggio, ne commanda severamente la riforma, e proibisce ogni sorta di
musica a riserva di quella che serve per la guerra e per la cerimonia Tiao115.
[11] Gli Arabi ne avevano lo stesso trasporto per la musica e le stesse opinioni intorno alla sua possanza. Vantavano anch’essi in , in e in i loro , i loro e i loro , che operavano dei miracoli colla voce e cogli strumenti. La loro musica era innestata colla filosofia, e i sapienti sapevano trovare dei maravigliosi rapporti tra i suoni armonici e tutta la natura. Lo strumento chiamato zir era simile al fuoco pei suoni animati ed acuti che rendeva, il metsni somigliava all’aria pella dilicatezza della sua melodia, il bem aveva simpatia colla terra di cui ne imitava coi suoni la pesantezza e la gravità, e i motsellets l’avevano coll’acqua pei suoni freddi che generavano. L’armonia, secondo gli Arabi, era la panacea, ovvero sia rimedio universale del corpo e dello spirito. V’erano le ricette mediche per tutte le malattie fondate sui tuoni dell’oud o liutto, come v’erano gli aforismi morali e i luoghi topici dell’arte oratoria e poetica per eccitare ogni genere di passioni fondati sui moti della musica, e sulle diverse vibrazioni dei loro strumenti. Il Khaschbat e l’oud erano i principali. Accompagnando il suo canto col primo fece il famoso in presenza del Gran Visir passare un gran numero di persone radunate in un salone dalla indifferenza al tripudio, da questo alla tristezza, e dalle lagrime al sonno senza che alcuno potesse resistere a quell’incomprensibile incantesimo. Suonando col secondo una canzone lavorata a bella posta, il musico intenerì la fierezza del califfo Aaron Raschid, costrignendolo a raccomodarsi colla bella Maridè sua favorita da cui se n’era slontanato con fermo proposito di non più ritornarvi. L’idea che gli Arabi si formavano della musica si potrà meglio comprendere dalla traduzione del seguente squarcio che si trova in uno dei loro poeti, come lo ricavo da una erudita memoria del Sig. interprete delle lingue orientali a Parigi intorno alla musica di quella nazione, alla quale io rimetto i lettori che volessero acquistare più distinte notizie.
«L’impiego della musica è una pruova della sua eccellenza. I nostri imani compagni de geni celesti la impiegano nelle nostre moschee qualora si leggono le sacre pagine del Koran, all’esempio di Daoud (Davide) (possa l’Essere supremo ricolmarlo di favori!) il quale cantava egli stesso i suoi cantici al suono dell’arpa.
«Il piloto vigilante con gli occhi fissi sulla bussola e premendo colla mano il timone del naviglio canta tutta la notte per levarsi la noia, mentrecbè il marinaro rampiccandosi sulle corde e spiegando la vela non pensa ai rischi della navigazione e intuona la sua canzonetta.
«L’empia maga adopera anch’ella una specie di canto nelle misteriose parole che borbotta fra se. Coll’aiuto d’una sconosciuta e barbara musica richiama alla vita il moribondo abbandonato dai medici. Le sue magiche intuonazioni hanno la virtù di riunire l’ossa spolpate e rianimare le fredde ceneri dei morti, di sedare le onde agitate del golfo delle perle, di tarpar le ali all’arenoso vento dominatore dei deserti della Petrea, e d’abbagliare i nostri occhi colle vane appariscente di mille fantastici oggetti.
«Il robusto condottier di camelli, mettendo in non cale i disagi del viaggio, si diverte dalla noia cantando, e la sua musica semplice e naturale rallegra le caravane e affretta il troppo tardo camminare de’ suoi cammelli.
«L’astuto uccellatore adopera una musica che imita il canto dei diversi uccelli ingannati dai suoni omogenei che fa egli sentire nel silenzio della notte. La timida pernice, l’incauto tordo e il francolino che fugge lo sguardo degli uomini, inciampano frattanto negli agguati ch’egli ha teso loro nelle ascose reti.
«Il pastore, riposando allorché l’araldo della luce sferra i campi dopo il mezzogiorno sotto l’ombra d’una palma, o aggirandosi per le campagne allorché biancheggia la luna sull’orizzonte, il suo rustico heiraât, e tien sospesa la gregge colla dolce melodia, ispirando agli stupidi bruti l’amore e il desiderio di perpetuare la propria spezie.
«La madre infine, l’amorosa madre acqueta i pianti del bambino cui ella porge il proprio latte, e l’addormenta al suono delle dolci nenie ec.»
[12] Se non che i componimenti musicali degli antichi Greci
benché soggiacessero anch’essi col tempo alla legge di tutte le cose umane, nondimeno
conservarono lungamente il loro splendore a motivo della eccellente loro costituzione, e
dell’intimo rapporto che avevano insieme tutte le parti che li componevano. Si è parlato
in altro luogo della convenienza di siffatti spettacoli colle opinioni religiose del
gentilesimo, la quale fu, siccome abbiamo veduto, una delle principali cagioni della lor
perfezione: diamone presentemente una occhiata all’interno loro meccanismo, onde
rintracciar meglio la differenza che passa tra quelli e i nostri. Simplificando l’idea
che noi abbiamo della musica in generale, sembra che altro non intendiamo con questo
vocabolo se non se un’armonia grata all’udito prodotta dalle proporzioni dei suoni più
gravi o più acuti, e de’ tempi più veloci e più lenti. Il costume in cui siamo fin dalla
infanzia di non considerar nella musica che la semplice modificazione del suono secondo
le leggi armoniche, ci fa restringer quest’arte in così brevi limiti. Ma gli antichi, i
quali aveano di essa nozioni più generali, comprendevano sotto quella parola più cose.
Il largo significato che le davano i Greci apparisce più chiaramente dalle seguenti
parole che si leggono nell’Alcibiade di . «Socrate: Dimmi
primieramente qual arte è quella a cui appartiene il suonare, il cantare, e il
ballare? Non ti darebbe l’animo di trovare un nome che significasse tutte le parti
comprese in quest’arte? Alcibiade: Non saprei
trovarlo. Socrate: Provati un poco. Quali sono le dee che presiedono a quest’arte?
Alcib. Intendi forse di dire le Muse? Socrate: appunto. Considera dunque qual nome può
ricevere l’arte da loro. Alcib. Pare che tu vogli accennare la musica. Socr. Cotesto
appunto»
. Attenendoci soltanto alla divisione che fa in altro luogo lo stesso
116, la melodia costava appo loro di poesia di ritmo, e d’armonia. Dalla
perfezione ove fu condotta da loro ciascuna di esse parti separatamente prese, e
dall’intima corrispondenza che metter seppero fra tutte come linee dirette ad un solo
centro, devono ricavarsi in gran parte i prodigiosi effetti che ci vengono
descritti.
[13] E incominciando dalla poesia quantunque libera errasse in sul principio e vagante senz’altra regola che l’orecchio, né altra misura che gli spazi di tempo impiegati nel proferir le parole, guari non andò che dall’istinto ammoniti i poeti la frenarono con severa legge e invariabile. La lingua che serviva loro di strumento era la più flessibile, la più vaga, la più armoniosa, la più pittoresca e la più musicale che sia stata giammai parlata dagli uomini. Le doti che separatamente prese rendono bello ciascuno dei moderni idiomi si trovavano in lei riunite. La diversità dei dialetti dorico, ionico, eolico ed attico, che indifferentemente s’usavano dai loro scrittori, per mezzo dei quali le cose che non potevano esprimersi bene in una maniera s’esprimevano meglio in un’altra; le trasposizioni o inversioni della sintassi che aggiugnevano grazia, numero e volubilità singolare al periodo; la copia di parole imitative, ovvero sia di quelle che esprimono col suono l’indole dell’oggetto, che rappresentano e che indicano, per così dire, alla fantasia la strada battuta dall’intelletto per rinvenirle; l’uso frequente delle parole composte, onde accadeva che una sola espressione rappresentasse all’anima un gruppo d’immagini, erano vantaggi per loro, ai quali noi per soverchia timidezza abbiamo in massima parte rinunziato con discapito delle lingue e della poesia. Che si dirà poi dell’arte che avevano i loro musici nel contrasegnare gli accenti, onde così spiccata e sensibile rendevasi l’inflessione? Che della minutezza con cui si badava non solo alla natura dei vocaboli, ma anche all’indole e collocazione stessa delle lettere? ce ne dà un distinto ragguaglio della natura delle vocali, delle semivocali e delle appena vocali che potevano entrare nel verso. Sappiamo da lui cosa fossero le doppie e le liquide, le aspre e le tenui, le mute e le medie. Ci vengono indicati i diversi suoni che corrispondevano a ciascuna delle vocali e delle consonanti ora dolcemente sonori, ora scorrevoli e pieni, ora mollemente scabri, e sempre opportunamente variati; ci si fa vedere la scelta che di essi facevano i compositori, e la scrupolosa esattezza altresì con cui venivano adoperate dai poeti secondo il diverso oggetto che prendevano a dipignere117. I loro poemi, e singolarmente quelli di (genio immortale, cui nessuno ha pareggiato finora nella varietà, nell’abbondanza, e soprattutto nell’arte incomparabile di parlare all’imaginazione ed all’orecchio col mezzo de’ suoni) sono pieni zeppi di simili esempi. Vuol egli significare il sorriso, il vezzo, il favellio di Venere? Fa uso principalmente dell’“e” e dell’“i”, lettere delle più tenui e quasi cascanti.
«Ἰλιὼ δʹ αὐτε προσεενπε φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη»
[14] Se vuol esprimere in questo verso
«Ἠῖονες βοόωσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω»
il muggito del mare allorché percuote con impeto le rive, ei replica più volte la lettera “o” la più sonora di tutte e la più rappresentativa nel caso presente. Parimenti se vuol descrivere il galoppo de’ cavalli che traversano su e giù le cime del monte Ida, lo fa con evidenza tale che ti par quasi di sentirne il calpestio.
«Πολλά δʹ ἄναντα, κατάντα, παράντα τε δοχμὶα τʹ ἠλθον.»
[15] Ma lungo sarebbe il rilevare tutte le bellezze di in questo genere, come quelle altresì dei poeti drammatici fra i quali basterà per ultimo l’addurre una pruova tratta dal gran comico , che volendo nella sua commedia intitolata il Pluto rappresentar al vivo la golosità d’un parasito, lo introduce girando la scena d’intorno e fiutando senza dir parola l’odore delle carni abbrustolite per il sagrifizio. Il quale atteggiamento viene maravigliosamente espresso dal poeta con questo verso:
«ὒὗ, ὒὗ, ὒὗ, ὒὗ, ὒὗ, ὒὗ.»
dove col solo replicar molte volte quella vocale di suono oscuro e nasale, rappresenta ciò che vuol dire con più energia che da altri non farebbesi in una intiera scena.
[16] Colla stessa avvedutezza aveano pensato alla formazione del metro. Di cento ventiquattro piedi tra semplici e composti onde costava la loro prosodia (numero prodigioso, dal quale solo potrebbe argomentarsi la superiorità della lingua greca rispetto a tutte le altre) non si trovava neppur uno che non fosse stato inventato per adattarlo piuttosto ad una spezie di canto che ad un’altro. Imperocché avendo eglino con sottile filosofia osservato che le passioni dell’animo s’esprimono con movimento analogo alla loro natura, la tristezza, per esempio, e lo scoraggiamento con movimenti tardi ed ineguali, l’allegrezza e lo sdegno con movimenti rapidi e veloci, la speranza con moti più equabili, con più rimessi il timore, e così delle altre, s’avvisarono d’imitare il loro andamento nella poesia dando quantitativo valore alle sillabe, e certa misura alle parole, affinchè esprimessero colla loro durazione, lentezza o velocità l’indole fisica di essi movimenti, dal che trassero origine i poetici piedi e la combinazione loro diversa.
[17] Come una conseguenza di siffatta combinazione ne derivava la influenza prodigiosa del ritmo, il quale preso in generale è un movimento successivo eseguito secondo certe proporzioni determinate, preso in particolare s’applica alla poesia e alla musica. Nella poesia il ritmo è la durazion relativa de’ tempi che s’impiegano nel pronunziar le sillabe d’un verso; nella musica altro non significa che la durazion relativa dei suoni ch’entrano nella composizione d’un canto. Secondo gli effetti di questa misura del tempo si trovano anche nei corpi rozzi purché siano sonori. Se le campane vengono percosse egualmente, e con moti proporzionali, le ondulazioni si propagano con suoni chiari e gradevoli, se però percuotonsi inegualmente, s’apre di leggieri qualche fenditura e qualche volta sconciamente si frangono. Nel tamburo quantunque non ammetta alcuna varietà di suono, vedesi non per tanto che a forza delle varianti percosse escono fuori certi suoni esprimenti l’evoluzioni militari che dispongono i soldati al coraggio, e gli aiutano nella fatica118. Tal era l’affetto che quest’autore portava al ritmo, che lo credeva compagno indivisibile di tutta la natura. Lo ritrovava nel camminar lento non meno che nell’affrettato galoppar dei cavalli. Lo sentiva nell’acqua, che a stilla a stilla grondava chetamente sui sassi. Lo riconosceva nel volo degli uccelli, nella pulsazion delle arterie, nei passi d’un ballerino, e persino arrivava il sagace suo orecchio a ravvisarlo negli alterni battimenti del pettine allorché il suo parrucchiere gli pettinava i capegli.
[18] I Greci lo consideravano come una successivi rappresentazione o immagine degli oggetti dell’universo imitati dalla musica col mezzo del tempo e del movimento, i quali, risvegliando nell’anima la memoria o l’idea di quella tal cosa fanno che si riproduca in noi la stessa passione che ecciterebbe se sopposta fosse ai nostri sensi. Ora, siccome gli oggetti dell’universo agiscono sopra di noi con varie spezie di movimenti, così faceva di mestiere che i ritmi poetici e musicali comprendessero nella imitazion loro tutta la varietà di movimenti degli oggetti imitati. E l’eccellenza della poesia e della musica greca consisteva in ciò appunto che nessun effetto naturale poteva concepirsi che non venisse espresso dall’una e dall’altra colla maggior esattezza ora col numero de’ tempi sillabici impiegati nel formar un piede, ora colla rapidità o lentezza del movimento impresso alle parole o al suono, ora coi vari generi di ritmo di cui potevano far uso, ora finalmente colla successione e intrecciamento diverso dei medesimi ritmi secondo la differenza e il numero dei versi, e l’ampiezza e volubilità del periodo. Si voleva, per esempio, esprimere i movimenti snelli e leggieri, come sono quelli del ballo dei satiri? I poeti adoperavano il piede tribraco, che costava di tre sillabe brevi, e la misura musicale corrispondeva esattamente a queste. Si dovea rappresentare un qualche oggetto che agisse con imbarazzo, tardità, o fatica? Ecco gli spondei, e i molossi venivano in aiuto del compositore, il primo dei quali costando di due sillabe lunghe, e il secondo di due lunghe precedute da una breve, mostravano col loro tardo andamento la lentezza della cosa rappresentata. S’aveva intenzione di eccitare l’allegrezza e il giubbilo? Ciò s’otteneva col dattilo, i cui moti sono d’indole conforme. Per non dilungarmi oltre il bisogno il ritmo presso ai Greci e Latini era come un orologio, che misurava con tutta la precisione possibile l’andamento fìsico delle passioni, e il suo carattere individuale n’era talmente fissato che la trasposizione d’una sillaba sola bastava per cangiarne gli effetti. Di ciò ne basti arrecar una pruova. Essi facevano uso più volte nei loro versi di due piedi il giambo e il trocheo composti egualmente d’una sillaba lunga e d’un’altra breve con questa differenza però che il giambo incomincia da una breve, ed il trocheo da una lunga. Ora siccome il primo di codesti piedi sembra che ad ogni passo raddoppi altrettanto del suo vigore quanto ne va scemando il secondo, così i poeti satirici (alla testa dei quali fa d’uopo metter ) adoperavano il giambo per guerreggiare coi loro nemici mentrechè gli autori drammatici all’incontro facevano uso del trocheo allorché introducevano a ballar sulla scena i vecchi. Come fece nella commedia degli Acharnensi, dove a motivo del metro che vi si adopera, sembra che venga mancando di mano in mano il vigore ai vecchi che ballano nel coro. Secondo gli accennati principi il sistema della prosodia antica, nel quale i nostri ciurmatori grammatici altro non sanno vedere che un accozzamento insignificante di sillabe era fra le mani d’, d’, e di il pennello delle Grazie, la fiaccola del genio, e la cagion effettrice della musicale possanza.
[19] Ben più elevato e più sublime era l’altro vantaggio che
aveva il ritmo d’influire cioè sui costumi nazionali, e sulla pubblica educazione.
Benché tal proposizione paia ridicola agli occhi di coloro i quali tengono per favolosi
tutto ciò che non è conforme alle loro picciole idee, nondimeno la testimonianza degli
antichi filosofi su questo punto è così decisiva che non si può a meno di non assentire
qualora non si voglia cadere in un biasimevole pirronismo. Di molte che potrebbono
addursi, basti solo l’autorità di e quella di
. Il primo dice espressamente: «Voi
dovete adattare il modo al soggetto ed alle parole, e non queste al modo o
all’armonia; su queste materie concerterete con quali piedi o misure siano più adattate per esprimere l’avarizia,
la petulanza, il fanatismo e gli altri vizi, e quali metri esprimano meglio le virtù
contrarie. Quindi è che il ritmo e i numeri acquistano la loro forza nella educazion
musicale, ed esercitano la loro grande influenza sulle passioni
dell’anima».
119 Il secondo si mostra così persuaso della verità di questa opinione che
riguarda il cangiamento del ritmo come una delle corruzioni della melodia. «Se
noi mettiamo (egli dice) a confronto i tempi antichi coi
no
stri, troveremo che anticamente v’era
una gran varietà di misure, delle quali se ne faceva un gran uso, perocché nell’età
trascorsa la varietà del piede e del tempo era in grandissimo credito. Noi studiamo
presentemente, e ci applichiamo alla varietà de’ modi, gli antichi a quella del
ritmo».
120 Indi ne ricava poi la cagione per cui l’arte musicale, che
tanta influenza aveva dianzi avuta sulla pubblica educazione, si trovasse allora ridotta
a servire di mero insignificante diletto sui teatri.
[20] Ma in qual maniera il ritmo poteva essere così intimamente legato coi costumi d’un popolo che dallo stato di quello se ne dovesse cavar conseguenza allo stato di questi? Gran problema accennato da molti, ma da niuno (ch’io sappia) sciolto finora. Tentiamo di rispondervi insistendo sui principi che ci hanno fin qui servito di scorta. Il ritmo musicale era in tal guisa modellato sul ritmo poetico che l’indole, natura e durazione dell’uno era precisamente conforme all’indole, natura e durazione dell’altro. Il ritmo poetico non era che una successiva imitazione dei diversi moti delle passioni; il ritmo musicale adunque non poteva essere che una rappresentazion successiva dei medesimi moti. Ma le passioni degli uomini e la maniera d’esprimerle si vanno cambiando in un popolo a misura che va egli passando dallo stato di rozzezza a quello d’una progressiva coltura; lo strumento adunque destinato a rappresentar le passioni dee per conseguenza rappresentare i suddetti cangiamenti. Ecco il perché dalla natura del ritmo musicale si ricavava presso ai Greci una pruova dello stato attuale dei costumi, che hanno un così stretto rapporto coll’indole e la forza delle passioni. Esso era precisamente come il termometro, il quale indica con tal esattezza le variazioni accadute nell’atmosfera che dallo stato dell’uno s’argomenta a vicenda allo stato dell’altra. Ciò serve a spiegare altresì in qual parte della musica greca fosse riposta la tanto da loro vantata qualità d’ispirar le virtù, e di correggere i vizi. Da quanto si è detto finora risulta ch’ella consisteva sovra ogni altra cosa nel ritmo, il quale operando per via di metri o misure proporzionate all’indole di ciascuna passione, poteva facilmente con una serie di movimenti a bella posta scelti e diretti ad un solo fine temperare, correggere, o divergere altrove i movimenti delle passioni contrarie, onde nascono in noi le tendenze al bene od al male; essendo principio incontrastabile in filosofia che le virtù e i vizi puramente umani (non le virtù teologali, le quali suppongono un abito soprannaturale infuso dalla grazia divina) sono per lo più un effetto della sensibilità e del fisico temperamento, i moti de’ quali dipendono dalle impressioni che vengono loro comunicate, o che ponno comunicarsi dalla educazione non meno privata che pubblica. Qualora non per tanto si trovi un oggetto che agisca fortemente e immediatamente sulla sensibilità degli uomini, egli è chiaro che fra le mani d’un saggio filosofo diverrà esso uno strumento della virtù, come fra le mani d’un accorto legislatore diverrà il veicolo delle massime che si vorranno ispirare ad una nazione. Meditando sovra siffatti principi, si troverebbe lo scioglimento di tanti che a noi sembrano paradossi ne’ costumi degli antichi popoli, e si vedrebbe non essere cotanto favolosa, né contraria al senso comune l’opinione, che avevano i Greci intorno alla morale influenza dell’armonia. Mille pruove di fatto mi fornirebbe la storia loro se il mio scopo fosse quello di far pompa d’erudizione121.
[21] Dal particolare studio posto da loro nella formazion della poesia e del metro non meno che nella scelta e nel maneggio del ritmo s’arguisce con evidenza la cura con cui trattarono tutto ciò che concerne la musica propriamente detta. Noi siamo all’oscuro della natura intrinseca della greca armonia, chechè abbiano voluto dirci in contrario gli scrittori della storia musicale e i traduttori e commentatori dei Greci senza eccettuarne i più recenti e più accreditati. Noi non possiamo abbastanza comprendere cosa fossero i loro generi diatonico, cromatico, edenarmonico, parole che la moderna musica prende in significazione affatto diversa da quella che da essi ci vien tramandata. Non sappiamo con esattezza cosa fossero i modi, quale il loro uffizio invariabile, e l’accezione comune di siffatto vocabolo presso a loro. Ignoriamo la costruzione e l’uso preciso dei loro strumenti, il numero delle consonanze che potevano entrar nei loro sistemi, mille altre circostanze insomma, senza le quali riesce impossibile non che difficile il formar un positivo e sicuro giudizio122.
[22] Ma da un complesso di ragioni indirette cavate dai fatti si diduce che i Greci mostraron nell’uso che facevano della musica vocale e strumentale la medesima profondità di riflessione che nelle altre cose. Siccome in tutte le belle arti riguardavano essi come oggetto principale l’imitazione della natura, e siccome la possanza imitatrice della musica, massimamente nello svegliar le passioni, dipende, come si provò nel capitolo ottavo del primo tomo di quest’opera, dalla sola melodia, così rivolsero ad essa principalmente la loro attenzione, la costituirono il fine ultimo dell’arte del suono, e il centro, quasi direi, intorno al quale aggirar si dovessero come subalterne e inservienti tutte le parti dell’armonia. Si privarono, egli è vero, con siffatta idea, di molte squisite ed artifiziose modulazioni che questa produce presso di noi, e delle quali va così orgogliosa la nostra musica, ma non mostrarono di far gran conto di simili privazioni, stimandosi abbastanza ricompensati coll’acquisto d’altri fini assai più importanti e più propri d’ogni arte imitativa. Rilevando che l’energia dell’effetto è sempre in ragione dell’opportunità e della convergenza delle cause, si studiarono con sommo impegno d’adattare ad ogni effetto particolare che dovea generarsi dalla musica l’individuale cagione che dovea generarla. Però sempre gli vediamo intenti a trascegliere quei tuoni, quelli intervalli fra gli altri, quei menomi componimenti specifici che sembravan loro acconci ad eccitar piutosto certa classe di affetti che d’un’altra. Talché ogni genere, ogni cantilena, ogni modo aveva il suo particolar uffizio che lo distingueva. Il diatonico per le gravi e semplici materie, il cromatico, languido ed effemminato perché composto di semituoni e di terze minori, era fatto per esprimere la tenerezza e gli amori. L’enarmonico, il più complicato e difficile, si serbava per le situazioni più concitate dell’animo. Similmente l’armonia dorica non ilare o sciolta, non varia o molteplice, ma magnifica bensì, veemente e severa, s’adoperava singolarmente nella guerra. La frigia e la lidia riputavansi atte ad ispirar la mollezza con uffizio conveniente all’indole e costumi di quelle nazioni dalle quali aveano preso il nome. Ad ognuna delle anzidette cantilene, come ancora alla eolica ed alla iastica, due tuoni collaterali furono aggiunti col progresso di tempo l’uno verso il grave, e l’altro verso l’acuto talmente che da cinque divennero quindici cantilene o melodie diverse123. Ciascuna di esse era altresì a qualche particolar uffizio destinata colla esclusione d’ogni altro, dal che ne risultava una riunione di cause una convergenza di linee dirette ad un unico centro, che veniva a rinforzar la espressione in ragione dei mezzi. Mutavansi anche i modi, ovvero siano arie o cantilene secondo il senso delle parole, e al cangiamento di queste teneva dietro quello degli strumenti. Il modo dorico, che era il più grave, suonavasi con due tibie destre, il lidio più acuto con due sinistre, e il frigio mezzo tra l’uno e l’altro con due tibie parimenti una destra e l’altra sinistra. Nella poesia lirica modulata a più voci il coro cantava e danzava al suono degli strumenti, e singolarmente delle tibie chiamate coriche dall’uso loro, siccome corauli s’appellavano i suonatori. La loro esattezza arrivava fino a determinar il gener di strumenti che si conveniva all’età ed al sesso. Secondo gli uomini adoperavano le tibie perfettissime, e secondo le perfette e più che perfette. V’erano le tibie verginali, le puerili, e le virili, e siccome varie erano le spezie di esse, così le più brevi servivano pei fanciulli e per le fanciulle, le più lunghe si destinavano agli uomini, e le medie erano verosimilmente serbate per le donne124.
[23] Dal picciol saggio ch’io non ho fatto se non brevemente abbozzare, e che meriterebbe forse di esser trattato con maggior estensione, si comprende facilmente quanto sia rimasta addietro l’avvedutezza dei moderni. S’io volessi fare un processo formale alla nostra musica, larga messe mi si presenterebbe di riprensione disaminando l’imbarazzata e difficil maniera d’impararla, l’imperfezione delle chiavi che servono di regola all’armonia, i vizi radicali del nostro solfeggio, e la falsità di tanti principi ricevuti come incontrastabili unicamente perché nessuno ha voluto chiamarli a contrasto. Come la musica risorse fra noi ne’ più barbari secoli, nei quali gli spiriti non ancor digrossati erano incapaci d’abbracciare l’ampiezza d’un sistema, o di conoscere la fecondità d’un principio, così non facevano distinzione alcuna tra le arti di bisogno e quelle di puro diletto. In conseguenza gli autori o inventori delle note musicali contenti d’agevolare lo studio al solo fine che richiedevano le circostanze loro, non sospettaron neppure i cangiamenti che doveano col tempo sopraggiungere alla musica, e le novelle vie che aprir poteva in quest’arte lo sviluppo successivo del genio. Però a misura che l’armonia fece dei progressi trovossi ognor più difettoso il metodo d’impararla, al quale volendo ovviare i maestri, stabilirono di mano in mano regole nuove che palliavano gl’inconvenienti presenti senza prevederne i futuri, e che non recidendo il vizio nella sua radice, raddoppiavano le difficoltà moltiplicando i mezzi termini. Attalchè la musica si trova in oggi agguisa di quelle città, le quali fabbricate in origine su una pianta assai ristretta, e dappoi lentamente aggrandendosi, hanno qua un veicolo senza uscita, là una strada di diversa spezie, colà un borgo fuori delle mura, dappertutto aggiunte posticele che ne turban l’ordine e ne sfigurano la simmetria. Ma siccome a sviluppar bene tante e sì spinose materie vi si vorrebbe un intiero volume, e che altronde il fermarsi su tali cose non è necessario al mio assunto, così mi restringerò a toccar brevemente quei difetti che nella nostra musica impediscono, secondo il mio avviso, i maravigliosi effetti che dovrebbono attendersi dalla sua unione colla poesia. Quanto più avanti s’anderà col pensiero si ricaverà che cotai difetti si riducono a due, l’uno al non aver saputo noi mettere un rapporto abbastanza confaccente ed intrinseco fra queste due facoltà, l’altro all’usarsi da noi un genere d’armonia poco o niente opportuno all’espressione individuale delle passioni.
[24] E primieramente per una generale inavvedutezza, le cui cagioni bisogna ripetere dalla natura dei secoli, ove nacque l’una e l’altra di queste arti, abbiamo esclusi dal genere musicale quasi tutte le diverse e moltiplici spezie della poesia. Noi non contiamo in questa classe che le sole cantate, qualche canzonetta, e il melodramma. Il madrigale, che prima era in uso nelle musiche di camera, giace oggidì inoperoso fra le raccolte dei rimatori. Il sonetto, la canzon petrarchesca, la pindarica, l’anacreontica, l’elegia, la satira, l’ode, l’epigramma, l’idilio, l’egloga, la sestina, gli sciolti, le terze rime, l’ottava rima, la pastorale, la commedia, la tragedia, e soprattutto il poema epico, capo d’opera dell’umano ingegno, vengono trattati da noi come generi puramente poetici che mai non debbono accoppiarsi alla musica. Quindi non è da maravigliarsi che ridotta quest’arte a trattar pochissimi generi non abbia acquistata né la perfezione, né la varietà di quella degli antichi, presso a’ quali non mai disgiugnendosi l’una dall’altra, i confini della musica erano gli stessi che quelli della poesia. I nostri compositori si troverebbono fortemente imbarazzati se fossero costretti a metter sotto le note il più bel sonetto del , o del , o il più magnifico squarcio dell’ e del : né saprebbero qual modulazione applicare al genere epico, ovvero al pindarico; laddove i Greci sapevano a meraviglia adattare a ciascuna spezie la sua particolar melodia. E diversamente cantavansi i poemi d’ e di che gl’idili di , o di ; altra era la composizion musicale fatta sull’elegie di , e di , altra quella sulle odi d’ e di ; differente il canto dei ditirambi da quello dei giambi di , la musica de’ Nomi da quella di teatro, e così via discorrendo.
[25] In secondo luogo, nella parte che veramente ci resta siamo ben lontani dal poter venire in paragone con esso loro. Imperocché consistendo senza controversia ogni regolata armonia nella combinazione del tuono e del tempo, ogni poesia che non sia egualmente felice nella combinazione dell’uno e dell’altro non potrà adattarsi perfettamente alla musica, e per conseguenza non sarà musicale in tutta l’estensione del termine. Ora la nostra poesia, che tutta quanta è appoggiata al regolamento del tuono, altro ella non considerando nella formazione dei versi fuorché l’ordine degli accenti e il numero delle sillabe, è sommamente difettosa nel regolamento del tempo non avendo veruna misura fissa con cui poter regolare la durazion relativa della pronunzia nelle parole. Non così accadeva nella poesia musicale degli antichi, la quale era eguale alla nostra nel primo pregio, e superiore assai nel secondo. Eguale nel regolamento del tuono, perché sebbene non badassero eglino per formare i versi al numero materiale delle sillabe, avevano tuttavia la stessa cura, che abbiamo noi nella opportuna collocazione degli accenti sulle parole, della quale nasceva in gran parte il numero, e la cadenza delle loro poesie125.
[26] Superiore nella esattezza del tempo, perché venendo assegnato a ciascuna sillaba poetica il suo valore intrinseco o di breve o di lunga, e tardandosi nel pronunziare la lunga un tempo duplo di quello che si tardava nel pronunziare la breve, ne veniva in conseguenza che la misura musicale fosse regolata perfettamente dalla prosodia, così che il musico per batter con precisione il tempo non doveva far altro che seguitar alla cieca il poeta. La qual cosa non osserva da noi, poiché ignorandosi nella nostra poesia la quantità sillabica, e badando per la formazione del verso al solo numero di esse sillabe, la misura musicale fa tutto da sé, e poche volte va d’accordo colla poesia. Per esempio, se si dovesse metter in musica questo verso di :
«Dulces exuviae dum fata, Deusque sinebant.»
e quest’altro d’, che gli serve di traduzione:
«Spoglie, mentre al Ciel piacque, amate e care.»
egli è chiaro che al maestro resterebbe pochissimo da fare nel primo, poiché, trovando di già misurata ogni sillaba, non doveva far altro che impiegar quattro tempi nella parola “dulces” composta di due lunge, due nell’“ex”, un solo nell’“u”, un altro nel “vi”, e così per tutto il verso di mano in mano, al fine del quale si troverebbe esattamente aver corrisposto al pensier del poeta. Tutto ciò che il musico poteva metter del suo, era il movimento più veloce o più tardo; sebbene anch’esso veniva indicato dal poeta o col senso delle parole esprimenti lentezza, e velocità, oppure col vario intrecciamento dei ritmi, i quali guidavano la misura. Non così accade nell’italiano, poiché non sapendo se la sillaba “spo” sia più lunga o più breve della sillaba “gli” o della sillaba “e”, non sa precisamente se alla prima corrispondano più o meno tempi che alla seconda, e alla terza. Si vede non per tanto costretto ad abbandonare la poesia per badare al valor delle note musicali, le quali non avendo nella collocazion loro altro regolatore fisso che il solo arbitrio del musico, formano di per sé un ritmo musicale distinto per lo più dal poetico, e non poche volte contrario. Lo che si vede da ciò che sovente la stessa composizion musicale produce il medesimo effetto applicata a parole di sentimento intieramente diverso, siccome notarono alcuni nel famoso monologo di Armida di , e nello stabat mater del .
[27] Quindi è che invece di formar, come si dovrebbe, un unico e solo linguaggio, invece di concorrere unitamente al medesimo effetto che è quello di risvegliar nell’animo una cotal sensazione o imagine, nascono all’opposto due linguaggi diversi, quello cioè del poeta e quello del musico, ciascuno dei quali, cercando vestirsi di bellezze sue proprie e independenti dall’altro, ha posto quei rilevante divario che pur sussiste nei nostri moderni sistemi ad onta degli sforzi di tanti uomini illustri che vi si sono affaticati per levarlo di mezzo. E ciò che si dice della poesia rispetto alla musica, si dice ancora della musica strumentale rispetto alla vocale, cioè che vicendevolmente si nuocono per voler ciascuna primeggiare da sé, sottraendosi dalla dipendenza della sua compagna.
[28] So che i fautori della moderna musica, alla testa de’ quali fa d’uopo metter il Signor Don napoletano (nome caro alle lettere ed alla sua patria)126 mostrano di far poco conto del vantaggio che avevano gli antichi nel regolamento del tempo, quasi che simili finezze non siano necessarie atteso l’attuale sistema della lingua e della poesia italiana. Ma parlando in tal guisa qual idea si formano essi della imitazion poetica e musicale? Ignorano forse che queste non producono il loro effetto se non in quanto rappresentano simultaneamente all’anima una medesima sensazione o immagine? Che dove la misura non s’accorda esattamente colle parole queste dicono una cosa allorché la frase musicale ne esprime un’altra, e che un medesimo oggetto rappresentato sotto due aspetti differenti altro non fa che dividere l’attenzione dello spirito senza fissarla? Non s’accorgono essi che dove la lingua non ha una prosodia regolare e stabile, la misura musicale debbe anche partecipare di siffatta irregolarità? Che mai si può accordare il valor delle note ove le sillabe prive siano di quantità determinata? Che il movimento ed il tempo mancheranno della dovuta precisione se vogliono tener dietro alle parole? Che al più solo potranno averla nei concerti puramente strumentali, cioè nel genere meno perfetto della musica, siccome quello cui manca il principal fonte della energia, che consiste nella espressione di qualche individuale concetto dell’animo? Che a motivo di cotal incertezza il musico si vede sovente costretto a cangiar di misura, principalmente in quei luoghi dove gli intervalli della voce essendo meno marcati, e conseguentemente più veloce la pronunzia, le note non possono seguitar l’ordine delle sillabe? E che nelle arie stesse dove il riposo della voce sulle rispettive vocali è più durevole, e più facilmente possono accomodarsi le note, troppo è grande tuttavia l’incertezza del compositore nel numero delle note che a ciascuna sillaba dee corrispondere, e nei tempi che debbono impiegarsi nel proferirle? Però la mancanza di prosodia esatta è un vero e positivo difetto nelle nostre lingue, il quale per l’influenza che ha nella musica, spiega altresì sufficientemente le cagioni della sua diversità rispetto all’antica, dove per molti secoli non si conobbe l’uso delle prolazioni, ovvero sia d’affastellare più note sopra la stessa sillaba. Se prestiamo fede all’erudito Bochard, un siffatto costume fu tramandato a noi da quei poeti e musici antichi chiamati Bardi dai settentrionali, parola che, secondo lui, significa in ebreo lo stesso che “cantar in suoni sminuitati e rotti”. Non so se la conghiettura di questo erudito possa dirsi abbastanza fondata; dirò soltanto che l’usanza è tale da non ismentire la sua barbara origine.
[29] Ma che vo io parlando della mancanza di misura poetica quando la moderna armonia è tanto difettosa persin nella misura musicale? Acciochè questa fosse atta a produrre ogni genere d’espressione farebbe di mestieri ch’ella potesse esprimere ogni e qualunque ritmo o durazione relativa di tempo atto a svegliare un muovimento nell’anima. Così faceva la misura musicale presso agli antichi, la quale, essendo perfettamente modellata sulla prosodia poetica, rappresentava lo stesso numero di piedi ritmici che la poesia. La ricchezza non per tanto dell’una si comunicava alla sua compagna, dal che ne risultava la varietà prodigiosa dei ritmi non meno musici che poetici, onde lungamente abbiamo parlato di sopra. Ma qual è il numero di tempi che ponno esprimere le misure musicali accettate da noi? Se si parla delle misure semplici, le quali non sono che due la dupla cioè, e la tripla, la prima non esprime che due soli tempi, e la seconda tre. Se si parla delle composte, queste non sono che quattro, cioè la quadrupla, ch’è una dupla doppia, la dodecupla, ch’è una dupla triplicata, le sestupla, ch’è una tripla doppia, e la noncupla, la quale è una triplicazione della tripla. La prima di esse misure esprime quattro tempi, la seconda sei, la terza altri sei, e la quarta nove. Ora egli è chiaro che con siffatta divisione non si possono misurar molti ritmi che attissimi sono a muover gli affetti. Con qual misura, per esempio, si renderebbero il giambo, e il trocheo, il primo de’ quali costando d’una breve e d’una lunga, e l’altro d’una lunga e d’una breve, hanno per conseguenza bisogno d’impiegar tre tempi in due sillabe sole? Colla dupla? No, perché questa divide il valore in due soli tempi. Colla tripla? Ma, così facendo, la musica viene a cadere in due massimi inconvenienti. Il primo di metter due note in una sillaba sola, lo che, slungando e distraendo la pronunzia più del dovere, fa che affatto si perda il senso delle parole; ed ecco l’origine del gran difetto del canto moderno, dove a motivo di non trovarsi la dovuta proporzione tra il numero delle sillabe e quello delle note, si spendono talvolta tre o quattro minuti nel profferire una vocale. Il secondo di non assegnare la loro individuale differenza ai ritmi che costano di tre tempi, come sono il giambo, il trocheo e il tribraco; poiché misurandosi tutti tre ad un modo, cioè con una tripla, rimangono fra loro indistinti. né sono il trocheo ed il giambo i soli piedi esclusi dalla nostra misura, ma per le ragioni allegate finora anche gli altri che dai grammatici vengono chiamati anfimacri, anfibrachi e bachii, come ognuno può esperimentare da sé tentando di ridurli all’odierno modo di misurare. Quanto ciò ne ritardi l’effetto lo sanno coloro che hanno filosofato sull’origine e i fonti della espressione musicale, e che conoscono altresì come una sola spezie di misura non può se non che con discapito della espressione rendersi comune ai mentovati piedi, ciascuno de’ quali ha la sua individuale e privativa energia.
[30] Non mancano di quelli, i quali stimano la nostra musica abbastanza ricompensata colla invenzione di comporre a più parti, e col ripolimento e perfezione cui portata abbiamo l’armonia. Senza decidere se cotesta invenzione sia propria dei secoli moderni e del tutto sconosciuta agli antichi (questione oziosa, intorno alla quale non potremo assicurarci giammai, nonostante i molti e celebri autori che l’hanno trattata) egli è chiaro che la sua utilità almeno per la musica teatrale è tanto problematica che poco o niun motivo abbiamo d’insuperbircene. Questa proposizione è tanto conforme alla esperienza che , , e , allorché vollero inventare la vera musica drammatico lirica, non trovarono a perfezionare la melodia mezzo più spedito di quello di sbandirne e screditarne il contrappunto allora regnante127. Se non è concepibile in qual guisa le voci diverse e gli strumenti cantassero tutti all’unisono nei cori degli antichi, più difficile è ancora l’immaginarsi come la moltiplicità e varietà degli accordi che richiede il contrappunto possa produrre una determinata e individuale passione. Conciosiacchè ad eccitar questa fa di mestieri una serie di movimenti tutti dal principio sino alla fine conformi all’indole di essa, lenti, per esempio, ove si vorrà esprimere la maninconia, più spediti dove si tratti dell’allegrezza, velocissimi poi ove della iracondia, e così delle altre affezioni dell’animo in guisa tale che se fra loro si mischiano movimenti di diversa natura, non è possibile ottenere il desiderato intento, sendochè l’azione dell’uno viene scambievolmente distrutta dall’azione contraria dell’altro. Ora delle quattro parti principali che costituiscono la nostra armonia equitemporanea, cioè il basso, il tenore, il contralto e il soprano, il basso, che è l’estremo più grave e per conseguenza quello che procede con moti più lenti, si congiugne nella stessa cantilena col soprano, che è l’estremo più acuto e che procede con movimenti più celeri; dalla qual congiunzione risulta una mischia, una opposizione di forze che distruggono l’animo dell’uditore in parti contrarie senza fissarla ad un movimento determinato.
[31] Quanto si dice della moltiplicità delle parti si dice altresì della scelta degli intervalli che sono in uso nella nostra armonia. Si riducono questi (parlando de’ semplici, onde si formano poi i composti) all’ottava, le due settime, le due seste maggiore e minore, la quinta, la quarta, le due terze maggiore e minore, la seconda, il tuono e il semituono. La natura intrinseca di essi intervalli, e soprattutto di quelli che entrano ordinariamente nell’armonia, vale a dire l’ottava, la quinta, la quarta, le seste e le terze, n’è, e ne debbe essere affatto diversa, poiché la modificazione del suono che risulta da ciascuno, e conseguentemente l’azione fisica indi prodotta, è proporzionale alla sua estensione, gravità ed acutezza, le quali essendo rispettive in ciascun intervallo, differente altresì esser debbe l’effetto individuale che ne vien generato. Ciò è tanto vero che se in una cantilena fa il musico valere piuttosto una quinta, per esempio, che una terza, il risultato del suono e dell’effetto sarà conforme al tuono della quinta, e non della terza. Posto questo principio incontrastabile, facciasi la supsizione che il compositore debba esprimere un sentimento di allegrezza, e che gli intervalli più a proposito per rappresentare siffatto sentimento siano le due terze. Egli è chiaro in tal caso che la base fondamentale della modulazione dovrà principalmente raggirarsi intorno alle terze, che il movimento dovrà colla sua velocità aumentarne l’effetto, e che fra tutte le voci dovrà scegliersi quella del soprano come la più agile e in conseguenza la più atta a significar l’allegrezza. Mentre la cantilena non si modulerà che all’unisono, le cose tutte anderanno a dovere, ma modulandosi secondo le leggi dell’armonia equitemporanea necessariamente avverrà che le parti del tenore, del contralto e del basso procedano simultaneamente per gli altri intervalli mentre il soprano corre successivamente per quelli delle terze, i quali essendo d’indole diversa dagli altri e operando anch’essi secondo la propria disposizione, o rintuzzeranno la forza del tuono dominante, o faran nascere una cotal distrazione fra la voce principale e le aggiunte, che non potrà mai generarsi il dovuto effetto per cui voglionsi, come abbiam veduto, movimenti omogenei. Non si niega che da siffatto contrasto non possa per opera d’un valente compositore cagionarsi talvolta una combinazione dei suoni che diletti l’udito per la sua vaghezza ed artifizio e tale è appunto il merito intrinseco della moderna musica, dove l’arte d’intrecciare le modulazioni, la bellezza delle transizioni e dei passaggi, l’artifiziose circolazioni intorno al medesimo tuono, la maestria nello sviluppare e condurre i motivi, in una parola le bellezze estetiche dell’armonia sono pervenute ad un grado d’eccellenza sconosciuto affatto agli antichi; ma egli è indubitabile che siffatto artifizio non è atto ad eccitar le passioni, e che l’intrinseca ripugnanza che regna nel sistema della nostra armonia (ripugnanza nata dal comprendere insieme più spezie contrarie di movimento) le toglierà sempre mai il diritto di gareggiar colla greca nella quale siccome non trovavansi le squisitezze armoniche della moderna, così non si trovavan nemmeno le sue contraddizioni; il tutto era anzi al suo scopo maravigliosamente diretto.
[32] Il grande svantaggio della nostra musica è non per tanto quello che qualunque principio di conmozione venga eccitato da essa verso un tale oggetto è per sua natura indeterminato e generico, non individuale e preciso. Ciò si ricava, oltre l’intrinseca contrarietà, che abbiamo provato esistere nell’armonia, anche dalla natura stessa della cantilena o composizione, la quale a eccezione del tuono principale che varia secondo l’indole del motivo, in tutto il restante è costretta a prevalersi di que’ tali elementi che sono gli stessi per esprimere ogni e qualunque spezie d’affetto, ma che dovrebbero variarsi a misura del bisogno e delle circostanze. Dovrebbe, per esempio, la nostra composizione essere obbligata, come lo era la greca, a scegliere non solo gli intervalli in genere tra il grave e l’acuto, ma gli intervalli in ispezie di maggiore o minore estensione secondo il carattere della cantilena, non solo la voce, ma la voce determinata in quel tal dato grado d’intensione o di remissione, non solo i ritmi procurati in generale dalla misura, ma i ritmi specifici propri in tal modo di quella passione che non potessero trasferirsi a verun’altra, non solo la tendenza vaga della cantilena verso un tale oggetto, ma la tendenza individuale altresì di tutte quante le parti che la compongono.
[33] Ma fintantoché il movimento totale verrà in qualunque
composizione accompagnato da movimenti parziali che ne distruggon l’effetto; fintantoché
i minimi componenti dell’armonia non avranno fra loro un essenziale e perfetto
combaciamento; fintantoché non si leverà di mezzo quella opposizion negli estremi
inerente ed intrinseca al nostro sistema musicale; fintanto insomma che non ripiglieremo
il metodo antico ch’era quello di dirigere la sua azione verso d’un solo punto, noi
avremo un bel vantare la nostra musica e dileggiare quella dei Greci, ma la verità, ch’è
sempre la stessa malgrado il sorriso della prevenzione e i sofismi della pedanteria, ci
farà vedere che noi non abbiamo della musica fuorché la parte più materiale e meno
importante, che non conosciamo lo spirito vivificante che l’animava altre volte, che non
possiamo scontrare in essa la vera espressione se non rare volte, e per puro accidente,
che quale noi la coltiviamo non é atta in se stessa a produrla, e che finalmente cotesta
facoltà incantatrice e prodigiosa non è presso ai moderni, come lo dice a chiare note il
celebre 128, se non «l’arte
insignificante di combinare i suoni»
.
[34] Ricercata filosoficamente l’intima differenza che corre tra
il nostro sistema musicale e quello degli antichi, e indicati in generale gli
inconvenienti annessi alla nostra armonia, pare che la serie di ragioni addotte fin qui
bastar dovesse a pienamente confermare il mio assunto. Ma siccome nel numero dei lettori
haccene ancora di quelli che facendo professione di vivere eternamente attaccati ai
pregiudizi della lor nazione e del loro secolo come le cariatidi al piedistallo delle
statue, m’accuseranno di troppa baldanza per aver osato chiamar in giudizio la moderna
musica, così a costoro incapaci di sentir per se stessi la forza d’una pruova, fa d’uopo
venir avanti coll’autorità spezie di argomento che l’inerzia adotta volentieri perché la
dispensa dal ragionare, e che il pregiudizio accarezza talvolta a fine di nasconder
colla stima che mostra verso le opinioni d’un solo, il disprezzo che ha per la capacità
di tutti gli altri. Sentano essi adunque parlare due scrittori cogniti alla
Europa non che alla Italia per la loro
perizia nelle scienze musicali, e che non possono venire accagionati di giudicare senza
cognizione di causa. Il primo è il celebre Padre , il quale sembra avere epilogato nel testo seguente quanto da me è
stato detto finora intorno alle due musiche. «La loro musica
(parla dei Greci) era finalmente e precipuamente diretta a muover gli affetti
dell’animo, dove la nostra ha per iscopo principalmente l’allettare e pascere il
senso, e a trarre in ammirazione gli ascoltanti mercè la finezza dell’arte praticata
in tutte le sue parti. Che se qualche rara volta giugne la nostra musica a muovere
qualcuno degli affetti, per esser caso raro, ci fa conoscere che ella
intrinseca
mente e di sua natura non
possiede codesta attività».
129 Il secondo è il famoso
, che nella prefazione alla sua
Parafrasi musicale sopra i primi venticinque salmi, parlando di tutte
quelle cose che nella musica greca concorrevano ad eccitar le passioni, si spiega in tal
guisa: «Ma quanto poi siano queste in oggi tolte a noi da nuovo costume, o trascuratone
l’uso di esse, egli è ben facile da comprendersi dal non udirsi che appena o di rado da
canti nostri, benché da vari consonante copiosi, e di vari movimenti e leggiadri
produrre nell’animo nostro qualche menoma parte di quelli antichi tanto ammirabili
effetti, i quali a chiunque odali raccontare sembrar convengono piuttosto favole che
veri»130.
Capitolo decimoterzo §
Cause particolari della decadenza attuale dell’opera. Prima Causa. Mancanza di filosofia nei compositori. Difetti nella composizione. Riflessioni sull’odierno uso della musica strmentale. Esame dei recitativi, e delle arie.
[1] Gl’inconvenienti annessi al nostro sistema musicale non impedirono ai compositori il creare delle bellezze parziali, e il condurre ciascuno dei rami del melodramma al grado di perfezione ond’era capace. Se l’odierna musica non ha più per iscopo quel fine morale cui la conducevano i Greci, e se tutte le parti che concorrono a formar lo spettacolo non hanno fra noi quella relazione e congegnamento totale che fra loro avean messi la lunga usanza di molti secoli e lo scambievol rapporto aiutato dalla legislazione, può quella, nonostante, adattarsi mirabilmente all’oggetto che si propone, ch’è di lusingar il senso con vaghe e brillanti modulazioni, e possono queste ridursi ad una certa unità, la quale se non appaga del tutto la severa ragione, basta nullameno per sedurre l’immaginazione con una illusione aggradevole.
[2] Alcuni compositori italiani, e non pochi ancora fra i moderni poeti hanno fatto vedere in pratica ciò che la filosofia pronunziava da lungo tempo come certissimo, cioè che le modificazioni del bello sono assai varie, che i fonti del diletto nelle belle lettere e nelle arti non furono dagli antichi pienamente esauriti, che la barbarie dei nostri metodi era capace di dirozzarsi fino ad un certo punto e ringentilirsi, e che da un sistema diverso da quello dei Greci potevano gli sforzi del genio far iscaturire nuove sorgenti di vero, d’intimo, e di non mai sentito piacere. Così dallo stato svantaggioso in cui si trovava la musica in certi secoli, e dall’ignorar la maniera d’applicarla alla poesia nacque la tragedia recitabile, preferibile a molti riguardi alla cantata; così dalla perdita dell’antica prosodia nacque la rima, che sì maraviglioso diletto ci porge ne’ poemi dell’, del , e del , come nei versi di , di , di e di ; così dalla strana confusion di più voci nelle musiche ecclesiastiche vennero le sublime composizioni del , del , del , e del ; così finalmente dalle rozze rappresentazioni fatte nel Pra della Valle, ovvero in Firenze nel Calen di Maggio, sorsero in seguito gli spettacoli fino a farci sentire le maraviglie d’un , d’un , d’un , e d’un .
[3] Ad altre cagioni oltre le accennate fa di mestieri non per tanto appigliarsi volendo esporre i motivi della dicadenza attuale dell’opera italiana. Se non si può legitimamente pretendere che il compositore, il musico, il poeta ed il ballerino diano alle rispettive lor facoltà la forma stessa che avevano venti secoli a dietro, si può bensì con ragione esiger da essi che non isformino quella di cui lo stato loro presente le rende capaci. Colpa è di loro la niuna rassomiglianza che ravvisa lo spettatore fra la natura che doveva imitarsi, e le belle arti che promettono d’imitarla. Colpa è di loro lo sconcerto e disunione che regna nel tutto, e gl’infiniti abusi che hanno preso piede in ciascuno di questi rami in particolare. Colpa è di loro la mancanza d’illusione e di verosimile che vi trasparisce, e che rende sconnessa, grottesca e ridicola la più bella invenzione dell’umano spirito. né giusto sarebbe incolpare le arti pei difetti degli artefici. Perlochè avendo io divisato di far conoscere ne’ seguenti capitoli quanto questi abbiano contribuito alla totale rovina del melodramma, e incominciando presentemente dalla composizione, io dico che il primo e capitale difetto dell’odierna musica teatrale è quello di essere troppo raffinata e poco filosofica proponendosi solamente per fine di grattar l’orecchio e non di muovere il cuore, né di rendere il senso delle parole, come pur dovrebbe essere il principale ed unico uffizio della musica rappresentativa. E non altrimenti avverrà finché si tralasci l’imitazione della natura il vero, il grande, il patetico, il semplice per correr dietro alle bambocciate, alle caricature e a’ falsi ornamenti. Si lodano bensì dai maestri dozzinali, ma non si studiano, non s’imitano le opere dei sommi compositori della trascorsa età, ciascuno vuol esser originale da sé ed aprirsi delle vie novelle, le quali non trovandosi se non se nella ricerca della natura ch’essi non conoscono, e nella profonda meditazione di cui sono incapaci, la loro invenzione ad altro non si riduce che ad uno stile capriccioso, ad un falso raffinamento che lusinga la loro vanità, e che rovina intieramente la musica.
[4] A fine di vedere se sia o no esagerata la mia proposizione, entriamo in un qualche esame intorno al metodo con cui si lavora in oggi la musica delle opere, cercando di farlo con quella imparzialità che si conviene ad un filosofo, il quale non iscrive mosso dall’odio o da connivenza per chicchesia, ma per solo amore del vero. E guardiamoci bene di non avanzar cosa che appoggiata non venga sulle eterne e generiche idee di quel bello ideale, innanzi a cui spariscono i pregiudizi, come le nebbie dardegigate dai raggi del sole.
[5] E incominciando dall’uso che si fa generalmente della musica strumentale, pare a me che la perfezione alla quale si è voluto condurre dai moderni da mezzo secolo in quà abbia contribuito non poco alla rovina della espressione nel melodramma. Ne’ tempi felici dei , dei e dei l’attenzione di que’ sommi maestri era unicamente rivolta a far valere il canto e la poesia, e non gli stromenti, avvisandosi con gran giudizio che questi altro non essendo che una spezie di commento fatto sulle parole, era una stoltezza da non sopportarsi che primeggiassero essi sulla voce e sul sentimento, come non potrebbe non tacciarsi d’ignoranza un grammatico che dasse maggior pregio alle illustrazioni di Servio o de la Cerda sulla Eneide di che non al testo istesso del divino poeta. Tutta l’energia della musica era riposta allora nella espressione delle parole, e l’orchestra non faceva che accompagnarle sobriamente e sotto voce per il comune. Siffatta semplicità non piacque lungo tempo al pubblico incostante, né ai capricciosi maestri. S’accrebbe il numero e la qualità degli strumenti, gli accompagnamenti divennero poco a poco più ricchi, l’orchestra acquistò maggior forza e vigore fra le mani principalmente del , dell’, e del , i quali seppero, nonostante, conservarla senza dar negli eccessi, stimando che la musica strumentale esser dovesse per la poesia131 ciò che per un disegno ben ideato la vivacità del colorito o il contrasto animato de lumi e delle ombre per le figure. L’uso ne fu portato più avanti dal compositor milanese, che rivolse a siffatto oggetto tutta la sua attenzione. Dal in quà questa parte del melodramma ha ricevuto degli accrescimenti che oltrepassano ogni credenza. Si è moltiplicato all’eccesso il numero dei violini, si è dato luogo nella orchestra a gli strumenti più romorosi. I tamburi, i timbali, i fagotti, i corni di caccia, tutto è ivi raccolto a far dello strepito. Si direbbe che qualcheduna delle arie che si sentono accompagnate in simil guisa fosse un azzuffamento di due eserciti nemici in un campo di battaglia.
[6] Tra il fracasso dell’armonia, tra i tanti suoni accavallati
l’uno sopra l’altro, tra i milioni di note, che richieggono il numero e la varietà delle
parti, qual è il cantore la cui voce possa spiccare? Qual è la poesia che non rimanga
affastellata ed ingombera? Molto più dacché un altro vizio non minore di questo è venuto
di mano in mano prendendo piede, cioè la spessezza della note. Queste negli antichi
spartiti erano grandi e largheggiavano assai negli spazi onde aperti riuscivano i suoni
vigorosi e distinti. Al presente sono esse così minute che non hanno luogo a fare una
impressione durevole, né servono ad altro che a snervare, a così dire, la forza del
suono spezzandolo in parti troppo deboli perché troppo leccate, nella stessa guisa che
l’eccedente uso dei diminutivi nello stile rende molle di
soperchio e stemperata la poesia132. Inoltre, succedendosi così affollate e con tanta
rapidità, affogano la voce del cantore in maniera che poco o nulla si sente dagli
uditori. Ed ecco che invece di andar insieme la musica vocale e la strumentale, invece
che la strumentale serva di appoggio alla vocale, come richiederebbon l’ordine e la
natura, quella al contrario confonde questa, potendosi dire a ragione che sono gli
strumenti che cantano, non già il cantore. Ognun vede da sé quanto nuoca cotal difetto
alla illusione dello spettatore; imperocché altro egli non sentendo che il romore degli
stromenti, né sapendo a quali parole, a quai sentimenti si riferisca tutta quella
armonia, la serie di sensazioni che si svegliano in lui diviene inutile, perché priva
d’oggetto. Allora non trova più verosimiglianza o interesse nell’opera di quello che
troverebbe in un semplice concerto. E allora ci va egregiamente il «suonata, che
vuoi tu?»
del .
[7] Non è difficile il rintracciarne i motivi di codesto progressivo accrescimento della musica strumentale. L’arte del suono è stata coltivata dipersè in Italia e in Germania da uomini eccellenti, che hanno saputo ritrovar in essa bellezze inusitate e novelle modificazioni di gusto. Alla soavità e dilicatezza che spiccano nelle composizioni italiane, si è saputo innestare la novità de’ passaggi e lo stile agiato e torrente che proprio sembra di alcune scuole tedesche, fra le quali campeggia quella del celebre , boemo di nazione, scrittore fecondo e rapido di fantasia inventrice, di prontissimo ingegno, e che tra i suonatori ottiene il medesimo luogo che Rubens tra i pittori. Queste bellezze parziali, alloppiando in particolar modo gli orecchi dell’uditore, hanno fatto sì ch’ei cerca di gustarle separatamente dalle altre, e che non ritrova nella melodia vocale un compiuto diletto se non gli perviene ai sensi accompagnata dal colorito forte degli strumenti. Il quale riflesso fa più d’ogni altra cosa vedere quanto l’uso e il postume possano modificare le facoltà interne dell’uomo fino a creare in lui dei gusti fattizi opposti o diversi da quelli che sono più conformi alla natura. Imperocché egli è certo che fra l’imitazione che si propone la musica vocale, e quella ch’è propria della strumentale, la prima è più fedele, più circostanziata e più immediata che non è la seconda, dove la distanza tra la maniera d’imitare e l’oggetto imitato è assai grande a motivo di non imitatisi le cose se non se in maniera troppo vaga e generica. Di modo che non si discernerebbe punto l’individuale argomento che gli strumenti prendono a dipignere, se le parole non venissero in aiuto del suonatore facendone la dovuta applicazione dei suoni a qualche caso particolare, indicandone le circostanze e i principali lineamenti additandone. Se si dovesse rappresentare sulla scena lirica quello squarcio mirabile della Eneide, allorché Didone si vuol uccidere di propria mano col ferro lasciatole in dono dal traditore Enea133, il compositore non potrebbe significare l’attuale situazione di quell’anima lacerata, se non se con un mormorio cupo ed agitato delle corde più basse, col suono piagnente degli stromenti da fiato, con modulazioni rapide, veloci e precipitate, le quali, imitando i fenomeni che accompagnano la terribile maestà della natura nelle tempeste, o negli sconvolgimenti dell’oceano, facciano per comparazione comprendere il morale scompiglio, in cui si trova la disperata Didone
«… magnoque irarum fluctuat aestu».
[8] Ma siffatti colori non convengono a quel quadro soltanto. Qualunque eroe, qualunque eroina si trovi nello stesso caso verrà dagli stromenti dipinta nella guisa medesima. Que’ tratti principali, que’ contorni decisivi che caratterizzano le figure, rimangono affatto indistinti. E le circostanze particolari che danno sì gran mossa e vivacità alla eloquenza di , come sarebbe a dire, le strane vicende per le quali è pervenuto quel ferro da i campi di Troia fino ai lidi di Cartago, il diverso fine cui serbavalo Enea, lo sfortunato e miserabil uso che ne fa Didone, l’eccesso di passione che la guida a troncare sì lagrimevolmente i suoi giorni, l’avvenenza, le grazie e le altre ragguardevoli doti che degna rendevano la bella regina d’assai più lieto destino, i benefizi renduti da essa al principe troiano, e l’ingratitudine imperdonabile di costui verso una principessa cotanto amabile, mille altri aggiunti insomma che feriscono, a così dire, il cuore a colpi raddoppiati, e dall’aggregato de’ quali risulta poi nello spirito quella sensazione complessa che ci intenerisce e ci attacca agli oggetti imitati; tutto ciò, io dico, è intieramente perduto per gli strumenti. E questa è la cagione altresì per cui le suonate, le sinfonie, i concerti e gli altri rami di musica strumentale, di rado o non mai svegliano in noi quel vivo interesse che sogliono destare il canto e la poesia, le quali esprimendo una qualche passione determinata che si contempla dall’anima in tutti i suoi aspetti, eccita in noi altrettanti motivi di attaccamento verso l’oggetto di essa quante sono le individuali circostanze, che vi si scorgono.
[9] (chi lo crederebbe?), il gran ha colle sue liriche bellezze contribuito a propagare il medesimo difetto. Le molte comparazioni che arricchiscono le sue arie, e che tante e sì leggiadre pitture contengono degli oggetti fisici della natura, hanno per necessità dovuto aprire un vastissimo campo all’uso, varietà e forza degli strumenti. Il suo spirito dotato, a così dire, di un tatto squisitissimo per presentire i diversi effetti della musica, ha saputo a maraviglia distinguere ciò che poteva esprimersi colla voce da ciò che dovea rappresentarsi principalmente dalla orchestra. Egli ha conosciuto che siccome non ogni inflessione, non ogni accento della umana favella era da imitarsi dagli strumenti, così non era proprio del cantore l’esprimere ogni o qualunque imagine. Gli oggetti dell’universo agiscono sopra di noi in mille maniere che la melodia vocale non può, per quanto si faccia, perfettamente imitare. E il movimento progressivo, e la quantità, e l’odore, e il calore, e il sonno, e la quiete, e le tenebre, e cent’altre qualità or positive or negative dei corpi non si esprimono in veruna guisa col canto, di cui solo è proprio l’afferrar la voce della passione, e i tuoni elementari dell’umano discorso. Dirà il poeta con molta leggiadria:
«L’aura, che tremalaTra fronda e fronda;L’onda, che mormoraTra sponda e sponda,È meno istabileDel vostro cor.»
[10] Ma come verranno rappresentate dal cantore il dolce sibilo, il susurro blando e lo scherzevole tremolio di quel venticello che soavemente romoreggia tra le frondi? Quai trilli, quai gorgheggi potranno rendere il placidissimo scorrere, il fuggire, il ripiegarsi, il vivace gorgogliar di quell’onda fra le rive? Certo è ch’egli farebbe schiamazzar dalle risa tutta l’udienza se accingersi volesse all’impegno di esprimer colla sua voce tai cose. Lo stesso dico s’egli prendesse a rappresentare i mugiti d’un mare agitato, gli urli dei mostri vaganti per le foreste, il romore del tuono, il cupo chiarore dei lampi, l’albeggiare della rosata aurora e l’armonioso canticchiare degli augelli. Siffatta incombenza appartiene piuttosto agli strumenti, i quali pella varietà e configurazione loro diversa onde capaci riescono di combinazioni più numerose di suono, possono più acconciamente imitare le diverse proprietà sonore dei corpi.
[11] Ad essi appartiene altresì il servire di supplemento alla voce umana nella espressione degli affetti. Il canto non basta più volte per far capire agli uditori tutta l’agitazione onde vien lacerata l’anima del personaggio. Havvi degli accessori nelle passioni, dei contrasti fra le idee, delle alternative fra i sentimenti, dei silenzi che nulla dicono perché si vorrebbe dir troppo, delle circostanze dove si bramerebbe d’avere cento lingue per palesare con esse la folla e il tumulto delle sensazioni interne onde siamo la vittima. In tali occasioni la strumentale è una spezie di nuova lingua inventata dall’arte affine di supplire all’insufficienza di quella che ci fu data dalla natura. Zenobia scaccierà via dalla sua presenza l’amato Tiridate perché la sua virtù la costrigne a levarsi dagli occhi un sì caro e sì pericoloso oggetto, ma nell’atto di profferire colla bocca il fatale decreto gli strumenti coi loro suoni non altro spiranti che tenerezza ci faranno intendere quanto costi al cuor di Zenobia quel rigore apparente. Dirà lo sdegnato Giasone a Issipile:
«Muori, se vuoi morir, ma muori altrove.»
ma l’orchestra dirà all’afflitta principessa in altro linguaggio che quella barbara sentenza
«Sulle labbra gli sta, ma non sul cuore».
[12] Mandane vorrà farla da eroina con Arbace, e rimproverandolo del suo tradimento gli dirà:
«No, non ti credo, indegno.Dimmi che un empio sei,E allor ti crederò.»
ma gli strumenti toglieranno, a così dire, il velo a quella finta alterezza, e faranno capire agli uditori che v’ha un’altra voce dentro di Mandane, la quale risponde
«Odiarlo, oh Dio! vorrei,Ma odiarlo, oh Dio! non so.»
così nelle interrogazioni che l’uomo appassionato fa sovente a se medesimo, nelle apostrofi oggetti inanimati dell’universo, e in cent’altre occasioni la musica strumentale si rende necessaria o per aumentar l’espressione, o per maggiormente sviluppare la sensibilità, o per supplire alla scarsezza della vocale o per imitar molte cose che cadono direttamente o in direttamente sotto il governo della musica, l’uso dunque delle similitudini assai frequente in , e la varietà di situazioni che somministrano i suoi drammi, hanno contribuito al medesimo fine134.
[13] Da cotal lusso nell’applicazione della musica strumentale si deducono alcune conseguenze di pratica oltre le indicate di sopra, le quali non sia inutile osservar brevemente. La prima si è la difficoltà che apparisce nel combinar fra loro tante parti diverse subordinandole in maniera che ne risulti un unico suono principale senza che i suoni parziali confondano il dominante, o si facciano sentire separatamente da esso, o producano un effetto differente da quello che si pretende. Diffatti pochi sono que’ maestri che sappiano diriggere il movimento di tutta l’orchestra al gran fine della espressione, e cavare da esso solo l’utilità che si potrebbe per rimettere, eccitare, trasfondere e variar le passioni. Pochissimi poi che sappiano dare a ciascuna delle parti principali che compongono l’armonia, quel particolare andamento che le si converrebbe a preferenza d’ogni altro. Eppure dalla opportuna distribuzione di esso movimento ne risulterebbe il massimo effetto possibile. La cagione si è perché essendosi osservato che quando il tuono fondamentale vibra una volta, l’ottava di esso tuono ne vibra due volte, la duodecima tre e così via discorrendo, egli è chiaro che se il compositore saprà donare alle parti che suonano cotali intervalli, un muovimento che s’accordi col numero e colla natura delle vibrazioni loro, il risultato del suono sarà più vigoroso, perché composto dall’unione di tutti gli elementi che lo compongono, e l’effetto indi prodotto sarà più confaccente alle leggi dell’armonia, e per conseguenza più musicale.
[14] La seconda è quella ridondanza eccessiva di accordi, quel pleonasmo, a così dire, di sensazioni con cui si vorrebbe accompagnar le parole, onde invece di rinvigorir l’espressione, altro non sì fa che indebolire l’effetto, poiché, siccome s’accennò nell’antecedente capitolo, la simplicità che richiede la musica vocale ad ottener il suo intento, viene distrutta dall’apparato armonico che esige la strumentale, la quale, essendo imperfetta nella sua imitazione, debbe ricompensare cotal mancanza coll’artifizio dando all’orecchio tutto ciò che non può concedere al cuore. Come fanno appunto quelle donne, le quali, veggendo dalle ingiurie del tempo sfrondarsi a poco a poco sulle loro guancie le fresche rose e vivaci che rallumavano i desideri dell’amante, cercano pure nelle studiate maniere e nella licenza de’ voluttuosi atteggiamenti un riparo al successivo mancare delle loro attrattive.
[15] La terza è quella smania d’introdurre dappertutto l’uso degli stromenti separati dal canto, e principalmente nei ritornelli. Per cosa del mondo non si leverebbe dal capo ai maestri l’usanza di premettere a qualunque aria la sua piccola sinfonia o concertino. Facendo altrimenti crederebbonsi banditi dal consorzio degli uomini, e scaduti per sempre dalla protezione del nume, che presiede ai musicali piaceri. Ma, s’avessero eglino ricavati i principi dell’arte loro non da una sciocca e ridicola usanza, ma dagl’intimi fonti della filosofia, si sariano agevolmente avveduti che se bene convenga talvolta far precedere il ritornello, non perciò sempre e in ogni occasione diventa opportuno. Quel proemio musicale maneggiato a capriccio introduce fra l’aria e il recitativo un divario troppo marcato e conseguentemente troppo contrario alla illusione. Lo spettatore non può a meno di non riconoscere l’inganno, sentendo il cantante che rallenta all’improviso il corso della passione, che sospende e tronca il pendio naturale del periodo per dar luogo agli strumenti; dovechè il sano giudizio vorrebbe che il passaggio dal recitativo all’aria fosse naturalissimo e pressoché insensibile. La famosa legge di continuità cui il famoso Boscovich applicò sì felicemente alla fisica, è non meno riferibile alle produzioni dell’arte che a quelle della natura. Che si direbbe d’un cotale che, camminando lentamente per via, si mettesse ad un tratto a spiccar salti e cavriuole? Ognun crederebbe che il povero galantuomo uscito fosse di senno. Ora tali sembrano a me que’ maestri, che senza consultar prima il buon senso, senza la debita graduazione e preparamento fanno all’improviso passaggio da un recitativo andante e negletto ad una sinfonia in forma. Cotal usanza non può rendersi opportuna se non quando serva a mantenere o spiegare i muovimenti che lascia nell’anima la passione o sentimento compreso nel recitativo. Attalchè la sinfonia non sempre dovrebbe essere un preambolo dell’aria, ma deve e può essere talvolta una continuazione o conseguenza del senso anteriore. E quando pur si riferisca alle parole che vengono doppo, non dovrebbe premettersi fuorché nel caso che l’aria o per esser lirica, o per non trovarsi intimamente innestata col senso del recitativo, o per comprendere un movimento inaspettato, o perché esprime la via tenuta dall’intelletto, o dalla passione da una riflessione in un’altra differente, ha bisogno di esposizione preliminare. Ma perché premetterlo a tante arie piene d’affetto, le quali hanno stretta relazione col senso anteriore? Perché frapporlo quando il differire sarebbe inopportuno attesa la natura della passione? Perché non entrar subito in materia senza far pompa d’armonia inutile?
[16] La quarta osservazione, che può in qualche modo riferirsi all’antecedente, riguarda l’apertura onde si dà incominciamento al dramma. Non già ch’io non lodi l’usanza di suonar gli strumenti avanti che sortano i personaggi, la quale mi sembra necessaria non che opportuna a sedar il confuso mormorio degli uditori, a svegliar la loro attenzione, e a preparar gli animi al silenzio ed alla compostezza. Condanno bensì che i maestri non abbiano cavato da siffatto principio tutti i vantaggi che ne potevano e che riflettuto non abbiano qualmente la sinfonia preliminare, oltre l’eccitar la curiosità dell’udienza, ha per iscopo eziandio l’esporre come in breve argomento l’indole dell’affetto che regnerà nella prima scena. Dico nella prima scena, giacché non saprei convenire col conte , il quale è d’avviso che l’apertura esser debba una espressione o compendio di tutto il dramma. Bisogna aver filosofato assai poco sulla natura della musica per non avvedersene che cotal sinopsi od epitome musicale diviene in pratica pressoché impossibile ad eseguirsi, attesa l’indole vaga e indeterminata del linguaggio strumentale, che non può e non sa individuare alcun oggetto, e la difficoltà parimenti di accozzar insieme senza distruggerli altrettanti movimenti diversi e forse contrari quanti sono i sentimenti che risultano dal totale d’un dramma. E ciò nel breve spazio d’un quarto d’ora che a fatica s’impiega nell’apertura. Se difficilmente si fanno intendere i musici ne’ ritornelli, i quali sono l’esposizione d’un’aria sola, ci sarà da sperare che riescano più chiari ed intelligibili nella esposizione di trenta e forse più scene? E se fa di mestieri che l’uditore dopo aver sentita la sinfonia aspetti pur anco le parole per sapere che quella che giace colà svenuta sul sasso, è la fedele Aristea che il giovane che le sta al fianco tutto smarrito e piangente, è il generoso Megacle, che il personaggio che sopragiunge inopportuno è Licida, che le ridenti e deliziose campagne che appariscono in lontananza sono quelle di Elide, e che i flutti, che vede luccicare tremoli e cristallini, sono le acque del fiume Alfeo, come potrà egli lusingarsi giammai di capire distintamente in un’apertura i diversi generi d’affetto, che debbono spiccare ne’ tanti avvenimenti, che s’affollano, s’incalzano, e con tanta rapidità si succedono nell’Olimpiade? Di più, questo metodo condurrebbe ben tosto la musica teatrale ad una sgradevole monotonia, poiché, avendosi a rendere la passione che domina per tutto il dramma, l’uditore sarebbe costretto a sentire fin da principio quel gener medesimo d’armonia, che gli toccherà poi in sorte d’ascoltare sì lungo tempo, e che dee per conseguenza essere dal compositore sobriamente dispensato affine di non cadere nel vizio distruggitore d’ogni più squisito piacere qual è la sazietà. Ma o comprenda la sinfonia l’intiera azione, o si ristringa ad una sola scena, certo è che nell’uno e nell’altro caso dovrebbe variarsi secondo che varia l’argomento, essendo diverso il suono che mi dispone a vedere i trionfi d’Achille, da quello, che mi prepara a sentire le amorose smanie d’Issipile, quello che mi dee strappare le lagrime per l’abbandono di Costanza nell’isola disabitata da quello, che m’indicherà le frodi del figliuolo di Venere nell’asilo d’Amore. Ma non così addiviene in pratica, poiché a riserba di alcune lavorate da maestri bravi la maggior parte delle aperture, che si sentono tutte ad una foggia e d’un carattere, sono appunto come quelle lettere che dagl’imperiti segretari si riducono ad una sola formola ricavata da qualche libro, o come gli autori del Cinquecento, i quali tutti sospiravano alla platonica perché talmente avea sospirato due secoli prima il .
[17] La quinta conseguenza è relativa al non osservarsi dai maestri colla dovuta accuratezza lo scambievole rapporto degli strumenti fra loro, e colla natura dell’oggetto cui devono rappresentare. , nelle parole
«E fa co’ suoi ruggitiLe selve risuonar»,
ha fatto ruggire il suo leone al suono di flauti obbligati. Un altro maestro napolitano espresse il fracasso d’una tempesta con una sinfonia di bicchieri. Niente in oggi di più comune che il mischiare degli strumenti, l’azione dei quali si distrugge a vicenda. I flauti, per esempio, il cui suono dolce e grazioso non dovrebbe servire che ad esprimere il soliloqio d’Amarilli, la dichiarazione d’amore di Mirtillo, l’addio di Cleonice, e in generale le affezioni amorose e soavi, s’accoppia nell’aria stessa col suono pieno e guerresco delle trombe con cui si dovrebbono rendere le battaglie e i trionfi. La dolcezza dei primi non può far a meno che non nuoca (come avviene sovente) alla fierezza delle seconde, e non vi si avrebbono ad accoppiare insieme se non quando le parole presentano una situazione dove il marziale ardore vien temperato da qualche circostanza affettuosa ed allegra. Tale sarebbe il ritorno di Ezio fra gli applausi e l’allegrezza d’un popolo che si vede per mezzo di lui liberato dal timore di Attila. Tale la sinfonia militare che precede la venuta d’Alessandro non men superbo per la conquista dell’India che pel supposto amore di Cleofile.
[18] Si pecca altresì frequentemente nel voler vestire di copiosi accompagnamenti le arie, che da se stesse abbondano d’espressione; laddove il buon gusto insegnerebbe che quando le parole sono talmente esprimenti che bastano esse sole a generare l’effetto, gli accompagnamenti divengono non solo inopportuni, ma nemici della verità musicale. Altro non si richiederebbe in tal caso che metterli all’unisono, e far giuocare utilmente il basso.
[19] Un altro svantaggio ancora mi sembra proprio dell’odierna musica strumentale, ed è l’aver ristretto di soverchio il numero delle modificazioni sonore escludendo dalle orchestre più sorta di strumenti, che sarebbero acconci a produrre a rinvigorir l’espressione. ha sensatamente avvertito135 che da niuno strumento si possono cavare tanti vantaggi quanti dal violino, perché niun altro è così acconcio a render dei suoni analoghi a quelli degli altri strumenti. Suonato con forza imita il pieno delle trombe, suonato rimessamente e con qualche delicatezza esprime le sordine e i flauti, col suo pizzicato rende in qualche maniera, benché imperfettamente, il suono dell’arpa.
[20] Tutti gli strumenti che si percuotono coll’arco hanno più o meno la stessa proprietà derivante dalla diversa giacitura e tensione che ricevono le corde dai tasti fino al ponticello, e da questo fino alla cordiera. Ed ecco il perché gli strumenti da corda e da arco s’impiegano nella orchestra a preferenza degli altri, e servono come di fondamento all’armonia. Tuttavia siccome né cotesti strumenti, né quelli da fiato, che s’usano comunemente, bastano a soddisfare alla immensa varietà di suoni che può somministrare l’arte drammatica, così mi sembra che la nostra musica abbia con grave scapito rinunziato all’uso di non pochi strumenti, che a tempo e luogo adoperati farebbero un grandissimo effetto. Perché, per esempio, non ammettere un organo nella orchestra, che suonato in qualche occasione a solo, o fra gl’intervalli degli strumenti, o anche con un leggiero accompagnamento preparasse gli animi a sentir l’inno d’un ierarca ispirato, a vedere la tremenda apparizione d’un nume, o a qualche sentimento di religione sublime e profondo? Se così felicemente riesce nella musica sacra qual dubbio vi può essere che non riesca talvolta nella musica drammatica136? Perché non dar luogo più frequente alle violette, le quali non avendo il suono così acuto come i violini, né così grave come il basso, ma essendo intermedie tra quelli e questo, servirebbero ad unir fra loro con una certa continuità i suoni diversi, e sarebbero acconcie ad esprimere la tranquillità e la placidezza? Soprattutto non posso a meno di non isdegnarmi colle moderne orchestre qualora vi veggo sbandita l’arpa, quello strumento delizioso le cui lunghe corde dolcemente vibrate, il cui suono tenero, armonioso e flebile m’ha cento volte strappate dagli occhi le lagrime e gettato il mio spirito in una maniconia più soave di qualunque allegrezza. Io porto ferma opinione che un’aria patetica cantata sul teatro da una bella voce col solo accompagnamento d’un’arpa e d’un flauto farebbe sull’udienza una impressione vieppiù profonda che non è quella delle arie più rinomate che si sentono in oggi eseguite con tutto il brillante sfoggio dell’armonia. Così almeno sono costretto a pensare dietro alla propria esperienza, qualora l’inconcepibile magia dei suoni da me in altri tempi sentiti non debba ripetersi dall’amabile persona che percuoteva lo strumento, la quale rientrata troppo immaturamente ne’ regni della morte mi lasciò per ogni retaggio il dolore d’averla conosciuta così tardi, e la disperazione d’averla così tosto perduta.
[21] Se non che non sono questi i soli difetti che si commettono nelle moderne composizioni musicali. Ve ne ha di più sorta nella maniera d’eseguire i recitativi, intorno alla natura dei quali essendosi parlato in più luoghi di quest’opera, e dovendosi parlare in altri capitoli, non mi tratterrò per ora se non quanto basta per far vedere la poca cura che hanno i maestri di seguitar in essi la natura e il significato delle parole.
[22] Un massimo inconveniente del recitativo semplice italiano è quello d’essere troppo trascurato dai maestri, i quali contenti d’accompagnare di quando a quando la voce con un’arcata o circolazione del basso, lasciano poi il restante in balia del cantore. Da ciò ne deriva che or si rallenti or s’affretti sconciamente la pronunzia, che le parole perdano il loro effetto, e che non vi si scorga punto quella perenne e non mai interrotta continuità di declamazione, quel tuono musicale che dee modellarsi prima sulla spezie di canto suboscuro (come il chiama ) proprio del discorso familiare, e poi sull’arte della declamazione drammatica. Nasce questo vizio dal non volersi applicare i maestri al necessarissimo studio della declamazion teatrale, o, per dir meglio, nasce dal mancare in Italia quest’arte della declamazione, che non può germogliar né fiorire dove manca un teatro tragico ed un comico che valgano la pena d’essere frequentati. in Francia si faceva recitare i drammi di avanti di metterli in musica da un’eccellente attrice, e dalla voce di lei ne raccoglieva i tratti più decisivi. Il mai non mandava a le proprie composizioni senz’averle prima declamate privatamente, e segnati colla penna nel manoscritto i tuoni che meritavano d’essere rilevati. Tali esempi sono degni d’imitazione, come lo è ancora l’esempio dei prelodato , il quale per ovviare agl’inconvenienti testé accennati del recitativo semplice, ha usato nel Paride, nell’Orfeo, e nell’Alceste d’un piccolo accompagnamento di violini, con cui si vestono, a così dire, tutte le parole. Questo metodo praticato da maestri ignoranti può avere i suoi svantaggi, come sarebbe a dire di render troppo uniforme e monotono il linguaggio musicale nel dramma, d’avvicinar troppo il recitativo semplice all’obbligato, e di togliere il chiaroscuro e le mezze tinte necessarie nell’armonia dal paro che nella pittura; difetti dei quali forse non è andato esente in ogni sua parte lo stesso . Ma siccome l’utilità d’un ritrovato non dee misurarsi dall’abuso che se ne può fare da chi non sa acconciamente metterlo in opera, così vuolsi rendere la dovuta giustizia a quel gran maestro per aver saputo guidare con un tal mezzo la voce del cantore senza imprigionarla, e aggiugnere a quella parte così disprezzata del melodramma un interesse neppur sospettato dagli altri compositori.
[23] Rispetto ai recitativi obbligati se prendono a disaminarsi imparzialmente le carte musicali si troverà che rare volte si conserva in essi il vero loro carattere, ch’è quello d’essere una cosa di mezzo tra il tuono della declamazione ordinaria e quello della melodia. Rare volte s’imita dai maestri il naturale andamento della voce, e la lentezza o velocità ch’esigerebbe l’indole del discorso. Ora scorrono dove si dovrebbono fermare, ora si fermano dove dovrebbero scorrere. Istrumentano di troppo in alcuni sentimenti comuni, e lasciano inoperosa l’orchestra in più luoghi dove la musica strumentale dovrebbe supplire ai silenzi energici del cantore. Molti e singolari esempi degli indicati difetti si trovano nelle composizioni dei moderni maestri, ma basterà per confermazione del mio assunto rilevare alcuni tratti dalle opere d’un compositore in oggi rinomatissimo cioè di . Nel famoso recitativo d’Ermelinda nell’opera intitolata il Ricimero doppo le seguenti parole
«Mora: ma chi? Tolgan gli Dei, che imprima,Al genitor fataliPortentosi caratteri la figlia,»
il compositore ha posta una lunga mossa di violini e di viole accompagnati dall’oboè e dai corni, la quale separa con un frapposto intervallo di più battute l’accennate parole da queste altre:
«Mora dunque; ma chi? l’idolo mio».
[24] Ma cotesto intervallo non è egli fuori di luogo in quella
occasione? Non è egli vero ch’Ermelinda
costretta da Ricimero alla fatale alternativa di
segnar sovra un foglio la condanna di morte o del padre o dell’amante, non deve essere
indecisa quando pronunzia quelle parole «Tolgan gli dei ec.»
, le quali
esprimono un sentimento risoluto, cioè quello di non condannare il padre? E che dopo
tale risoluzione dee subito passare senza fermarsi alla conseguenza “Mora dunque”? Il
giuoco degli strumenti prima del “mora” è non per tanto un contrasenso dell’armonia, per
ischivarne il quale bisognerebbe posporre le note due parole dopo, cioè inanzi al “Ma
chi?” perché facendosi ivi manifestamente il passaggio da un movimento in un altro, cioè
dall’orrore che ispira ad Ermelinda l’idea di dover condannare un padre, a quello di
dover sagrificare l’amante, l’orchestra dee rappresentare altresì l’irresolutezza nata
dal contrasto di siffatte idee. Havvi un altro esempio dell’accennato difetto nello
stesso recitativo allorché in quelle parole:
«Se vè clemenza in Cieloperché non cade un fulmine, e risolveLa Reggia in fumo, e Ricimero in polve?»
il compositore frammette tra il “fulmine” e il “risolve” un silenzio nella voce per sedici semicrome, che non viene indicato in alcun modo dal senso delle parole.
[25] Facciamo ora passaggio all’economia ed esecuzione dell’aria. Questa spezie di componimento considerata dal poeta altro non è che un particolar sentimento compreso in una piccola canzonetta divisa in più strofi e fregiata di tutte le vaghezze della poesia. Considerata dal compositore essa è l’espressione d’una idea o pensier musicale, che si chiama comunemente motivo, nel quale, come su una gran tela, la musica si propone di pennelleggiare un qualche oggetto propostole dal poeta, prendendo dalla melodia il disegno, e il colorito dagli strumenti. Conseguentemente a siffatto carattere il motivo dee con tutta l’esattezza possibile corrispondere al senso delle parole acciocché il musico non mi dica una cosa allorché il poeta m’inculca un’altra; dee contenere un unico e solo pensiero, il quale venga poi di mano in mano sviluppandosi ne’ diversi toni che lo costituiscono, non altrimenti che soglia far l’oratore analizzando nel corpo della orazion sua la proposizione che n’è l’argomento; debbono i motivi subalterni riferirsi al primario, come le linee d’un circolo si riferiscono ad un centro comune, o come le idee semplici scomposte prima e divise si riuniscono poscia per formar una idea complessa; debbonsi in tal guisa subordinare fra loro i suoni, che l’unione dell’uno non nuoca punto anzi maggiormente rilevi l’effetto dell’altro, cercando di combinare per quanto sia possibile l’unità, che convince ed appaga lo spirito colla varietà che lo ricrea. Ha inoltre da cercare il compositore che il motivo d’un’aria abbia un carattere decisivo che lo distingua da ogni altro del medesimo genere; che le modulazioni, per esempio, ch’entrano nella composizione d’un soggetto patetico, non servano ai caprici ed alle irregolarità d’un argomento giocoso, l’espressione dell’allegrezza d’un coro di contadini a quella del tripudio delle baccanti, la gravità d’un ecclesiastico miserere ai cupi e dolorosi omei d’Alceste, o d’Admeto; che la misura che dà tanta mossa e vigore alla melodia, e gli accompagnamenti che ne aumentan l’effetto servano a far ispiccar il canto senz’alterarlo, e che né questi né quella si prendano la libertà di rappresentar cose staccate dal senso generale dell’aria, e che non abbiano immediata relazione colle parole, essendo certissimo che gli episodi fuori di luogo non sono meno ridicoli nella musica di quello che lo siano nella oratoria e nella poesia.
[26] Supposti gli accennati principi tanto più sicuri quanto che sono ricavati non da’ capricci dell’usanza né dalla particolare opinione di un qualche scrittore di musica, ma dai fonti inesauribili di quel vero comune a tutte le arti d’imitazione, qual’è la maniera osservata dagli odierni compositori nel lavorare le arie? Pensieri rancidi e vieti che si replicano mille volte e mille volte si sentono con fastidio delle orecchie, e con iscapito dell’interesse; motivi, a così dire, abbozzati senza finitura e senza carattere; idee buttate all’improvviso come vengono giù dalla penna, senza la lima che vien dallo studio, e senza la sensatezza che acquistano dalla riflessione; tratti raccolti qua e là nelle carte de’ viventi o de’ trapassati maestri combinati poi bizzarramente, onde ne risulta un ritratto che non ha fisonomia determinata; mosaici composti d’altrettante pietre di vario colore quanti sono i diversi stili, che sovente concorrono alla composizione dell’aria stessa; periodi musicali raccozzati insieme senza disegno a formar un soggetto che per lo più è in contraddizione con se medesimo e col tutto insieme del dramma; una fluidità insignificante di melodia che s’oppone alla robustezza e maestà dello stile, che restringe la musica a non trattare fuorché i rondò e le barcaruole, e che esprime la nobile tristezza d’Ezio o d’Achille col tuono proprio delle canzonette per ballo; i vezzi e le frascherie sostituite all’antica, e non mai pregiata abbastanza simplicità; il desiderio di grattar l’orecchio o di sorprender la fantasia con passaggi capricciosi, con arpeggi fuori di luogo, e con ambiziosi ornamenti; per dir tutto in poche parole il secolo del e del , che va succedendo nella musica dietro a quello dell’ e del , ecco il vero, il genuino, il per niun verso alterato quadro della presente musica teatrale in Italia.
[27] Questa verità dura ma incontrastabile, questo grido universale del buon senso e della filosofia, questo pubblico lamento della ragione replicato da quanti non hanno interesse in negarlo riceverà una maggiore conferma volendo discendere all’esame d’un’aria, qualunque ella sia, che serva d’esempio se non di tutte almeno della maggior parte di quelle che si cantano in oggi sui teatri.
[28] Aprasi per un poco una carta o spartito musicale, e vi s’osservi il metodo che comunemente si tiene nel lavorarle. Appena l’interlocutore ha finito il recitativo, gli strumenti cominciano una suonata o preludio chiamato ritornello. L’oggetto di questa piccola sinfonia è di ragguagliar gli uditori, agguisa di proemio, o preambolo, del sentimento generale che dee regnare nell’aria. Cessano gli stromenti, e la voce del cantore prende a cantar solo, e senza l’accompagnamento la prima parte dell’aria. Sia l’aria, per esempio, questa:
«Nel lasciarti, o Prence ingrato,Mi si spezza in seno il cor:Di morirti almeno al latoPerché a me tu nieghi ancor?Giusto Ciel, che acerbi affanni!Perché, oh Dio! tanto rigor?Deh! m’uccida, astri tiranni,Il mio barbaro dolor.»
vediamo come il compositore la spezza dappertutto e la smembra. S’incomincia dopo il primo verso a ripeter due vole “mi si spezza in seno il cor, si spezza in seno il cor”. Indi viene il terzo “Di mo….rirti al-me-no al” e doppo un lungo intervallo “lato perché a me tu nieghi an-cor?” Indi collo stesso tritume di note si ripiglian di nuovo i due primi versi “Nel lasciarti, o Prence ingrato mi si spezza in seno il cor”, impiegando qualche minuto in gorgheggiar su quel povero core. Crederemo che sia finita? Non per certo. Fa pausa il cantore, e gli stromenti riempiono l’intervallo replicando col suono i medesimi sentimenti del canto. E come se l’uditore non gli avesse intesi abbastanza, o si parlasse il linguaggio degli ottentoti, di cui la musica ne fosse il dizionario, bisogna che l’attore gliel’inculchi di nuovo ripigliando coll’ordin medesimo le parole. Però si tornano a replicare per molte volte quel “cor”, quel “seno”, e quel “lato” scorrendo or sù or giù per le note con gorgheggi velocissimi, e con mille semicrome. Cessa il canto, ma per questo siamo fuori d’impaccio? Oibò. La musica strumentale ricomincia a fine di dare alle parole tutta la varietà d’espressione ond’è suscettibile il sentimento finché termina la prima parte. E la seconda? Oh questa poi ha la medesima disgrazia che i cadetti delle famiglie illustri, ai quali tocca languire in ristrettezza di fortune mentre che il fratello maggiore vive fra il lusso e l’opulenza. Il suo destino è di essere rapidamente sbrigata con quattro note senza l’analisi, divisione, o repetizione dei periodi che si fa nella prima, se non in quanto fra le pause della voce l’orchestra porge di quando in quando aiuto al cantante. Se il lettore mi domanda la ragione di cotal diversità, io confesso di non saperla. Checché ne sia di ciò siamo pervenuti alla fine del nostro viaggio? Chi così credesse viverebbe in inganno. Questo non è che il primo ostello dove si rinfrancano i cavalli per ripigliare valorosamente la corsa. Il ritornello, il cantore, e la prima parte dell’aria cominciano di nuovo, e si replica due volte lo stesso andirivieni collo stesso apparato di note e di gorgheggi.
[29] Mi dica ora di grazia un compositore di buon gusto non prevenuto dai pregiudizi dell’usanza, o da quelli dell’arte, che gliene paia della esposta economia di quest’aria? A qual fine quelle fastidiosissime ripetizioni? A che giova quel tanto stritolarne i periodi sempre aggirandosi dintorno alle stesse parole? A che il ripigliar più volte i due primi versetti sospendendo, anzi troncando senza ragion sufficiente il senso delle parole? Si fa, diranno i maestri imperiti, per dar luogo all’armonia. Diasi pure. Ma hassi a dare in tutte le occasioni senza distinzione? Ad onta del verosimile? Contro a ciò che richiede l’indole della passione? Hassi a spezzar un periodo, il quale sovente non finisce fuorché nella seconda parte dell’aria, per ripeter la prima fino alla noia? Hassi a ritardare l’impeto dell’affetto ch’esigerebbe un isfogo ulteriore per fermarsi a bell’agio su un “a”, su un “i” o su un “o”? Hassi a star gorgheggiando un quarto d’ora su una cadenza per far capire all’udienza che lo smascolinato Arione è capace di eseguir venti battute di gorga in luogo di dieci? Ciò è a un dipresso lo stesso che dire che la natura è fatta per ubbidire alla musica, non la musica per imitar la natura.
[30] Io son ben lontano dal volere che l’ordin metodico delle
parole serva esattamente di regola al compositore, voglio anzi ch’ei raggiri il suo
pensiero, e a così dir, l’analizzi per entro alle differenti modulazioni che le
somministra il suo tono dominante senza la quale licenza non è facile, che l’espressione
musicale ottenga il suo intento siccome quella, la quale non apportando in ciascun suono
individuale se non se una sensazione troppo rapida e fugace, non può avere il suo
effetto in un solo istante; perlochè volendo imprimer nella memoria traccie distinte e
durevoli della sua possanza, ha bisogno d’esser condotta per più modulazioni differenti.
né m’è ignoto altresì che il costume di replicar talvolta una parola o una frase può
avere il suo fondamento nella ragione, e che ciò ha luogo principalmente allora quando
l’uomo stimolato da una viva passione, e ripieno di quella idea che serve ad
eccitargliela, altro non rivolge in mente fuorché l’oggetto de’ suoi trasporti o de’
suoi tormenti. La quale proprietà, volendo per poco inoltrarsi nell’abisso della
sensibilità umana, sembra forse che debba ritrarsi da una persuasione intima che l’amor
proprio fa nascere in noi, che se gli uomini, i numi, od il destino non rendono
giustizia alla nostra causa, e non ascoltano con benignità e conmiserazione le nostre
richieste, il motivo ne sia perché non hanno inteso abbastanza le nostre ragioni, e
perché a lor non è noto quanto sarebbe di mestieri il nostro cordoglio. Così una tenera
madre disperata per la morte del figliuolo, ch’era l’unico oggetto delle sue tenerezze,
si sente fra i singhiozzi che le offuscan la voce fra le lagrime che le inondano il
sembiante, fra gli amplessi onde si stringe al seno il freddo cadavere, ripiegarsi
frequentemente sul suo dolore ritornando ad ogni momento alle medesime imagini, alla
medesima espressione e alle doglianze stesse. Così nell’Avaro di
allorché arriva a notizia
d’Arpagone che gli è stata rubbata dal proprio figlio la
cassettina dove nascosto avea egli i suoi preziosi danari, s’ode gridare da forsennato
per la scena: «Helas! Mon pauvre argent, mon pauvre argent,… ah mon cher
argent»
. Così nel secondo libro dell’Eneide, Anchise, che fuggendo da Troia incendiata in compagnia
d’Enea, di Creusa, e d’Ascanio, vede
lampeggiar in lontananza le armature dei nemici che l’inseguiscono, esclama mosso dalla
paura:
«… nate, fuge, nate; propinquant».
[31] In queste e simili occasioni dove la natura dell’affetto lo
richiede e la poesia lo comporta va bene il replicar coll’armonia alcuni tratti
dell’aria, come ha fatto da gran maestro il celebre nel «che farò senza Euridice?»
dell’Orfeo, dove il protagonista, essendo stato per un improvviso e
crudele accidente privato della compagnia d’una sposa cui tanto amava, è assai
verosimile che vada egli sfogando da sé solo il proprio cordoglio, e ripetendo ai boschi
più volte il nome d’Euridice; ma il farlo senza
discernimento in ogni circostanza è secondo il mio avviso non meno contrario al buon
senso che all’ottimo gusto, poiché siffatte repliche non si debbono considerare se non
come altrettante battologie della sintassi musicale.
[32] Ma ciò che non è conforme alla natura né alla ragione si è
la ridicola usanza di quel da capo solito a mettersi nel fine delle
arie. Senza l’abitudine che fa loro chiuder gli occhi su tante improprietà, gl’Italiani
avrebber dovuto riflettere che niuna cosa fa tanto chiaramente vedere la poca filosofia
colla quale vengono regolati di qua dai monti gli spettacoli quanta questa: che il
carattere della passione non è mai quello di riandar se medesima metodicamente, né
d’interrompere la sua impetuosità naturale per fermarsi a ripigliar con ordine la stessa
serie di movimenti; che il distaccare dal tutto insieme d’un’azione uno squarcio per
recitarlo di nuovo è dissonanza non minore di quella che sarebbe in un ambasciatore il
ripeter due volte in presenza del sovrano l’esordio d’un’allocuzione; che il carattere
della musica non può legitimare cotesto abuso, giacché si può variare benissimo e
rinvigorir l’espressione senza ricantar di nuovo il motivo; e che uno spartito dove si
vegga appiccato al margine un da capo è ugualmente difforme agli occhi della sana
ragione che sarebbe agli occhi d’un naturalista un braccio con due mani, oppure un
animale che avesse un paio di nasi sulla faccia. Mi si risponderà (e a che non
rispondono i maestri?) che la colpa non è di loro, ma degli ascoltanti che chiedono con
furore la replica. Ma gli ascoltanti non la chiederebbero con tanta smania, se il
compositore avesse l’arte d’interessarli nel soggetto principale, e se l’andamento
dell’azion musicale fosse così unito e concatenato che la curiosità dell’udienza venisse
ognor più sollecitata a risaperne lo scioglimento, come si vede da ciò che giammai si
domanda in una commedia di carattere, o in una tragedia la replica d’una scena per
quanto sia ella sublime, forte, o patetica, e per quanto venga dagli attori
maestrevolmente rappresentata. Gli antichi maestri avevano pure anch’essi un’udienza da
contentare, ma cotale assurdità non si trova ne’ loro grammi, la quale era riserbata
alla svogliatezza, al fastidio e alla corruzione del moderno gusto. Nelle carte musicali
non apparisce vestigio del da capo se non verso la fine del secolo
scorso. Il primo ad introdurlo sembra essere stato il cantore Baldassarre Ferri perugino, come si può argomentare
dalla prefazione d’una raccolta di poesie a lui dedicata, ove nello stile ampolloso di
quei secolo si dice, parlando di non so quale cantilena: «Che il popolo
sopraffatto da vostri sovrumani concenti, guardandovi qual novello portentoso
Orfeo della età nostra, vi sentì replicar
più volte sulle nostre scene rimbombanti coi vostri applausi ed inaffiata coi torrenti
dell’armonia vostra dolcissima.»
[33] Bisognerebbe render grazie al per essere stato (a quello che sento da alcuni) il primo a
sbandirne i noiosi da capo sostituendovi le arie lavorate a rondò, del
che ne diede egli per la prima volta un plausibile esempio nel «Dov’è? s’affretti
per me la morte»
, se da cotai usanza non fossero venuti altri danni egualmente
grandi alla musica drammatica quello cioè di repetere mille volte le stesse parole
invece di replicar l’intiero motivo, e quello altresì di ridurre la musica ad una
sgradevole uniformità, altro per lo più non sentendosi in oggi che arie intrecciate e
ridotte a rondò. Così si passa da un vizio all’altro, e la pretesa perfezione che,
secondo i moderni, acquista di mano in mano la musica, consiste nel distruggere un
difetto per impiantarvi un maggiore. Il peggio si è che un tal costume è passato ancora
dal teatro in chiesa degradando con siffatta puerilità l’augusto e maestoso contegno
della religione. Una volta il padre eterno si contentava di dire al suo unigenito
figliuolo «sede a dexteris meis»
, in tuono grave e posato i ora glielo
canta a rondò, e gli ardenti cherubini si cuoprono rispettosamente il viso colle ali
mentre il creatore dell’universo va ripetendo cento volte alla francese «sede,
sede, sede, sede, a dextris, a dextris, sede a dextris, sede a dextris»
.
[34] Alcuni giudicano che potrebbe ovviarsi al difetto del soverchio ripeter le stesse parole lavorando le arie in maniera che contenessero quattro o cinque strofi invece di due; così, dicono essi, l’uditore, che si diletta di sentir cantare, resterebbe appagato senza scapito del buon senso, e il cantore che altro non cerca se non di far brillare la sua voce, otterrebbe il suo intento senza recar oltraggio alla poesia. Ma oltrachè non si reciderebbe in questa guisa la radice del male, la quale non consiste nella scarsezza delle parole, ma nella smania che ha il cantore di condurre la sua voce per tutti i tuoni possibili, mi sembra che si caderebbe in difetti non minori di quello cui si cerca di schivare. Il motivo si è perché essendo troppo difficile il comprendere in tante strofi un unico pensier musicale, ne verrebbe in conseguenza che non vi si potrebbe nemmeno accomodar un solo motivo; ciascun periodo formando classe a parte nel sentimento ne richiederebbe una particolar cantilena, onde non sussisterebbe più la legge fondamentale stabilita di sopra, cioè l’unità di soggetto e di melodia. Questa usanza inoltre non potrebbe aver luogo fuorché nelle arie giocose, le quali, rappresentando caratteri poco profondi, e che rimangono, a così dire, nella superficie dell’anima, non abbisognano se non se di musica brillante e leggiera che scorra senza fermarsi a lungo sugl’individuali sentimenti; dovechè nelle arie tragiche e di forza, le quali aprono larga sorgente di espressione alla melodia, convien che il poeta divenga economo di parole, acciocché la musica, percorrendo i moltiplici tuoni che il suo argomento le somministra, faccia meglio valere la sua possanza.
[35] Che diremo del poco riguardo che si ha da maestri dozzinali per le convenienze della poesia? Alle volte la scena costerà di venticinque versi perché altrettanti vi vogliono per bene esprimere il sentimento, e di questi venticinque il compositore ne mutila dieci. Se il senso rimane imperfetto poco gli cale; basta che non si generi fastidio al cantante, e che si facciano sui quindici versi le stesse sfoggiature che si farebbero sui venticinque. Alle volte cangian l’ordine delle strofi mettendo in primo luogo quella ch’era seconda, e nel secondo la prima, ovvero levano via del tutto l’altra parte dell’aria senza punto badare alla proposizione che resta smozzata all’esempio di quei quadri che rappresentano le figure soltanto a mezzo busto. Alle volte un comando decisivo del principe, un affare di congiura, o qualche altra urgenza di sommo rilievo, richiamerà altrove l’attore, ma egli non partirà a motivo che il compositore lo trattiene mezz’ora in sulla scena dicendo “parto parto” e non partendo giammai. Alle volte due campioni incolleriti saranno sul punto di battersi, ma la musica gli tratterà un quarto d’ora colla mano sull’elsa minacciandosi colla più bella melodia del mondo. La sconcezza in questo genere è arrivata a segno che in un’opera veduta da me dovendo salir sopra un naviglio il primo uomo e cantar prima una cavatina, la nave, che veniva spinta dalle onde, ha dovuto fermarsi, come s’avesse udito e cognizione, attendendo che finissero que’ noiosi arzigogoli. Peggio poi quando fanno dei solecismi in armonia esprimendo colla musica un senso intieramente contrario a quello che dicono le parole. Diranno queste “Raggio del cielo è la bellezza”, e il compositore vi metterà “La bellezza del cielo è un raggio”. , rinomatissimo fra i maestri, ha nel dramma intitolato I tre amanti ridicoli posto sotto i due versi seguenti
«Oh che rabbia, o che furore!Io mi sento lacerar.»
un tempo di minuetto ballabile. Poffare Iddio! Il furore e la rabbia in un tempo di minuetto da ballo! Altro non gli restava che riserbar il tuono del Miserere per una contradanza.
[36] Alle volte si scontrerà il compositore in nomi propri o appellativi in avverbi, o in parole che non hanno espression musicale per se medesime, come sono per esempio “arena”, “regno”, “padre”, “senza”, “fronde” ed altre simili, e su queste lavorerà un lungo passaggio facendo dir al musico “areeee”, “reeee”, “paaaaa”, “seeee”, “froooo”, ec. laddove la filosofia della musica insegnerebbe che i passaggi non si debbono comporre fuorché su parole significanti alcun movimento progressivo, o ch’esprimono un determinato genere di passione. Difatti cosa è un passaggio? Non altro che una breve dimora della voce su una qualche vocale, dove il canto aggrumola insieme un numero di picciole note succedentisi con grazia e leggierezza. Ora cotal ornamento non può rendersi verosimile fuorché nel caso che il replicar le note serva ad imitar la natura dell’oggetto rappresentato, come si farebbe nelle parole “scorrere”, “tremolare”, “volare”, che suppongono un’azione successiva, ovvero in queste altre “affanno”, “smania”, “cordoglio” e simili, nelle quali esprimendosi la natura con un accento più vivo e più calcato, anche la melodia ritrova maggior novero d’inflessioni decisive da poter connettere insieme nella sua imitazione.
[37] Che si dovrà pensare eziandio dello strapazzar che fanno miseramente l’espressione fermandosi soltanto nelle parole individuali che si trovano per accidente nella composizione, e tralasciando, anzi sfigurando con questo mezzo il sentimento generale dell’aria? Esprimerà questa, per esempio, un affetto concitato e veemente, ma scontrandosi talvolta nelle parole “calma”, o “riposo”, il maestro si ferma a collocar posatamente una tenue benché sia di movimento contrario e ripugnante a tutto il resto. Nella stessa guisa si veggono essi sommamente affaccendati nel rappresentare con suoni alti la parola “cielo”, con bassi la “terra” o l’“inferno”, con suoni cupi la parola “buio”, le precipitano “sul fulmine”, l’incalzano sul “tuono”, e fanno quindici o venti slanci di voce qualora il leone che errando vada per la natia contrada, o l’orsa nel sen piagata, o la serpe ch’è al suol calcata, o la tigre delle foreste ircane, ovvero qualche spaventevole mostro di simil razza si scaglia in un’arietta contro allo smarrito personaggio. Se gli ornamenti ch’essi appiccano a quelle parole rallentano ad un tratto l’energia della musica, o ne cancellano l’effetto generale del motivo, se l’orditura dell’aria esigerebbe che si scorresse di lungo sui movimenti particolari e subalterni per meglio esprimere la passion dominante, se quei ridicoli deviamenti dall’oggetto principale invece di fissar, come si dovrebbe, l’attenzione dell’uditore ad un punto solo, altro non fanno che miseramente distrarnela; ciò nulla importa al compositore. Per essi il fior del bello è riposto nel far capire che sanno l’armonia; alla qual notizia arrivandosi più presto con siffatto metodo che con quello di esaminare l’intiera orditura musicale d’un dramma, o di sviluppar lentamente la relazione e convenienza de’ suoni individui col tutto insieme d’un’aria, non è maraviglia che prendano in ciascun vocabolo occasione di fermarsi a dar mostra dell’abilità loro con cose affatto disparate, o almeno estranee al soggetto. Quindi è che il volgo de’ compositori allora si delizia sopra ogni modo quando trova nei versi del poeta replicate le parole “caro anima mia” dove possano fare una qualche smanceria, oppure quelle piccole immagini del fiume che mormora, dello zeffiro che tremola, del gorgeggiante augellino, dell’eco che ripete, del fragore del tuono, del turbo nereggiante con siffatte anticaglie, che sono (quasi direi) venute a nausea per la loro frequenza. , che pur non è fra cotesto volgo, non ha avuto difficoltà d’impiegare nove battute e mezza (le quali a sedici note per battuta rendono il numero di cento cinquantadue note effettive) sulla seconda vocale della parola “amato” nell’aria “Contro il destin che freme” dell’Antigono. E ciò per due volte consecutive. Gran Dio! Cento e cinquantadue, anzi trecento e quattro inflessioni per una sola vocale! E questa si chiama musica drammatica!
[38] Un altro sommo difetto degli odierni maestri quello è di poco o nulla studiare l’accento patetico della lingua, che serve di fondamento alla musica imitativa, cioè i tuoni individuali di ciascuna passione. Avvegnaché tutte l’affezioni dell’uomo non siano che altrettante modificazioni della fisica sensibilità, e che a siffatto riguardo esse non parlino che un solo linguaggio cioè quello del piacere o del dolore; tuttavia nella maniera d’esprimer l’uno e l’altro ciascuna si crea un particolare idioma composto d’inflessioni e d’accenti diversi da quello d’ogni altra. Si tratta, per esempio, d’una disgrazia accaduta all’improvviso ad una persona amabile, come sarebbe a dire di consolare un tenero padre per la morte del suo unico figliuolo? Molti ne avranno rincrescimento, ma nell’atto di condolersi con esso lui ciascuno prenderà un tuono di voce ed un gesto proporzionato al proprio carattere e al grado d’interesse che si piglia nell’infausto avvenimento. L’uomo prudente ma freddo gli metterà posatamente avanti agli occhi le avversità cui va soggetta l’umana vita, e la necessità di rassegnarvisi. L’uomo austero ma sensibile mischierà alle significazioni del suo dispiacere pel male accaduto i rimproveri sulla imprudenza di chi non seppe sfuggirlo. La malignità farà vedere un non so qual tuono d’ironia che indicherà la segreta compiacenza che ha del danno altrui. La politezza si contenterà d’espressioni generali che dinotino un qualche rammarico. L’amicizia farà sentire il linguaggio della tenerezza, s’asterrà d’ogni motto che possa inacerbire la sua doglia, accompagnerà talvolta con una lagrima fuggitiva le lagrime dello sventurato amico. L’amore… ah! per l’amore non v’ha che il velo di Timante, o l’impietrimento d’Othello.
[39] Dalla fedele rappresentazione di questi diversi idiomi che non può eseguirsi se non da chi si è molto avanti inoltrato nella cognizione degli uomini, nasce ciò che s’appella in musica “espressione”, la quale non è altro che l’imitazione abbellita d’un sentimento determinato. Ora siccome questo sentimento non viene somministrato alla musica se non dalla poesia, così la vera espressione musicale nella drammatica non è né può essere che l’esatta imitazione della imagine, passione o sentimento compreso nelle parole. Queste due cose hanno una così stretta relazione fra loro che la musica fatta sulle parole d’un’aria non potrebbe senza guastarsi essere trasferita alle parole d’un’aria diversa; come il ritratto che rappresenta con esattezza una fisonomia, non può servire a rappresentare una fisonomia differente da quella.
[40] Rivolgendo le composizioni del , del , e del , e disaminando il Se cerca, se dice del primo, il Misero pargoletto del secondo, il monologo di Didone moribonda del terzo, io trovo ch’eglino hanno talmente meditato sovra i principi pur ora esposti, hanno saputo afferrare in maniera lo spirito delle parole che chiunque volesse o cambiar le arie loro o accomodar il motivo, gli accompagnamenti e l’espressione totale ad un’altra poesia non farebbe che distrugger affatto la loro verità musicale. E questo è appunto il segno più decisivo della loro eccellenza.
[41] Ma i moderni compositori hanno nemmen rivolto il pensiero a siffatta massima ch’è il cardine dell’unione fra la musica e la poesia? Hanno neppur sognato a modulare le arie secondo il vero e preciso accento delle individuali passioni? Intendono essi nemmeno in che consista l’espressione poetica? Basta gettar uno sguardo sulle carte loro per chiarirsene ad evidenza di tutto il contrario. Tanto sono lontani dal comprendere il linguaggio individuale di ciascun affetto che non conoscon neppure i gradi specifici che gli distinguono. Lo stesso motivo che serve di fondamento ad un’aria d’amore viene da loro impiegato per significare la benivolenza, la divozione, la pietà e l’amicizia, passioni fra loro cotanto differenti. Il sospetto crudele, l’agitazione, la gelosia, il rimorso sono rappresentati ad una foggia medesima. Lo sdegno non si distingue dalla disperazione, né questa dal terrore, e così via discorrendo. Quindi è che qualora si cavino le parole dallo spartito, la composizione da sé sola non offre per lo più veruna rassomiglianza, verun linguaggio intelligibile per chi che sia. E quindi viene altresì la facilità che trovano i moderni compositori di cambiar le loro composizioni adattandole a cento sentimenti diversi.
[42] Ma che parlo io di sentimenti diversi? Poche sono le arie musicali moderne, alle quali (restando la composizione qual era) non possono adattarsi parole di sentimento perfettamente contrario. Si scuotono i fautori della moderna musica a così ardita asserzione? Agrottano forse le ciglia i compositori? Ebbene: vengasi alla esperienza ch’è il divino scudo di Pallade inanzi a cui impietriscono il fanatismo, la prevenzione e la pedanteria.
[43] , compositore stimabile ed accreditato, ha lavorata un’aria137 su quelle parole dell’Adriano in Siria
«Già presso al termineDe’ suoi martiri,Fugge quest’animaSciolta in sospiriSul volto amabileDel caro ben.»
nelle quali avendo voluto il poeta esprimere il giubbilo d’un appassionato sposo sul punto di rivedere dopo lungo tempo e dopo una travagliata fortuna la sua amatissima sposa, egli è chiaro che il compositore avrebbe dovuto seguitar l’espressione delle parole rappresentando in maniera siffatto giubbilo che, volendo ancora cambiar la composizione questa non potesse applicarsi giammai fuorché all’espressione dell’allegrezza. Piacemi per ora di fare una supposizione contraria e di figurarmi Farnaspe che inebbriato da quel nettare inconcepibile cui l’amore fa gustare alla presenza, e in compagnia dell’oggetto che s’ama, fosse pur costretto a distaccarsi improvisamente dal fianco d’Emirena per abbandonarsi alla incertezza del proprio destino, lasciando la sua sposa in balia d’un rivale odiato e potente che si prenderebbe il barbaro piacere di tormentarla. Voglio supporre altresì che le parole con cui Farnaspe esporrebbe la crucciosa sua situazione fossero per esempio le seguenti:
«Vicina al termineDe’ suoi contentiPiange quest’animaFra pene e stentiL’inesorabileSuo fier destin.»
ora io dico che la musica dell’ applicata a quest’ultima strofe, la quale, come ognun vede, comprende un sentimento diametralmente opposto al sentimento delle prime parole, farebbe appuntino il medesimo effetto. La cagione si è perché i tratti musicali apposti all’aria di sono così indeterminati, così generici, così malamente connessi colla declamazion naturale di quelle parole, che facilmente ponno rivoltarsi a qualunque altro significato. Per rendere più chiara e più palpabile la demostrazione, io voglio aggiugnere alla poetica parodia testé arreccata una strofetta in lingua francese, che nulla ha di comune né coi senso dell’aria di , né con quello della mia. Eccola:
«Mes tourments sont finis,je vais revoir Ismene:Sans doute un dieu puissantEn ces lieux l’amène:Mon cœur libre de soucisVole sur ses pas.»
poste tutte tre sotto le stesse note la musica va egualmente bene, come il lettore può chiarirsene da sé dando una occhiata alla carta musicale che si trova infine di questo volume, dove osserverà la sinfonia preliminare che non ha verun carattere decisivo, il motivo che rende la malinconia dal paro che il giubbilo, il
«Vicina al termineDe suoi contenti»
espresso nella stessa guisa che il “già presso al termine de’ suoi martiri”, il “piange” come il “fugge”, il sentimento francese “un dieu puissant en ces lieux l’amene” non altrimenti che il “quest’anima sciolta in sospiri”, l’epiteto “inesorabile” colla melodia medesima che l’“amabile”, e il “caro bene” convertito in un “fiero destino”. E ciò conservando fedelmente il suo bel tempo in largo, il movimento, e gli accompagnamenti.
[44] Non si ritrova pertanto nell’odierna musica teatrale quello scopo, quel fine ultimato, quell’unità di espressione e di soggetto cui dovrebbe riferirsi nella musica ogni cosa, come tutto si riferisce all’unità di azione nella tragedia. Sembra che i compositori vogliano metter dal paro le composizioni con quelle pitture cinesi prive d’imitazioni e di disegno e stimabili solo per la vivacità del colorito, e che dimenticandosi affatto della meta principale, corrano dietro a infrascare la musica e a lusingar inettamente l’orecchio. Hanno essi delle cose eccellenti in dettaglio, i loro diversi stili abbondano di tratti vivi, animati e piccanti, superiori a quanto in quel genere ci offrono gli oltramontani, ma sono tratti staccati cui manca la primaria bellezza che consiste nella esatta relazione colle parole e col tutto. E questo perché? Per mancanza di studio e di riflessione, per mantenere i pregiudizi che hanno ormai acquistato forza di legge, perché vogliono ridurre a due o tre dozzine di esempi tutte l’arie d’indole e di carattere affatto diverso, facendo come il celebre frate Gerundio138, il quale trovava nella storia di Taltoc, idolo ridicolo degli antichi Messicani, tutta l’applicazione per la predica dei Corpus Domini, pe’ i suoi parenti ed amici, e per la processione de’ flagellanti che si faceva in Campazas, sua patria. Insomma perché imparano la musica da pedanti e non da filosofi.
[45] E non è maraviglia che così avvenga, se si pone mente al cattivo metodo con cui s’insegna in Italia ai maestri cotal genere di studi. Fra tutti i rami della educazion letteraria non avvi il più trascurato di questo. Si crede aver addottrinato abbastanza un giovine quando egli ha imparata sul cembalo l’arte di concertare le parti, di ritrovare gli accordi, di preparare, di risolvere, di combinare in varie guise le note.
[46] Ma da siffatte cose fino a quelle che dee sapere un compositore corre una distanza infinita. Questi ammaestramenti non contengono se non la sintassi, a così dire, o la grammatica della musica, e servono piuttosto a non commettere degli errori che a produrne delle vere bellezze. Si può chiamare la scuola del diesis e del bemolle, delle massime e delle lunghe, delle crome e delle biscrome anzi che quella della vera eloquenza musicale. Non s’insegna loro la rettorica dell’arte, quella cioè che sollevando l’ingegno sopra la meccanica disposizion delle note analizza, comprende ed abbraccia tutto l’argomento d’un’azion musicale, dando le regole opportune per lavorare l’apertura, dirigendo la fantasia nella invenzione del motivo principale, il quale dee corrispondere al tuono che domina nella poesia, additando i mezzi per ben disporne i motivi subalterni che si scelgono secondo l’indole di ciascuna scena in particolare, indicando i diversi stili che sono nella musica corrispondenti a quelli della prosa e del verso, mostrando quali figure o tropi servano a lumeggiar l’idioma dell’armonia, quando si debbono tralasciare e in quali occasioni debbano adoperarsi. Non s’insegna loro la fisica propria del mestiere che consisterebbe nello studio dell’acustica, ossia nello esame di quei rapporti che la risonanza dei corpi sonori ha colla macchina umana, e in particolare col nostro orecchio, quantunque sia fuor d’ogni dubbio che tali notizie gioverebber moltissimo alla perfezione e maggior finezza dell’arte. Non s’insegnan loro quei rami di filosofia applicabili all’uffizio del compositore, cioè la scienza dell’uomo sensibile, la cognizione delle umane passioni e dei loro sintomi, l’indole e varietà dei loro movimenti secondo i rispettivi caratteri e le situazioni diverse, quali accenti, quali inflessioni, quai toni di voce convengono a ciascun affetto, onde esprimer poscia col mezzo de’ suoni ora quei tratti caratteristici che manifestano al primo colpo d’occhio la natura in tumulto, ora quelle sfumature più delicate e leggiere che richieggono a bene osservarsi uno sguardo più esperimentato. Non s’istillano loro i principi di quella erudizione che tanto è necessaria per chi s’accinge a comporre, come sarebbe a dire intender bene la propria lingua, ravvisar la più acconcia collocazione degli accenti, la prosodia più esatta e la connessione dell’una e dell’altra colla declamazion teatrale, internarsi nell’arte poetica e nel meccanismo della versificazione a fine di conoscer la diversità degli stili, e la maniera di eseguirli nella musica, non trovarsi digiuno nella storia e nei costumi de’ popoli per non dare all’asiatico Enea la stessa melodia che al mauritano Jarba, e non far cantare sul medesimo tuono un effemminato Sibarita e un generoso compagno di Leonida allevato sulle rive dell’Eurota. Di queste ed altre cose appartenenti più da vicino alla scienza loro sono così all’oscuro la maggior parte dei moderni maestri che niuno si trova meno in istato di soddisfare alla difficoltà che ponno muoversi contro da chiunque non sia della professione. Io medesimo benché alieno dal mestiero e poco iniziato in siffatte materie mi sono maravigliato spessissimo della profonda e totale ignoranza in cui vive la maggior parte di essi di quei principi dell’arte propria, per comprenderne i quali basta una mente avvezza a ragionare che abbia avuto qualche consorzio colla filosofia. , , , , , le , , , , , , e tali altri uomini di merito, che hanno con tanta lode avanzata la teoria, la pratica, o la metafisica della musica nel nostro secolo, sono nomi egualmente sconosciuti a loro che al gran Lama del Tibet, o ai Telapoini del Siam. Pochi vi sanno dire il perché d’una legge musicale o rendervi la ragion filosofica di una usanza; pochissimi hanno i lumi sufficienti a conoscere i pregiudizi e gli abusi del loro mestiere, o conoscendoli, la buona fede di confessarli. Pare che l’anima loro non esista fuorché nei tasti del cembalo, che la loro esistenza tutta si raduni sulle punte dei diti, e che gli spartiti siano la carta geografica dove si comprende tutto il loro universo scientifico. Se si dovesse cercare un emblema che rappresentasse al vivo il maggior numero degli odierni maestri di cappella, io crederei di averlo ritrovato in quell’artificiale automate fabbricato dal celebre Vaucanson, che suonava il flauto meccanicamente, oppure in quella macchina inventata pochi anni fa da un Boemo, e veduta nell’imperial corte di Vienna, la quale a forza di segreti ordigni giuocava perfettamente agli scacchi senza senso alcuno né cognizion delle mosse.
[47] Ora se non si può far dei progressi nelle scienze e nelle arti senza la speditezza dei metodi, i quali per la maggior parte degli uomini sono ciò ch’è la bussola per le caravane che traversano i deserti immensi di Saara e di Biledulgerid; se quelli che s’adoperano comunemente nelle scuole di musica non meno che nelle altre scuole che formano la nostra educazion letteraria, servono tanto a sviluppar il genio musicale quanto lo studio delle Pandette gioverebbe a crear in una nazione dei legislatori simili a Minosse, a Confuzio, a Pen, o a Licurgo; se tutte le idee o modificazioni intellettuali dell’umano spirito hanno così stretta relazione fra loro che non può farsi gran via in una scienza o facoltà senz’essere più che mediocremente versato nella cognizione delle altre facoltà o scienze che le tengono mano; se il talento s’avvilisce qualora divien mercenario, e se le arti liberali somiglianti a quelle piante generose che marciscono ne’ luoghi paludosi o ristretti, né s’avverdiscono o frondeggiano fuorchè all’aria aperta e sotto libero cielo, non ponno fiorire colà dove i coltivatori loro le prendono per un mestiero che debbe unicamente servire di stromento al loro guadagno; egli fa d’uopo confessare, che la musica soggetta a tutti gli accennati inconvenienti non può, e non ha potuto conservar lungo tempo la sua perfezione in Italia.
[48] Sarebbe nondimeno una ingiustizia l’incolpar soltanto i maestri. Se questi hanno contribuito a viziar il gusto del pubblico, anche il pubblico ha loro non poche volte fatto uscir di sentiero. L’amore del piacere, che ricompensa gl’Italiani della perdita della loro antica libertà e che va dal paro in una nazione coll’annientamento di pressoché tutte le virtù politiche, ha fatto nascere la frequenza degli spettacoli. Da questa è poi venuta la sazietà del bello, e il desiderio di variare, che hanno generato in seguita la mediocrità, la stravaganza, e il capriccio. In ogni piccola città, in ogni villaggio si trova inalzata un teatro. Il solo Stato Pontificio ne conta più di quaranta. Mancherà la sussistenza agli indigenti, i ponti ai fiumi, gli scoli alle campagne, gli spedali agli infermi, e i provvedimenti alle calamità pubbliche, ma è fuor di dubbio che non mancherà la sua spezie di Coliseo per gli scioperati. La dimanda che oggidì fa il popolo italiano a chi timoneggia nel governo, è la stessa che ne faceva sedici secoli addietro a’ tempi di , vitto e spettacoli Panem et Circenses. Ogni anno s’eseguiscono di quà dai monti più d’un mezzo centinaio di rappresentazioni musicali diverse. Quella ch’è piaciuta all’estremo nel carnovale scorso s’ascolta con isvogliatezza e fastidio nel carnovale presente. I capi d’opera del e del giacciono polverosi e negletti, perché il popolo avido di novità gli pospone, dopo averli più volte sentiti, alle bambocciate e alle caricature de’ compositori moderni. Ognuno degli spettatori si trova attaccato dalla stessa malattia di Nerone, il quale annoiato delle bellezze di Ottavia e delle attrattive di Popea giunse fino a mutilar un garzone per isposarlo, e concepì la strana fantasia di vestirsi delle spoglie di un vitello per intraprender ciò che non oserei raccontare senz’allarmar la dilicatezza dei lettori.
[49] Questo morbo letterario proviene da due principi irremediabili ascosì nell’umano spirito, cioè dalla inquietudine e dalla vanità. Per un effetto della prima avviene che l’uomo, non sapendo stabilire dei limiti alle proprie facoltà e restando sempre con ciò che desidera al di sopra di quello che ottiene, ama sul principio nell’armonia gli accordi più naturali e più semplici, tali cioè che nascano espontaneamente dall’argomento, e possano con facilità ritrovarsi dal compositore. Ben presto, non trovando in quella naturalezza la novità e la sorpresa che cagionavano il suo piacere, cerca degli altri tuoni più piccanti, che risveglino, a così dire, la sua infastidita sensibilità. Ma cotai tuoni divenuti anch’essi per la stessa cagione insipidi e freddi dopo qualche tempo, necessario è che cadano nella stessa dimenticanza che i primi per dar luogo ad altre modulazioni più vive, l’effetto delle quali è di guastare e corromper l’orecchio avvezzandolo al caricato invece del semplice.
[50] La vanità, di cui è proprio il rinunziar ad una folla di piaceri per meglio assaporare il maggiore di tutti ch’è quello di farci credere superiori agli altri, è il motivo altresì per cui molti si compiacciono d’uno stile ricercato e difficile. La maniera naturale e facile appunto perché è tale, sembra riserbata alla debole comprensione del volgo. Il sentirla non costa niente, non è effetto del sapere né dell’ingegno, ma da una non so quale disposizione che sebbene dal cielo sia stata data a pochissimi, per tutto il mondo crede di possederla. L’ambizione per tanto non trova i suoi conti in codeste bellezze semplici. Ella preferisce lo straordinario e il bizzarro, ciò che suppone un qualche sforzo di mente per ben comprendersi, perché ciò fa onore alla penetrazione e alla dottrina dell’uomo vano, mostrandolo coll’una e l’altra superiore di molto alla intelligenza comune. E tal è la bassezza dell’amor proprio, che quantunque la natura gli si appresemi con tutti i suoi vezzi, cerca nonostante di chiuder gli occhi alle vaghezze di lei, temendo che il mostrarsi sensibile ad esse noi faccia cadere dalla riputazione di uom dotto, ch’ei tanto pregia, fino alla debolezza d’averne dei piaceri comuni col volgo.
[51] Da ciò è derivato un’altro inconveniente. Quanto maggiore è il trasporto di un popolo per gli spettacoli tanto più grande è la libertà che concede ai coltivatori di essi. Simili agli amanti presso a’ quali le donne amate sono sicure di ottener il perdono di qualunque loro arditezza, gli uditori sono indulgentissimi con chi è lo stromento de’ loro piaceri. Cotal licenza può giovare di molto all’avanzamento delle arti allorché queste essendo nella loro fanciullezza, e confidate alle mani di saggi regolatori hanno bisogno di pigliar incremento, di spiar tutte le uscite e veicoli che guidano al bello non per anco ben conosciuto, e di rintracciar nel vasto campo della sensibilità e della immaginazione il maggior numero possibile di quelle sorgenti onde scaturisce il diletto. In tal caso i metodi che le circoscrivono, riducendole prima di tempo in sistema, sono paragonabili a quelle fisonomie formate troppo presto nei fanciulli, le quali annunziano per lo più la debolezza dell’individuo e la scarsezza del principio vitale. Ma quando le arti hanno presa la lor consistenza, quando le idee della bellezza nei rispettivi generi è bastevolmente fissata, quando la moltiplicità de’ confronti ha messo al crogiuolo del tempo e del giudizio pubblico le opinioni, gli errori, le verità, e le produzioni degli artefici, allora una licenza illimitata produce l’effetto contrario. Ognuno che coltiva una professione vuol distinguersi dai compagni. Desideroso di esser grande piuttosto colla lode propria che coll’altrui, cerca d’avanzarsi nella sua carriera per sentieri non battuti dai concorrenti. Quindi l’amore della singolarità, il disprezzo per gli antichi metodi, il discostarsi dai maestri e il creder che hanno fatto meglio di loro quando hanno fatto diversamente. Tale è il destino di tutte le arti, e tale è presentemente quello della musica.
[52] Ciò non vuol dire che in così sfavorevol sentenza siano compresi tutti quanti i compositori d’Italia. Chi scrive sa benissimo che ogni regola patisce la sua eccezione e che in ciascuno dei rami della facoltà musicale può questa nazione vantare più d’un professore di sommo merito. Infatti bisognerebbe aver aprodato or ora da qualche isola boreale scoperta dal celebre viaggiatore Cook per ignorar i talenti e la scienza del sempre bello e qualche volta sublime ; d’un scrittore pieno di melodia e di naturalezza, il quale in pochi anni che visse ebbe la stessa sorte del , cui non restò inferiore nell’invenzione e nella novità; d’un ritrovatore facile e fecondo massimamente nel buffo, e che forse ottiene fra i compositori lo stesso luogo che fra i poeticomici; d’un tornato poco tempo fa in Italia dopo essere stato ai servigi della imperatrice delle Russie, dotato d’estro singolare e d’una maravigliosa ricchezza nelle idee musicali, e che risplende per ornatissimo stile e per nuovo genere di vaghezza; d’un maestoso insieme e venusto, di gran fuoco, di vivo ingegno, di stile brillante e florido; d’un celebre per la sua maniera di scrivere dolce, affettuosa, e sommamente cantabile; d’un degno di essere annoverato fra i più gran compositori del suo tempo pel colorito forte e robusto, per la ragione che spicca nelle sue composizioni, e per la verità della espressione; d’un scrittor naturale, pieno di gusto, e di scelta felice negli accompagnamenti; d’un , d’un , e per tacere molti altri, d’un , il quale benché tedesco di nazione ha forse più d’ogni altro contribuito a ricondurre nel buon sentiero la musica teatrale italiana spogliandola delle palpabili inverosimiglianze che la sfiguravano, studiando con accuratezza somma il rapporto delle parole colla modulazione, e dando alle sue composizioni un carattere tragico e profondo dove l’espressione che anima i sentimenti va del paro colla filosofia che regola la disposizione dei tuoni139.
[53] Parimenti tra i moltissimi maestri di musica strumentale, o morti da poco tempo o viventi ancora, l’Europa tutta si riunisce per rendere la dovuta giustizia ai due famosi eredi dello spirito di cioè e , il primo dei quali si creò un suo particolare stile mirabile per la bella e forte cavata dello stromento, mentre il secondo felicissimo nell’imitare il suo maestro divenne eccellente nella esecuzione non meno che nella patetica e dolce gravità de’ suoi adagi. Singolare per la forza, vigore, e chiarezza del suono, per l’opportuna scelta degli ornamenti, per la nobiltà del suo stile e per diversi altri pregi è l’egregio , direttore della Reale Orchestra di Torino. Degni discepoli d’un tanto maestro tuttora si mostrano il , che rammorbidisce a meraviglia con una certa dolcezza e soavità la robustezza dello stile propria della sua scuola, e l’incomparabile , la cui maniera di suonare veloce, viva, di gran nettezza, e di ottimo gusto ha meritamente riscossi gli applausi dei più rinomati teatri. Né meno celebri sono presso agli amatori della scienza armonica divenuti il suonatore originale per lo suo stile ameno, vago e grazioso, il compositore bravissimo di elevati spiriti, di frase limpida e chiara, e di profonda dottrina musicale, il di sangue italiano quantunque nato e allevato in Parigi, il quale altrettanto si è distinto nel genere brillante e piacevole quanto il famoso nell’agevolezza dell’arco, nella maestria dei passaggi e nell’arte di eseguire le più difficili squisitezze dell’armonia. Né la scuola del ha tralignato dall’antico valore, ma durevoli saggi ci porge ancora in due pregevolissimi torinesi il cioè, violonista eccellente, e il , imitatore felice dello stile del suo maestro, al quale si dice che aggiunga del suo una bellissima cavata di suono limpido, netto e preciso. E chi non sa per quanta fama vadano chiari i nomi del , del , napoletano, e della celebre di Nardini, la quale non inferiore nel merito ai professori di primo grido seppe trasferire all’arte del suono la dilicatezza e le grazie proprie del suo sesso. Sarebbe più facile
«Ad una ad una annoverar le stelle»
che il fare patitamente menzione di tanti altri compositori o esecutori più giovani, che sotto la scorta degli accennati maestri coltivano quest’arte deliziosa in Italia. Ma l’andare più oltre né piace né giova, non essendo il mio scopo tessere una nomenclatura od un catalogo, ma presentare soltanto agli occhi de’ lettori una rapida prospettiva. Quello che in generale può dirsi è che nelle loro mani la musica acquista a certi riguardi una maggiore bellezza mentre la va perdendo a certi altri. Se la leggerezza, la varietà, la leggiadria, il brio, l’abbondanza, l’analisi più minuta dei tuoni, un maggiore raffinamento in tutte le sue parti, ed alcuni antichi pregiudizi tolti di mezzo per sostituirvi degli altri bastano a caratterizzar il buon gusto d’un’arte imitatrice, la nostra età dovrebbe a ragione chiamarsi il secolo d’Augusto per la facoltà musicale. Ma se, come abbiamo provato in altri luoghi e proveremo di nuovo dove si parlerà del canto, il vero filosofico gusto e la perfezione d’ogni arte imitativa consiste nella rappresentazione più o meno abbellita della natura, e nell’esprimere l’oggetto che prende a dipingere senza sfigurarlo né caricarlo più di quello che comporta l’indole della imitazione, se questo fine non s’ottien nella musica se non per mezzo della semplicità, della verità e della naturalezza accoppiata all’espressione, e se ogni e qualunque ornamento, ogni e qualunque bellezza che le si aggiunga senza riguardo a cotale scopo, non è altro che una imperfezione, un difetto di più, in tal caso bisogna pur confessare, e confessarlo con coraggio, che la maggior parte delle pretese finezze armoniche, onde vanno tanto superbi i moderni maestri, invece di provare il miglioramento del gusto altro non provano che la sua visibile decadenza. Come il lusso, che manifesta una ricchezza apparente nello stato politico, annunzia da lontano agli osservatori sagaci il languore e la povertà della maggior parte degli individui.
Fine del Tomo Secondo.
Tomo terzo §
Capitolo decimoquarto §
Seconda causa: vanità ed ignoranza dei cantori. Analisi del canto moderno. Riflessioni sui giudizi popolari, e sulla varietà dei gusti musicali.
[1] In una nazione che riguarda l’unione della musica e della poesia come un semplice passatempo destinato a cacciar via l’oziosità, dove il piacere del canto è nulladimeno così universale e così radicato, dove la lingua è per se stessa armoniosa e cantabile, e dove tal diletto si compra a costo del più gran sagrifizio, il cantore dev’essere la persona più interessante del publico divertimento. Così questi, prevalendosi del favore degli spettatori, si è discostato pian piano dalla subordinazione dovuta al poeta e al compositore, e da subalterno divenuto padrone regola a suo talento la musica e la poesia. Se i cantori d’oggidì fossero come in altri tempi musici, poeti e filosofi insieme, il costume che dà loro la preferenza sarebbe non solo commendabile, ma necessario, poiché, a riguardar le cose in se stesse, la musica strumentale non è che una imitazione o un sassidio della vocale. Ma dal momento in cui si separarono codeste facoltà sorelle; dacché si considerarono come divise le persone di musico, di cantore, di poeta, e di filosofo; dacché ciascuna di esse volle sottrarsi da quella subordinazione che rendevasi necessaria e per la divisione comune e per l’ignoranza particolare dei professori; dacché ognuno aspirò a farla da capiscuola e a primeggiare, allora il cantore ridotto ad un esercizio quasi intieramente meccanico aver non dovea verun altro esercizio fuorché quello d’ubbidir al poeta e di eseguire il disegno del maestro. E mentre si trattennero fra cotai cancelli le cose tutte andarono in miglior sesto, come avvenne sul principio del dramma musicale sotto la direzione del e del . L’ignoranza del poeta e l’infingardaggine dei compositore fecero in seguito rovinar giù per la china del cattivo gusto i cantanti. Nel secolo passato il canto delle arie oltrepassava di poco nell’artifizio quello dei recitativi, i quali costituivano principalmente l’essenza dell’opera, e perciò ne’ recitativi ponevano ogni loro studio i compositori; sebbene il cattivo gusto allor dominante faceva che vi s’introducessero non poche putidezze di contrappunto lontane dalla semplicità e dalla bella natura. Dopo la metà del secolo i poeti incominciarono a far un uso più frequente delle arie, o strofette liriche, nei loro drammi, della quale usanza invaghiti i maestri dozzinali (cioè la maggior parte) trascurarono a poco a poco i recitativi in maniera che neppur li consideravano come necessari alla musica drammatica. Per lo che, trovandosi con siffatto metodo liberi della fatica che doveva costar loro la verità e i tuoni più vicini al discorso naturale in quella sorta di composizioni, s’applicarono a coltivar principalmente le arie, dove potevano spaziare a loro talento mostrando tutte le delicatezze dell’arte, fossero esse o non fossero conformi al sentimento delle parole. Ecco l’origine di quel regno che di mano in mano sono venuti formando sulle scene i cantanti; imperocché accomodandosi questi ad un sistema che proccurava loro l’occasione di sfoggiare nel canto più raffinato ch’esigono le arie coll’agilità della voce senza trovarsi, a così dir, rinserrati fra le angustie del recitativo, costrinsero il compositore ed il poeta a strozzar il melodramma riducendolo a cinque o sei pezzi staccati, dove si fa pruova non d’illusione, né di teatrale interesse, ma d’una sorprendente volubilità ed artifizio di gola.
[2] Se fosse mio divisamento alzar la voce contro agli abusi che non sono puramente letterari, citerei innanzi al tribunale inappellabile della umanità, della filosofia, e della religione la barbara ed esecrabile costumanza che si conserva tuttora in Italia come reliquia dell’asiatica voluttà per monumento dei nostri vizi, per oltraggio della natura, e per consolar i Caraibi ed i Giaghi della superiorità che gli Europei si vantano d’avere sopra di loro. Parlo del privar che si fa spietatamente delle sorgenti della virilità tanti esseri men colpevoli che infelici, non per sigillare col loro sangue la verità della nostra augusta religione che ispira solo mansuetudine e dolcezza e che abborrirebbe sagrifizi sì infami, non per liberar la patria da eccidio imminente o da grave sciagura il sovrano, non per esercitar un atto di virtù eroica e sublime che ci ricompensasse della durezza dei mezzi coll’importanza del fine, ma per blandire l’orecchio col vano ed inutil diletto del canto, ma per sollazzare nella sua svogliatezza un pubblico capriccioso, scioperato, e corrotto, ma per riscuotere un passaggiero e frivolo applauso in quei teatri che istituiti un tempo col fine di stampare negli animi del popolo le massime più importanti della morale, sono oggimai divenuti l’asilo de’ pregiudizi nazionali, e altrettante scuole di scostumatezza. Esorterei i grandi della terra, che accumulando insensatamente su tali persone onori e ricchezze favoreggiano un abuso cotanto infame, a rivolgere i loro tesori e la protezione loro ad altri usi meno disonoranti per la ragione, e meno perniciosi alla umana spezie. Farei arrossire i filosofi, che impiegando le loro ricerche in oggetti inutili, o facendo servire l’analisi alla destruzione di quelle verità, delle quali esser dovrebbero i principali sostenitori, passano poi di volo sopra un così orribile attentato che si sostiene unicamente perché autorizzato dal tempo e perché fiancheggiato dal despotismo del piacere. Ridesterei lo zelo dei ministri dell’altare acciocché più non trovasse ricetto nel domicilio augusto della divinità un pregiudizio che non può far a meno, che non la offenda, e metterei loro sotto gli occhi l’esempio del Pontefice Clemente XIV, il quale (se mal non m’appongo) riaccese di nuovo i fulmini del Vaticano contro ai crudeli promotori della evirazione. Mi rivolgerei a quel sesso da cui non si dovrebbe aspettare che patrocinasse una simile causa, ma tra il quale gl’inconcepibili progressi della corruzione fanno pur nascere più di una spiritosa avvocata, pregandolo a concorrere per mezzo della influenza cui la natura, non so se per nostra fortuna o per nostra disgrazia, ha dato alle donne sopra di noi, a sradicar un costume il quale divenuto che fosse più generale renderebbe affatto inutile sulla terra l’impero delle loro attrattive, e persin la loro tanto da noi pregiata esistenza140.
[3] Ma poiché alla oscura e solitaria filosofia poco forte in se stessa per resistere alla tirannia delle opinioni altro partito non resta fuorché quello di piangere su tali crudeltà, detestarle e passar di lungo, mi restringerò al mio solo uffizio ch’è di additare gli abusi da costoro introdotti nell’opera. Non è il minore quello che apparisce a prima vista, e che risulta immediatamente dalla loro figura e costituzione fisica, la quale li rende idonei bensì a rappresentare caratteri femminili, o al più quelli di Attide nello speco di Galatea, e di Cipariso nel gabinetto di Cibele, ma in niun modo a proposito per rappresentare personaggi virili. Infatti qual proporzione trova l’occhio dello spettatore fra l’aria maestosa e guerriera di Temistocle coi visi forbiti di codesti ch’io chiamerei volentieri i neutri della umana spezie? Fra la dolce e vigorosa fierezza d’Achille col languido loro atteggiamento? Fra lo sguardo decisivo e celeste di Marte o di Apolline col loro volger d’occhio effeminato e cascante? Come potranno contraffare gli dei coloro che sono al di sotto degli uomini? Come è possibile che quelle lor voci liquide e dimezzate ispirino altri affetti che mollezza e languore? Come non ha dovuto perder la musica la sua antica influenza sugli animi?
[4] Alla sconvenevolezza nella figura s’aggiugne come una conseguenza la poca espressione nei movimenti, difetto che hanno essi comune con quasi tutti gli altri cantori. Occupati solo del gorgheggiare, pare a loro che l’azione e il gesto non ci abbiano a entrare per niente, e si direbbe quasi che vogliano patteggiare colle orecchie dello spettatore senza curarsi punto degli occhi. Così si veggono sovente muover le labbia, s’ode la soave armonia delle loro voci come si sentiva risuonar nell’antica Menfi la statua di Memnone al primo comparir dell’aurora senza che corrispondesse all’armonia verun atteggiamento esteriore. E se qualche volta si pongono in movimento è solo per contraddir se medesimi, e per distrugger col gesto la commozione che avrebbe potuto destarsi col canto, accompagnando con segni di dolcezza le parole ch’esprimono il furore, e prestando a Cleonice addolorata per la partenza di Alceste lo stesso contegno che le si darebbe alorché si consiglia coi grandi della nazione intorno alla scelta di uno sposo. Chi può frenare il riso in veggendo un Timante disperato o un furioso Farnace, che in mezzo alla disperazione o alla collera quando l’anima, mettendo in rapida convulsione le braccia, gli occhi, il volto, e pressocchè tutte le membra, fa quasi sembiante di volere sloggiare dal corpo, pur si fermano fissi immobilmente colla bocca aperta, col braccio incurvato, e colla mano attaccata al petto per più minuti, come avessero a rappresentare i figliuoli della Niobe che si trovano nella galleria di Firenze? Cosa vogliono significare que’ tanti storcimenti di collo, quel girare cogli omeri, quel non aver mai il torace in riposo non altrimenti che facciano gli avvelenati o i punti dal morso della tarantola nel tempo che si espone la sua ragione ad un principe, o mentre Regolo parla gravemente col senato di Roma? E è l’uomo di buon senso che non deva fremere nel veder per esempio Radamisto che, ferito in un braccio da Tiridate, continua ancora a gestire per tutta l’azione col braccio ferito, come l’avesse pur sano? Nell’osservare Arbace, che apparecchiato a bere il veleno e cantando un’aria colla tazza in mano, la va voltando, e rivoltando come fosse già vuota? Nel contemplar Argene, che mentre le vien narrata la disperata risoluzione di Licida resta indifferente sulla primiera attitudine finché dura il racconto, terminato il quale comincia come per convenzione a dar nelle smanie? Nel rifletter che Beroe allorché parlando con Samnete gli dice:
«Idol mio per pietà rendimi al tempio.»
invece d’intuonare quell’“idol mio” verso l’amante, si rivolge al vicino palchetto dove lo scimunito protettore accoglie l’inzuccherato complimento con un sorriso di compiacenza e colla stolidezza degna di cotai mecenati? Per non dir nulla della energia che scemano alla situazione e al sentimento lasciando il gesto inoperoso e senza effetto in tante circostanze che traggono appunto da esso la lor verità.
[5] Come avessero un fedecommesso ne’ gesti che si trasmettesse per retaggio dal maestro al discepolo, così vedrete usarsi da loro in ogni e qualunque circostanza certe maniere di muover le braccia, il collo e le mani, dalle quali non si diparton giammai. Si cangia la musica annunziando che comincia il recitativo obbligato o l’aria? Ecco Eponina voltar tosto le spalle all’imperador Vespasiano, che riman sulla scena senza riguardo al rispetto dovutogli, e divertirsela passeggiando lentamente il teatro come se per tutt’altro fine fosse venuta colà che per conciliarsi l’attenzione e per mostrarsi appassionata. Prende poi a cantar le parole colla nobil mimica esposta di sopra, e colla quale par che i cantanti vogliano prendersi a gabbo la sensatezza degli uditori; tanto essa è inverosimile, disanimata e ridicola. E intanto Vespasiano, che ascolta, che fa egli? Sua maestà imperiale se la passa garbatissimamente affettando un’aria di dissipazione che innamora, guardando per ordine i multiformi cimieri, e le vario-pinte altissime piume che si muovono nei palchetti, salutando nella platea i suoi conoscenti ed amici, sorridendo col suggeritore o colla orchestra, guardandosi l’anello, battendo talvolta e ribattendo le catenuccie dell’orologio con simili gentilezze tutte a questo modo bellissime. E ciò mentrecchè la meschineria Eponina si sfiata per muoverlo a compassione. Quale idea si formano essi adunque del luogo dove si trovano, e dei personaggi che rappresentano? Non direste che vogliano ancor sul teatro comparir que’ tali, che sono, che si facciano uno scrupolo di mentire al pubblico e (come diceva a questo proposito graziosamente il più volte lodato ) che abbiano timore non l’udienza prenda in iscambio il Signor Alipio Forcone e la Signora Cecilia Pelatutti col principe Zoroastro e colla regina Culicutidonia?
[6] La cagione degli accennati difetti viene in parte dalla
natura stessa del canto, poiché quanto più di attenzione si mette nel far dei trilli e
dei passaggi tanto meno rimane per accompagnarli coi segni confaccentisi; ma in gran
parte consiste ancora nella inesperienza dei cantori, nel poco studio che ci mettono su
tali cose, e nelle false idee che si formano del loro mestiero, non sapendo, o non
volendo sapere, che l’anima degli affetti consiste nella maniera di esprimerli, e che
poco giova ad intenerirci la più bella poesia del mondo quando accompagnata non venga
dall’azion convenevole. Così almeno la intendeva il gran , il quale in una lettera diretta al Signor napoletano si lagna vivamente di cotale abuso:
«Qualunque sia, ei dice, cotesto mio povero dramma
non crescerà certamente di merito fra le mani de’ presenti cantori ridotti per colpa
loro a servir d’intermezzo ai ballerini, che avendo usurpata l’arte di rappresentare
gli affetti e le azioni umane meritamente hanno acquistata l’attenzione del popolo,
che hanno gli altri meritamente perduta; perché contenti di aver grattato le orecchie
con una sonatina di gola nelle loro arte, il più delle volte noiose, lasciano il peso
a chi balla d’impegnar la mente e il cuore degli spettatori.»
[7] E pazienza s’eglino almeno avessero imparati gli elementi dell’arte loro e cantassero come va fatto, ma per disgrazia nostra sono o tanto ignoranti o tanto pregiudicati in questo quanto nel restante. Per mettere in tutto il suo lume una proposizione che profferita da uno straniero in mezzo alla Italia può forse comparir temeraria, mi si conceda entrare in qualche ricerca intorno al canto imitativo del melodramma, la quale sarà, cred’io, non inutile affatto ai signori virtuosi, se pur la loro ignoranza o la vanità o i pregiudizi che partecipano dell’una e dell’altra, lasciano loro tanto di modestia e di buona fede quanto basta per degnar d’uno sguardo le osservazioni di un amatore del bello, il quale però ha i due capitali difetti di non essere cioè aggregato a veruna accademia musicale, e di dire intrepidamente ciò che si sente.
[8] Nel nostro presente sistema drammatico tre cose concorrono principalmente a produr l’espressione, cioè l’accento patetico della lingua, l’armonia, e la melodia, ciascuna delle quali suddividendosi in vari altri rami formano quell’aggregato dal quale ben congegnato e unito ai prestigi della prospettiva risulta poi l’illusione e l’interesse dello spettacolo. L’accento patetico della lingua non essendo altro che il linguaggio naturale delle passioni nei vari loro caratteri, è quello che serve di fondamento alla imitazion musicale principalmente nel canto. La melodia è l’imitazione stessa di esse passioni eseguita pel mezzo d’una serie successiva di suoni aggradevoli. L’armonia è, per così dire, il legame o vincolo fra l’uno e l’altra siccome quella che modifica l’accento secondo tali determinati intervalli, e che dà ai suoni della melodia la necessaria precisione e giustezza. Le tre cose accennate sono così legate fra loro e così essenziali nel melodramma che ove mancasse una sola, non sarebbe possibile l’ottenere l’effetto delle altre. L’accento della lingua sciolto, a così dire, e vagante non avrebbe altra forza che quella che si ritrae dal parlar ordinario. La melodia da per sé sarebbe un disegno capriccioso senza oggetto né regola. L’armonia resterebbe una combinazione equitemporanea di suoni che niuna immagine, niuna idea presenterebbe allo spirito. Ma se la loro azione è necessaria nel melodramma, non è necessario però che quest’azione sia nello stesso grado dappertutto né che sia simultanea. In una lingua armoniosa per natura come la greca, dove la poesia regolava la musica, dove la prosodia era l’anima della misura, dove l’accento musicale se medesimo non abbisognava se non che dell’aggiunta del ritmo per divenire un perfetto recitativo, la poesia poteva accompagnarsi e s’accompagnava in effetto con un canto eguale e continuo appropriato mirabilmente all’indole di essa. Poetare e cantare pei Greci erano una sola e medesima cosa. Ma nelle nostre lingue moderna appoggiate per le ragioni che s’addussero altrove su principi diversi siffatta unione o combaciamento fra la poesia e la musica non può così speditamente ottenersi, poiché avendo la musica acquistate tante ricchezze inseparabili da lei, non sa accompagnarsi colla poesia senza portar seco tutto il corredo de’ suoi abbigliamenti, e per conseguenza senza opprimere la compagna. A guisa dell’amore, ella non sa regnare che sola. Dall’altra parte l’azione della musica è così viva ed intensa che mal potrebbe regger l’uomo alle squisitezze d’una melodia come è quella usata ne’ nostri teatri, se dovesse prolungarsi senza interruzion né respiro per i tre atti d’un dramma. Da queste due ragioni combinate insieme risulta il doppio bisogno di far prevalere alternativamente nel melodramma or la poesia or la musica, e di maneggiar la melodia con certe precauzioni allorché faccia di mestieri unirla colle parole affinchè queste non perdano totalmente l’effetto loro. Quindi la natural divisione della poesia musicale in recitativo semplice, recitativo obbligato ed aria; divisione troppo necessaria nei nostri sistemi di armonia e di lingua, ma la quale per motivi contrari non era né poteva esser tale presso agli antichi Greci. cosicché tutta la teoria della espressione nel moderno melodramma si racchiude nella soluzione del seguente problema: Assegnare fino a qual punto l’accento naturale della lingua possa divenir musicale, e fino a qual punto la musica deva approssimarsi all’accento naturale.
[9] Una folla di corollari luminosi e brillanti mi si fanno innanzi dopo l’enunciato problema, sui quali però mi è forza passare di lungo per fermarmi soltanto nelle cose che tendono direttamente al mio assunto. Sarà la principale l’applicazione degli accennati principi alle diverse parti del melodramma. V’ha dei casi dove spicca la sola poesia con pochissimo accompagnamento di musica; dei casi dove la poesia prende alcuni caratteri di canto coll’intervento degli strumenti; dei casi infine dove la poesia trasfondendosi intieramente nel canto e fregiata da tutti gli ornamenti della strumentale concorre insiem colla musica a render più pomposo e più illustre il trionfo del sentimento.
[10] Partendo da un principio inconcusso, cioè che nella musica drammatica tutto esser deve imitazione e che niente può ella imitare dell’umano discorso fuorché l’accento delle passioni o ciò che appresenti allo spirito una rapida successione d’immagini, si deduce con evidenza che poco o nulla può imitare la musica nel semplice recitativo, nel quale poco differente dal parlar ordinario pel tuono della voce tranquilla con cui s’espone, e per le materie che vi si trattano, raro è che spicchi l’energia degli affetti. Tocca dunque alla poesia il far valere ciò che non potrebbe render la musica, ed ecco il luogo opportuno per l’attore di mostrar il suo talento nel recitare, notando il senso delle parole con chiara e netta pronunzia, osservando la prosodia della lingua senza confonderla, facendo sentir all’orecchio il poetico ritmo senza troppo affettatamente ricercarlo, insistendo sulle inflessioni che le somministra il discorso, facendo sentire gli incisi, le transizioni, le sospensioni e i periodi colle mutazioni accidentali dei tuoni, in una parola attaccandosi alle regole che prescrive l’arte della declamazione. La musica non vi deve entrare se non quanto basti per far capire che l’azione rappresentata è un azion musicale per contraposizione alla recitata. Altro non vuolsi da essa se non che accompagni di quando in quando l’attore col basso affine di sostenere la di lui voce, né si chiede altro dall’attore se non che misuri l’accento con qualche intervallo armonico, nel quale la regola sarebbe che non oltrepassi colla voce l’estensione d’una ottava. Tutto il restante debbe tacere e la sola poesia parlare.
[11] Allorché il sentimento va prendendo mossa e calore, allorché la voce interrotta per intervalli palesa il disordine degli affetti e l’irresolutezza d’un animo agitato da mille movimenti contrari, l’accento patetico della lingua piglia anch’esso un nuovo carattere nel recitativo obbligato, carattere il quale, essendo imitabile dalla musica, giustifica l’intervento di essa, anzi lo rende necessario. Ma uno stato dove la passione s’esprime per reticenze e dove l’alternativo silenzio frapposto alle parole è il miglior indizio possibile della dubbiezza dell’animo, non potrebbe rappresentarsi con una sempre costante e non mai interrotta modulazione: quindi la regola dettata dal buon senso e dalla esperienza d’usar cioè vicendevolmente della poesia e degli strumenti come di due interlocutori che parlano l’uno dopo l’altro. Ed è qui appunto dove più che altrove spiccar dovrebbe la scienza mimica dell’attore e le profonde osservazioni fatte da lui sui caratteri, sugli affetti, e sugli uomini. Dovrebbe egli interpretare colla evidenza del gesto ciò che la voce non esprime abbastanza, perché trovasi, a così dir, soffogata dall’affollamento delle idee. Dovrebbe dar maggior lume e risalto all’idioma imitativo degli strumenti ora con lunghe pause e marcate che aprano largo campo all’azione di essi, ora con quei segni inarticolati che sono la favella dell’anima, e che mostrano la superiorità di un attore che sente e conosce non solo quello che dice, ma quello ancora che deve tacersi. Dovrebbe far sentire la successione degli intervalli armonici nei tuoni della voce, e farla sentire in maniera che, notandoli fortemente e troppo spesso, non si dia nel cantabile proprio dell’aria, oppure notandoli debolmente e troppo di rado, appena si distingua dal discorso ordinario. Dovrebbe inoltre significar coll’azione, coi cambiamenti del volto e coll’atteggiamento della persona que’ tratti di forza e di sublimità che vengono assai meglio spiegati con un silenzio eloquente e con un accento interrotto che colla più pomposa orazione. Dalla imperizia de’ cantori in questo genere è venuta l’accusa che vari scrittori fanno al canto moderno di non convenire cioè in alcune occasioni a quello stile sublime, a quelle situazioni inaspettate ed energiche onde tanto s’ammiran da noi i poemi degli antichi, e le tragedie recitabili. Diamone alcuni saggi per maggior chiarezza.
[12] Nel sesto libro della Eneide Enea trova ne’ boschetti dell’Eliso la troppo sventurata Didone. Al suo apparire si risvegliano nel petto del principe Troiano la tenerezza e il rimorso. S’avvicina, piange, le parla colla eloquenza propria d’un’anima che conosce tutta la sua umiliazione, e che vorrebbe pur patteggiare fra la religione e l’amore. Didone l’ascolta senza guatarlo, non proferisce un sol motto e gli volta le spalle.
[13] Nella Medea di quella principessa sdegnata con Giasone e con tutta la corte di Creonte fa palese a Nerina sua confidente l’estremo desiderio che ha di vendicarsi, e la destrezza colla quale va cercando i mezzi per riuscirvi. Nerina, che ignora ciò che ponno intraprendere le grandi passioni, mostra di dubitarne, le mette in vista tutto l’orrore del suo destino, l’odio de’ propri vassalli, la potenza di Giasone e la debolezza di lei
«Contre tant d’ennemis que vous reste-t-il?»
Medea risponde:
«Moi.»
[14] Negli Orazi del medesimo poeta una donna viene dal campo dov’era stata presente alla pugna senza però vederne il fine, per avvisar il padre che i duo figliuoli suoi erano stati uccisi da’ Curiazi, e che il terzo, vedendo di non potervi resistere, avea presa la fuga. Il vecchio sen duole amaramente della codardia del figlio. La sorella allor gli dimanda
«Que vouliez-vous qu’il fît contre trois?»
e il vecchio Orazio:
«Qu’il mourût.»
[15] Nell’Othello di quel generale di cuor magnanimo ma violento e geloso all’estremo, ingannato da Jago, crede infedele Desdemona sua moglie e la uccide nel letto maritale. Un momento dopo scuopre l’innocenza di questa e le calunnie del perfido amico. Invece di dar nelle smanie, Othello impietrisce e cade sul letto senza voce né motto.
[16] Nel Macbetto dello stesso poeta un suo
confidente gli dice che il suo nimico gli ha trucidata barbaramente la moglie e i figli,
alla qual nuova restando egli quasi colpito fosse dal fulmine, e sentendosi eccitar
dall’amico alla vendetta e al sangue, troncamente risponde: «Ei non ha
figli.»
[17] Ora, dicono essi, né il terribil silenzio di Didone e di Othello, né le sublimi risposte di Macbetto, di Medea, e di Orazio, né mille altri esempi di questo genere si posson rendere nella nostra musica troppo loquace senza stemperarli in una insipida cantilena. Ma benché siffatta obiezione abbia più forza contro alla spezie di canto e di musica solita a sentirsi oggidì sui teatri che contro il canto e la musica in generale, e benché intendersi ciò debba soltanto delle arie e non dei recitativi, dove è indubitabile che possono aver il lor luogo i tratti più vibrati ed energici, come l’hanno pur qualche volta in quelli di ; egli è certo nonostante che l’accusa sarebbe men ragionevole ove la riflessione e la scienza del cantore sapessero colla proprietà dell’azione supplire al rapido e conciso linguaggio degli affetti. Ma di siffatto studio e cognizione, onde tanti vantaggi ne riporterebbe l’arte drammatica, niun pensiero si prendono i moderni Arioni.
[18] Quando la passione dopo aver ondeggiato vaga ed incerta s’appiglia pure ad un qualche partito, o si risolve in uno o più sentimenti determinati, allora l’accento della lingua rinforzato dal vigore che gli somministra la sensibilità posta in esercizio offre quella situazione o quadro che serve di fondamento all’aria. In questa la poesia animata dalla espressione, abbellita dalla esecuzione e fregiata di quanto ha l’armonia di più seducente e di più energico prende tutti i caratteri del canto. Ivi l’estensione della voce è maggiore, le sue inflessioni più decisive, i riposi sulle vocali più lenti, la successione armonica degli intervalli diviene più sensibile e più frequente. Ivi la melodia ricerca i tuoni più appassionati e per conseguenza i più veri, gli raccoglie sotto ad un motivo dominante, gli dispone secondo l’ordine più dilettevole all’orecchio, e gli guida per modulazioni ora forti ed ardite, ora insinuanti e dolci, ora brillanti e piacevoli, ora tragiche e sublimi. Ivi l’attore non dee più recitare, ma modulare bensì le parole con proporzionata messa di voce, con portamento giusto, serbando religiosamente i loro diritti alla poesia e alla lingua, prendendo dall’arte quel tanto e non più che ci vuole per presentar la natura nel suo più vero e più dilettevole aspetto, in una parola devono spiccare nella esecuzione del suo canto la verità, l’esattezza, e la semplicità. Per verità di canto s’intende l’eseguire ciascun motivo colla mossa o andamento ad esso più acconcio, e l’afferrar i caratteri distintivi di ciascuna cantilena qualmente si convengono alla patria, alla età, alle circostanze e al grado attuale di passione del personaggio rappresentato. Per esattezza io intendo la precisione nella intonazione, la giustezza nel tempo, la chiarezza nell’articolar distintamente le sillabe. Per semplicità altro non si vuole significare fuorché l’opportunità e la scelta negli ornamenti. E perché molto si è parlato e nulla si è conchiuso finora dai musici intorno all’uso di cotali ornamenti, trovandosi fra loro chi vorrebbeli esclusi affatto dal canto come cosa puerile, e chi vorrebbeli al contrario supporre così necessari che disadorna e insoffribile riuscir dovesse senza di essi qualunque melodia; perciò parmi opportuno aggiugner brevemente su tale argomento qualche riflessione più filosofica e più precisa, imitando i chimici, i quali riducono ad un picciol vasetto di quint’essenza odorosa la sostanza di mille fiori che si trovavano sparsi per le campagne.
[19] Lo scopo delle arti imitative non è di rappresentar la natura semplicemente qual è, ma di rappresentarla abbellita. Siccome tutte le cose create perciò appunto che sono create hanno dei limiti e siccome i limiti suppongono imperfezione nell’essere ove si trovano, così non è possibile scoprir nell’universo un oggetto tanto assoluto e compito che possa servire di archetipo all’alta meta che si propongono le arti. Che fa dunque l’artefice? Guidato dalla percezione intima di quel bello che esiste forse bella natura fino ad un certo punto ma che non è nella maggior parte se non che una composizione, un lavoro fattizio delle nostre idee prende a modificar la materia che debbe servirgli di stromento, e togliendo da essa le parti tutte che mal corrisponderebbero al suo mentale disegno, raduna le altre e le combina sotto la forma più acconcia a far nascere in noi le idee della unità, della varietà, della convenienza e dell’ordine. Così l’amore di Prassitele, il Giove di Fidia, la Venere di Tiziano, il carattere di Augusto nel Cinna, l’anima di Regolo nel , altro non furono che un aggregato di proprietà atte a produrre in noi un determinato genere di sensazioni, le quali proprietà sparse prima nel mondo morale o nel fisico, e raccolte poi dagli artefici sotto ad un determinato concetto, costituirono quel tutto che viene decorato col nome di bello. Ecco la necessità di abbellir la natura ricavata dal principio stesso della imitazione.
[20] La musica non differisce punto dalle altre arti rappresentative. Come le statue dell’Ercole e dell’Antinoo sono una raccolta di tratti esprimenti la proporzione e il vigore osservati dallo scultore in più individui della umana spezie; come la descrizione della tempesta in non è altro che l’unione di molti fenomeni naturali che si veggono succedere negli oggetti, e che poi si radunano dal poeta in un solo quadro, così un bel recitativo od una bell’aria altro non sono che la collezione d’una moltitudine d’inflessioni e d’accenti scappati alle persone sensibili nei movimenti di qualche passione, e disposti poi dal compositore secondo le leggi della modulazione. Il risultato non per tanto della imitazion musicale benché tale qual è non esista nella natura, ha nondimeno in essa il suo fondamento, poiché sebbene non trovisi alcun oggetto sonoro in particolare che presenti all’orecchio la serie dei tuoni contenuti nell’aria, per esempio, “se mai senti spirarti sul volto” di , egli è però indubitabile che separatamente presi si trovano tutti nella voce delle persone da passioni amorose agitate. Attalchè molto male, a mio avviso, opinò quel moderno autore141 che ripose l’imitazion musicale nel rango delle chimere; opinione che non potè nascere in lui se non di poca filosofia, o dal desiderio di distinguersi con qualche novità stravagante.
[21] Al motivo d’abbellare e d’aggrandir la natura che ha comune la musica con tutte l’arti rappresentative, s’aggiungono ancora dei peculiari a lei sola. La sua maniera d’imitare è così indeterminata e generica, i sagrifizi che ci costrigne a fare nella poesia e nella declamazion naturale sono tanti sì replicati e sì grandi i segni esteriori delle passioni che servono di materia al linguaggio musicale sono così poco energici e così ambigui a cagione di quel contegno, di quella tinta di falsità, o di riserba che hanno sparso sopra di noi i sistemi d’educazione, e i successivi progressi della cultura o piuttosto del corrompimento nella società, i punti insomma dov’ella può afferrare gli oggetti sono sì oscuri e sì rari che la musica non ci offrirebbe verun compenso, né meriterebbe gli omaggi delle persone di gusto se l’arte d’illeggiadrire le cose, e per conseguenza una discreta licenza negli ornamenti non supplisce in lei alle altre mancanze. Eccedente non per tanto fu la severità di quell’altro francese autore d’un bel Trattato sul melodramma allorché volle sbandirà dalla musica drammatica tutto ciò che serve a dipignere e a far valere la possanza intrinseca dell’arte. Distingue egli con molto ingegno due sorta di musica una semplice e un’altra composta, una che canta e un’altra che dipinge, una che chiama di concerto e un’altra di teatro. Alla musica di concerto permette il cercar le forme più leggiadre di canto, lo scegliere i motivi più belli, e il far uso di tutte le squisitezze della melodia, ma non vorrebbe che la musica di teatro pensasse a verun’altra cosa fuorché all’unica espressione delle parole, che in grazia di queste trascurar dovesse ogni idea di proporzione e di ritmo, che non s’imbarazzasse nel condurre artifiziosamente i motivi, e nel seguitare le frasi musicali; bastando per essa il poter rendere colla maggior esattezza ciascun pensiero compreso nella poesia. In una parola vorrebbe egli che le grazie e le bellezze della musica fossero tutte quante sagrificate ad una rigida verità. Nulla di più giusto né di più sensato che siffatta opinione ove non fosse stata condotta all’eccesso. Egli è vero che le grazie puramente musicali sfoggiate al di là d’un certo segno fanno svanire l’illusione ch’è l’anima dell’interesse teatrale, ma egli è vero altresì che la troppo fedele e perfetta imitazione dei tuoni naturali privi dell’abbellimento che ricevono dalla musica non avrebbe sulle passioni la stessa forza muovente che ha l’altra imitazione meno perfetta ma più abbellita di cui è capace la melodia. O nasca un siffatto fenomeno dalla impressione più gagliarda che i suoni musicali fanno sui nostri nervi, o dalla compiacenza che risulta nell’anima dal veder imitati gli oggetti, o dal piacere riflesso che ha lo spirito ritrovando nuova materia dove esercitare la sua facoltà pensatrice e comparativa, o dalla sensazione analoga a noi che produce l’idea dell’armonia compresa negli intervalli musicali, o dal complesso di molte altre idee accessorie che s’uniscono a quella della immediata espressione dei sentimenti, certo è che dall’aggregato e dalla scelta dei colori che il musico aggiugne al quadro preso a dipingere, ne deriva un cumulo di piaceri maggiori assai di quello che ne risulterebbe dagli stessi originali imitati; nulla avendo di strano anzi essendo molto conforme alla quotidiana esperienza che i tuoni musici che rappresentano, per esempio, le gelose smanie di Poro, ci riescano più gradevoli, e ci muovano più assai che nol farebbe la voce naturale di Poro s’esprimesse quelle smanie medesime, come un serpente od una tigre che ci farebbero inorridire in mezzo ad una campagna, ci dilettano al sommo quando gli vediamo maestrevolmente imitati dal pittore. Ora se l’oggetto primario d’ogni musica imitativa è quello di piacere e di commuovere, se un tale oggetto s’ottiene assai meglio permettendo ad essa una discreta licenza negli abbellimenti, se la musica, cui lo scrittore francese chiama di concerto, mi rapisce, mi commuove, m’incanta, mi strappa dagli occhi le lagrime e mi sveglia appunto quelle stesse passioni che vorrebbe svegliarmi la poesia senza recar onta ai diritti di questa, e senza distruggere l’illusione propria del canto, perché dovrò sbandirla dalla scena? Perché dovrò con soverchia stitichezza rinunziare ai vezzi musicali e agli ornamenti che mi ricompensano dei sagrifizi che sono costretto a fare in grazia del canto? Tutta l’arte consiste nel colpire con giustezza pel segno dando alla rappresentazione propria della musica quel grado d’abbellimento che la rende commovente e aggradevole senz’alterar di troppo la sua rassomiglianza coll’oggetto imitato.
[22] Ma dove, quando, e come deve usar il musico degli ornati per conciliar fra loro i due estremi difficili, di emendar cioè coll’arte i difetti della natura, e di non sostituire alla natura gli abbigliamenti dell’arte? Seguitiamo in cotal ricerca l’analisi. Quando si dice che l’arte debbe aiutar la natura, si viene a dire che l’artificio è un supplemento di ciò che a lei manca. Per conseguenza dove la natura non ha bisogno di supplemento, dov’ella ha in se stessa i gradi di attività necessari a produrre compiutamente il suo effetto, ivi l’artifizio non dee punto aver luogo. A conoscer poi quando la natura abbia forza per se sola a produrlo, basta osservare se i tratti che si mostrano in lei fissano tutta l’attenzione del nostro spirito in maniera che dopo averla veduta, e dopo ch’ella ha parlato, la nostra curiosità e il nostro desiderio richieggano ancora qualche cosa di più, oppure rimangano appieno soddisfatti. S’è conseguito questo fine ultimo? Allora gli ornamenti aggiunti alla semplice e schietta natura nuocono invece di giovare, perché da una banda chiamano a se parte di quell’attenzione che dovrebbe tutta e intiera fissarsi sul tale oggetto, e dall’altra cuoprono colla loro pompa alcune bellezze naturali di esso onde restando inosservate, oppur non sentite non eccitano l’interesse. Le potenze del nostro spirito non restano ancora appagate? Ecco deve l’arte venire in soccorso a riempiere quel voto lasciato tra la cagione e l’effetto, facendo che gli abbellimenti cuoi servano, a così dire, di mediatori fra l’imperfezione della natura e la sensibilità mal contenta dell’uditore. Sua incombenza è di aggiugnere all’oggetto imitato quei lineamenti che gli mancavano nella prima sua impronta acciò più chiara e più sensibile apparisca l’imitazione. Ma si ricordi bene ch’essa appunto non dee far altro che riempiere il vuoto, vale a dire correggere, o aiutare, o perfezionar la compagna, non mai soppraffarla né opprimerla. La somma gloria di lei consiste anzi nel farla trionfare e nascondersi. Guai se l’arte mostra i suoi vezzi! Guai se invece di ausiliare vuol comparir prottetrice! Allora lo spettatore, che non s’interessa nell’oggetto se non se a motivo della illusione, ogni qual volta è costretto a riconoscer l’inganno: si pente della propria credulità e si vendica dispregiando l’arte e l’artefice.
[23] Dai principi accennati si ricava che il musico non dee ammetter in ogni luogo gli ornamenti, né in ogni luogo schivarli. Dee ammetterli qualora essi realmente correggano i difetti della composizione o del sentimento, qualora promuovano il gener medesimo di espressione che regna nel canto, qualora si confacciano coll’oggetto imitato e colla situazione, qualora servano a conciliar l’attenzione dello spettatore disponendolo a inoltrarsi nel senso delle parole o a gustar meglio la forza e la varietà del dettato musicale. Deve schivarli qualora divengon superflui o palesan di troppo l’artifizio, o scemano con insignificanti frascherie la vivacità del sentimento, o distornano l’attenzione dell’uditore dal soggetto principale, o distruggon l’effetto delle parti compagne, o tingono il motivo di un colore diverso da quello che esige il suo carattere, ovvero cangiano l’indole della passione o la natura del personaggio. Come la materia di che si tratta è tanto importante, così sarà bene il discendere a qualche conseguenza di pratica.
[24] Prima. Non si dee aggiugnere alcun abbellimento né dalla parte del suonatore né dalla parte del cantante ai semplici recitativi, come non s’inorpellano nella retorica l’esposizione d’una ragione o la narrativa d’un fatto; perocché nascendo l’interesse dalla chiara percezione di ciò che il produce, lo spettatore non potrebbe commuoversi in seguito se gli ornamenti gl’impedissero di prestar al filo dell’azione la dovuta attenzione.
[25] Seconda. Molto meno nei recitativi obbligati, ove rappresentandosi la dubbiezza dello spirito nata dal contrasto dei motivi che gli si fanno innanzi, l’anima concentrata nella sua irresolutezza non ha tempo di badare alle frascherie.
[26] Terza. Non deve infiorar il principio di un’aria per la stessa cagione che non s’infiora l’esordio di una orazione, cioè perché ivi è più che altrove necessaria la semplicità ad intender bene ciò che vuol dire il motivo, il quale mal si capirebbe travvisato dall’arte, e perché supponendosi gli uditori attenti abbastanza in principio, fa d’uopo riserbar i fiori per quel tempo ove la loro attenzione comincia ad illanguidire.
[27] Quarta. Nemmeno allora quando il canto esprime il calore delle grandi passioni. Queste non veggono altro oggetto fuorché se sole, e gli ornati aggiunti in tal caso fanno il medesimo effetto che le nuvole frapposte a ciel sereno fra l’occhio dello spettatore e l’astro luminoso del giorno.
[28] Quinta. Né meno in quella spezie di affetti che ricavano il pregio loro maggiore dalla semplicità con cui si sentono, e dal candore con cui si esprimono; tali sono gli amori boscherecci e le ingenue tenerezze di due giovani amanti ben educati. Una negligenza non affettata si conviene ai primi. Un ozio dolce d’ogni altra facoltà dello spirito fuor di quella di amarsi e di godere s’appartiene ai secondi.
[29] Sesta. Non dee il cantore frammetter gli ornamenti qualora l’andamento delle note nella composizione o la mossa degli strumenti è incitata e veloce. Sarebbe lo stesso che se ad uno che anela nel corso, altri gettasse fuori di strada alcuni pomi bellissimi, acciocché trattenendosi egli a raccoglierli, non potesse mai toccare la meta.
[30] Settima. Né meno quando canta accompagnato in un duetto, in un trio, in un finale o in un coro; attesoché se ad ogni cantore si concedesse l’uscir della riga per far pompa di ghiribizzi mentre gli altri stanno fermi a rigore di nota, quella non sarebbe più musica ma piuttosto una confusione e un tumulto.
[31] Ottava. Si può far uso di qualche fregio nelle arie allegre e festevoli perché proprio è dell’allegrezza il diffondersi, e perché lo spirito non fissato immobilmente (come nelle altre passioni) sopra un solo oggetto, può far riflessione anche agli scherzi dell’arte.
[32] Nona. Come nelle arie ancora che si chiamano di mezzo carattere; perché non esprimendosi in esse veruno slancio di passione forte né alcun rapido affollamento d’immagini, la melodia naturale deve allora supplire con graziosi modi e con gruppetti vivaci alla scarsezza di melodia imitativa.
[33] Decima. Si può brillare cogli ornamenti
in quei casi dove il personaggio s’introduce a bella posta cantando come nell’«Oh
care selve, oh cara felice libertà»
posto in bocca di Argene nell’Olimpiade, o nell’inno
«S’un’alma annodiS’un core accendiChe non pretendiTiranno amor?»
nell’Achille in Sciro, e varie altre di questa classe, nelle quali siccome il personaggio non rappresenta, ma canta, così a lui non si vieta usare di quelle licenze che si permettono a chi si diverte cantando in una camera, o in un’accademia.
[34] Undecima. Ma nei casi indicati, come in
tutti gli altri, gli ornamenti debbono usarsi con parsimonia e con opportunità. La
mancanza della prima fa simile il canto alla pianta infeconda di : «foliorum exuberat umbra»
. La mancanza della
seconda mette il motivo musicale in contraddizione con se medesimo, poiché ad un
andamento patetico s’uniscono i fregi dell’allegro, gli arzigogoli del presto
s’inseriscono nell’adagio, e così via discorrendo.
[35] Duodecima. Quando il pensier musicale d’un aria si è presentato adorno di certa classe di ornamenti, non si dee replicarlo di nuovo vestito in foggia diversa; perché s’hai colpito nel segno la prima volta, saranno necessariamente fuori di luogo i vezzi chc le aggiugni nella seconda.
[36] Decima terza. Le cadenze si devono eseguire con una ben graduata messa di voce, e con sobrietà d’inflessioni scorrendole con un sol fiato e con quel numero di note soltanto che basti a far gustare il pensiero e a riconoscervi l’indole della passione.
[37] Decima quarta. Vengono proscritte dal buon senso tutte le cadenze eseguite nello stile di bravura, cioè quelle cadenze arbitrarie inventate all’unico fine di far brillare una voce accumulando senza disegno una serie prodigiosa di tuoni e raggirandosi con mille girigiri insignificanti. Questo metodo è eccellente per metter in vista un cantore agli occhi del volgo musicale, ma l’uomo di buon gusto va al teatro per sentir parlare Sabino ed Eponina, non per sapere quanti passaggi e quanti trilli possano uscire in mezzo quarto d’ora dalla volubilissima gola d’una Gabriela, o d’un Marchesi.
[38] Decima quinta. Non si devono far entrare nel canto gli ornati propri della musica strumentale; poiché avendo questa le sue bellezze a parte, il mischiarle con quelle del primo è lo stesso che vestire il pensiero di un abito non suo.
[39] Decima sesta. Per conseguenza sono estremamente assurde e ridicole le arie obbligate dove la voce imita uno stromento sia da fiato ossia da corda. Lo scopo del canto drammatico è quello di rappresentar le passioni, le quali non si manifestano nell’uomo col suono dell’oboè, né del violino.
[40] Decima settima. Hassi a sbandire delle cadenze come un ornamento puerile quella che si chiama “recapitulazione dell’aria”, parola che o si risolve in una idea inintelligibile, o contiene un precetto insensato. La passione non epiloga mai se medesima né dispone i suoi movimenti secondo le regole dell’arte retorica del .
[41] Decima ottava. Gli abbellimenti che s’introducono debbono essere di vaga e leggiadra invenzione, perché il solo fine d’introdurli è quello di difettare; debbono innestarsi con graziosa naturalezza nel motivo acciocché non appaia troppo visibilmente il contrasto; debbono finalmente eseguirsi con esattezza inemendabile, poiché sarebbe strana cosa e ridicola che il cantore si dimostrasse inesperto nelle cose appunto ch’ei fa col solo ed unico scopo di mostrare la sua perizia.
[42] Se i maestri dell’arte invece di consultar la moda sempre capricciosa e incostante, o di abbandonarsi allo spirito di partito che non coglie nel vero giammai, avessero, siccome ho io cercato di fare, fissati i principi analizzando le idee ne’ suoi primitivi elementi, da una banda non si vedrebbero essi aggirarsi tastoni dentro al buio di mille inconcludenti precetti, e dall’altra la musica vocale si troverrebbe in Italia in istato assai diverso da quello che si trova presentemente. Però non diffido che dal lettore mi venga perdonata la lunghezza dello svagamento in attenzione alla sua utilità.
[43] Dicendo quello che dovrebber fare i cantori, ho detto
appunto quello ch’essi non fanno. Come se avessero in qualche scrittura fatta per mano
di notaio rinunziato solennemente al buon senso, così gli vedrete sovvertire e capo
volgere ogni parte del melodramma. Il recitativo dove la poesia conserva tutti i suoi
diritti, e dove l’imitazione è così prossima alla verità e alla natura, è la parte
ch’essi strapazzano più d’ogni altra. Ora profferiscono le parole con un certo andamento
uniforme e concitato che non a declamazione o a discorso naturale rassembra, ma a quelle
orazioni piuttosto che i fanciulli sogliono cinguettare presso al loro babbo. Ora
adoperano una cantilena perpetua che annoia insoffribilmente chi ascolta; ora scambiano
la quantità delle sillabe pronunziando breve la lunga, e lunga la breve; ora si
dimenticano nelle fauci o nel palato le finali delle parole profferendole per metà; ora
sconnettono il nominativo dal verbo che gli si appartiene, ovvero una parte
dell’orazione dall’altra in maniera che tante volte non si capirebbe punto la relazione
fra le parole né il significato loro se non venisse in aiuto il libretto per far ciò che
faceva il pittore di un castello chiamato Orbaneja rapportato nella storia di
Don Quisciotte, al quale, dopo aver dipinta una figura, riusciva
fanto fedele l’imitazione che gli abbisognava per esser capito scriver di sotto:
«Questo è un gallo»
. Nulla dirò della radicale monotonia e della
somiglianza perpetua che s’avverte sostituita a quella varietà d’intervalli e di tuoni
che vi si dovrebbe sentire in ciascun periodo, anzi in ciascuna sillaba secondo la
diversità delle parole e dei sentimenti. Se qualche differenza vi si osserva, questa
consiste solo ne’ vizi dissimili di chi gli recita. V’è chi lo dice in confidenza, chi
con una confusione che ributta. V’è chi affretta a guisa di chi vuol galoppare, v’è chi
mostra una milensaggine che vi par quasi debba convertirsi in ghiaccio prima di finire.
Chi sei mangia fra’ denti, chi lo canta ridendo. L’uno strilla, l’altro balbutisce e il
terzo scivola.
«… Ille sinistrorsum,hic dextrorsumabit, unus ubi bis Error».
[44] Ho udito alcuni cantori scusarsi di cantar male i recitativi accagionando i maestri, i quali coi rivolgimenti inaspettati del basso fanno aberrar la voce in luogo di guidarla. Sarà vero talvolta questo difetto ne’ compositori, ma ciò non basta a scolparne i cantanti, che quasi sempre lo cantano male oltre l’inciampar che fanno in mille altri vizi, i quali nulla hanno di comune col movimento del basso. Passiamo alle arie.
[45] Non negherò già che se il canto si prende in quanto è la maniera di modificare in mille guise la voce col maggior possibile artifizio e finezza, non abbia quest’arte ricevuto degli avvanzamenti prodigiosi in Italia. La leggerezza del clima, il tatto squisito dei nazionali in materia di musica, la lunga abitudine di giudicare e di sentire, la moltiplicità dei confronti, la lingua loro piena di dolcezza e di melodia, la sveltezza e agilità della voce procurata a spese della umanità sono tutte cause le quali hanno dovuto render gli Italiani altrettanto capaci a perfezionare questa spezie di talento quanto lo erano gli antichi Sibariti nel raffinar i comodi della vita, o quanto le moderne ballerine del Suratte descritte con penna rapida e brillante da uno storico filosofo lo sono nel preparar eruditamente le faccende multiformi della voluttà. cosicché l’arte di eseguire le menome graduazioni, di dividere il suono più delicatamente, di esprimere le differenze e gli ammorzamenti insensibili, di colare, di filare e di condurre la voce; di distaccarla, di vibrarla, e di ritirarla; la volubilità, il brio, la forza, le uscite inaspettate, la varietà nelle modulazioni, la maestria nette appoggiature, nei passaggi, nei trilli, nelle cadenze, nelle vocalizzazioni, siccome in ogni altro genere di ornamenti, lo stile dilicato, artifizioso, raffinato, sottile, l’espressione talvolta degli affetti più molli condotta fino alla evidenza; sono tutte meraviglie del cielo italico poste egregiamente in esecuzione da parecchi cantori viventi, abilità ch’io riconosco in loro e la quale tanto più volontieri confesso quanto più sono lontano dal voler comparire parziale od ingiusto.
[46] Dirò di più che in questa spezie di canto si sono eglino distinti a segno che non solo le nazioni moderne, tra le quali è incontrastabile che nessuna può venire in paragone coll’italiana, ma porto anche opinione che nemmeno quelle due antiche coltissime, la Greca e la Latina, pervenissero mai sul teatro all’artifizio e delicatezza di modulazione che si pratica a’ nostri giorni142.
[47] Ma se per canto s’intende l’arte di rappresentar modulando le passioni e i caratteri degli uomini talmente che vi si scorga chiaramente la verità dell’oggetto rappresentato come debbe pur esser l’uffìzio dei teatro e d’ogni canto imitativo, in tal caso non se ne sdegnino gl’Italiani se a nome della filosofia e del gusto francamente pronunzio aver essi, invece di giovare alla sua perfezione, guastata, pervertita, e corrotta la musica, non perché manchi questa di eccellenti qualità, ma perché ne fanno una pessima applicazione.
[48] Diffatti se l’imitazion teatrale si proponi due fini, l’uno la rassomiglianza della copia che imita coll’originale imitato, e l’altro la rassomiglianza dei muovimenti ch’eccita in noi la copia coi muovimenti ch’ecciterebbe l’originale; qual imitazion di natura è mai quella del canto drammatico dove la lontananza che passa tra l’originale e la copia è assai maggiore di quella che passerebbe tra due originali affatto diversi? Qual conformità ritruova l’orecchio non prevenuto dell’uditore tra il sentimento sublime, tranquillo e profondo che signoreggiava l’anima di Temistocle, allorché risoluto di morire prima di disonorare la sua memoria, prorompe in quelle inarrivabili parole:
«Serberò fra ceppi ancoraQuesta fronte ognor serena:È la colpa e non la penaChe può farmi impallidir.»
e quel sentimento medesimo cantato alla moderna, cioè facendo che Messer Temistocle si diverta per un quarto d’ora in mezzo ai trilli vezzosissimi e alle deliziose cadenze, le quali doveano pur convenire maravigliosamente in quella situazione ad un eroe combattuto? Qual somiglianza corre tra la sorpresa della smarrita Dircea allorché si confessa priva di senso non che di parole
«Divenni stupidaNel colpo atroce:Non ho più lagrime,Non ho più voce;Non posso piangere,Non so parlar.»
e l’interminabile loquacità musicale con cui s’esprime quello stato medesimo obbligando a gorgheggiar con mille semicrome quella che “non sa parlare”, e facendo or sù or giù rotolare la voce di colei che “non ha più voce”? Qual rapporto col suono grave e posato, col quale un uomo che fa riflessione alle funeste conseguente, che arreca l’abbandonarsi agli sregolati suoi desideri, deve pronunziar le seguenti parole:
«Siam navi alle onde algentiLasciate in abbandono:Impetuosi ventiI nostri affetti sono:Ogni diletto è scoglioTutta la vita è mar.»
coll’enorme guazzabuglio di note onde si vestono esse nel canto uscendo alla fine in un minuetto, o in un allegro, posciacchè il minuetto e l’allegro sono, come vede ognuno, il miglior mezzo possibile per enunciare una massima filosofica? Di siffatti solecismi musicali sono piene in tal guisa tutte le opere moderne, che l’accumulare gli esempi sarebbe, come dice un proverbio greco, lo stesso che portar vasi a Samo o nottole ad Atene.
[49] Ma l’imitazion che risulta dalla somiglianza del canto colla situazione del personaggio suppone forse troppo di studio e di gusto perché deva sperarsi dagli automati canori che si chiamano virtuosi di musica. Vediamo almeno se si trovi un compenso nell’altro genere d’imitazione che nasce dalla convenienza delle parti elementari del canto coi tuoni della favella ordinaria. Allorché l’uomo parla, il suo discorso si distingue precisamente per la maggior lentezza o rapidità nel profferir le parole o le sillabe, pel grado di acutezza o di gravità che vi si mette, e per la forza o remissione colla quale si notano le inflessioni. A questi tre elementi della voce umana corrispondono altrettanti nella musica. Il tempo esprime la velocità o la tardezza, il muovimento imita l’acutezza o la gravità, il piano e il forte rappresenta il diverso ricalcar che si fa sulle vocali. Ora siccome la natura e la combinazione degli accennati elementi non è sempre la stessa nell’umano discorso, ma variano entrambe secondo l’indole e il grado delle passioni, essendo certo che l’andamento per esempio della malinconia è tardo e uniforme, quello dello sdegno rapido e precipitato, quello delle passioni composte disuguale e interrotto; così nel canto dovrebbesi in ciascuna cantilena variare il tempo, il movimento e il ritmo musicale secondo l’espressione delle parole, e la natura dell’affetto individuale che si vuol rappresentare; né passar si dovrebbe dai tuoni più piccoli e bassi ai più alti ed acuti, né discender poscia da questi agl’imi senza la debita graduazione e verità di rapporto.
[50] Posti siffatti principi mi si dica di grazia qual
imitazione, qual convenienza col favellar comune apparisce nel canto moderno, dove a
rappresentar affetti e sentimenti contrari si pongono in opera li stessi capricci, che
dalla piebaglia armonica vengono chiamati ornamenti? Dove in un’aria dolente si
frammischian le stesse volate, gruppi e salti di voce che converrebbonsi ad un’aria
concitata? Dove esprimendosi nelle parole un equabil languore mi si salta all’improvviso
dal più basso al più acuto scorrendo molte volte tutta l’estension della voce con mille
impertinentissimi gruppi di note? Dove nel caldo maggiore d’un sentimento iracondo
allorché il cantore dovrebbe mostrarsi, a così dir, soffocato dalla sua stessa
prontezza, si ferma lentamente in un passaggio lunghissimo sfidando ad un combattimento
di gola le leccore e i canari? Dove questa fermata si fa non alla fine d’un periodo o
d’una parola, come vorrebbe il buon senso e il richiederebbe l’inflessione patetica, ma
in mezzo ad una parola o su una vocale staccata dalle altre? Dove il modulatore corrompe
i tuoni in maniera a forza di repliche, di passaggi e di trilli che ove ti brattava
d’imitar la tristezza o l’odio, mi si sveglia l’amore o la gioia? Dove col trinciar in
mille modi e agglomerare la voce si sfigura talmente il carattere degli affetti naturali
che più non si conosce a qual passione appartengano, onde ne risulta una nuova lingua,
che non intendiamo? Dove non si comprende che vi sia alcun linguaggio articolato, ma un
“a” o un “e” che corrono precipitosamente per tutte le corde e per tutte le scale
applicabili egualmente a parole ebraiche o latine che alle italiane? Dove all’aria
stessa cioè alla stessa passione che conserva la tinta e il colore medesimo si dà tutte
le volte che si torna da capo un tuono affatto diverso cambiando il tempo, il movimento
e il ritmo, quantunque il cambiamento non abbia punto che fare col basso e coi violini?
Dove troncando a mezzo il senso delle parole e lo sfogo degli affetti attende talvolta
che finisca l’orchestra che dia tempo ai polmoni di raccoglier il fiato per eseguire una
cadenza? Dove per il contrario s’impone silenzio alla orchestra, dando luogo al maestro
che levi la mano dal cembalo e che pigli tabacco, mentre il cantore va follemente
spasseggiando senza disegno per un diluvio di note? Dove questi si prende ad ogni passo
la libertà d’uscire da ciò che gli prescrive la composizione costringendo l’orchestra a
seguitarlo negli sciocchissimi suoi ghiribizzi? Dove in luogo che gli strumenti imitino
la voce, è piuttosto la voce umana quella che prende talvolta a gareggiare cogli
strumenti chiamando con eccesso di stolidezza a singolar tenzone ora una tromba, ora un
violino, ora un corno da caccia? Oh! Che sì che nel vedere la strana violenza che fanno i cantori al senso
comune avrebbe avuto ragion di esclamare «Quis tam ferreus ut teneat se?»
Che sì che l’aveva quel francese autore d’un poema sulla musica allorché disse parlando
della Italia:
«Orgueilleuse Ausonie, il le faut déclarerÀ la honte d’un art que l’on doit révérerMille insectes maudits dont tes villes abondentDe leurs sons venimeux de toutes parts t’inondent:Par un nombre d’auteurs de nos jours redoubléJe vois sous leurs fureurs ton pays accablé.»143
[51] Eppure (mi sento opporre da più d’uno) le vostre invettive sono altrettanti colpi dati al vento, poiché o imiti il canto, o non imiti la natura, sia esso o non sia conforme al senso delle parole, certo è che piace generalmente sul teatro, e che le arie cantate con le stranezze e le inverosimiglianze, contro alle quali vi scagliate sì fieramente, sono quelle appunto che riscuotono i maggiori applausi e che svegliano costantemente l’ammirazione del popolo. Una delle due cose adunque vi fa di mestieri accordare: o che le orecchie del pubblico non sono giudici in fatto di musica, lo che sarebbe un paradosso, o che i vostri sognati rapporti fra la rappresentazione e il rappresentato non sono punto necessari a produrre l’effetto.
[52] Ecco l’universale ma puerile sofisma, il quale ridotto in massima dalla ignoranza e avvalorato da uno spezioso pregiudizio, è quello che cagiona l’esterminio di tutte le belle arti. E quando mai, replicherò io a codesti fautori della irragionevolezza, e quando mai fu costituito il popolo per giudice competente del gusto ove si tratta di arti o di lettere? Da qual sovrana decisione, da qual tribunale emanò un’autorità così destruttiva dei nostri più squisiti piaceri? Il popolo può giudicare bensì del proprio diletto e compiacersi d’una cosa piuttosto che d’un’altra, nel che i filosofi non gli faranno contrasto, ma non è, né può esser mai, giudice opportuno del bello, il quale non viene così chiamato quando genera un diletto qualunque, ma allora soltanto che genera un diletto ragionato figlio della osservazione e del riflesso. Il piacere, che gustan nel canto moderno coloro che nulla intendono, non è altro che una serie di sensazioni materiali, a così dire, e meccaniche prodotte unicamente dalla melodia naturale inerente ad ogni e qualunque tuono armonico, e che si gode ne’ gorgheggi d’un rossignuolo al paro che nella voce d’un cantore. E se di questo solo piacere si parla, e di questo si contentano, e per questo solo vanno al teatro, appigliai eglino pure alle decisioni del volgo, che io non m’oppongo. Ma oh bellezza sovrumana della musica! Oh imitazione figlia del cielo! Io non mi presento inanzi al tuo altare con sì umili sentimenti. Allorché vado al teatro per tributarti un omaggio d’adorazione, io porto meco la non ignobil superbia esser uom ragionevole, e di voler conservare fin nell’esercizio della mia sensibilità i privilegi della mia natura. Io chieggo prima da te che, trasportando nel falso le sembianze del vero, tu mi seduca e m’inganni; che porti l’inganno e la seduzione al maggior grado possibile; che mi facci pigliar un inconsistente aggregato di suoni pei veri gemiti d’un mio simile, e che mi costringa a correre, come un altro Enea, per abbracciar il fantasma di Creusa invece del suo corpo. Tu devi poscia chieder da me, che svanita che sia l’illusione, io seguiti ancora a godere della compiacenza riflessa di essere stato ingannato; che ammiri la possente magia dei suoni che pervennero a farlo; che paragoni que’ punti di rassomiglianza col vero onde trasse origine il mio delizioso delirio; che sillogizzi comparando la voce che cantò colla passione o l’idea che voleva rappresentarmi; e che simile all’Adamo introdotto dal , dopo aver vagheggiata in sogno la bellissima sconosciuta immagine della futura compagna, confronti poi svegliato a parte a parte nell’originale il vivace lume degli occhi, l’oro dei capegli, le rose delle labbra, il latte della morbida carnagione e la tornita perfezion delle membra.
[53] Giudice non per tanto del bello solo è chi ad un tatto dell’anima squisito e pronto accoppia una robusta facoltà pensatrice, chi comprende ad un tratto la finezza non meno che la moltiplicità delle relazioni fra gli oggetti del gusto, chi sa dedurre da un principio sicuro una rapida serie di legittime conseguenze, in una parola chi porta in teatro o sui libri una mente illuminata non disgiunta da un cuor sensibile. Senza l’una e l’altra di queste doti tanto è impossibile il parlar aggiustatamente in materie di gusto quanto lo sarebbe ad un cieco nato il giudicar dei colori. Ma come attender tante e sì difficili qualità da un pubblico per lo più ignorante o distratto, il quale, siccome vede spesso cogli altrui occhi e sente colle altrui orecchie, così gusta non poche volte coll’altrui sensazione e non colla propria? Come sperarle da un udienza che va alle rappresentazioni drammatiche collo spirito medesimo che anderebbe ad una bottega da caffè, ad una conversazione o ad un ridotto, cioè per ispendervi quattr’ore in tutt’altro esercizio che in quello di arricchire la sua testa d’idee e il suo cuore di sentimenti? Come crederle in una union di persone, le quali per lunghissima e non mai smentita esperienza veggonsi applaudir sempre al cattivo e trascurar il buono? Correre in folla ai mostri chiamati tragedie del mentre lasciano solitarie sulle scene la sublime Atalia e la patetica Alzira? Deliziarsi estremamente con Arlecchino o Tartaglia, e sbadigliare alla rappresentazione del Misantropo? Tacciar di sforzato e seccagginoso , e poi commendare i… Nomi illustri ch’eravate per sortire dalla mia penna, la mia pietà vi risparmia! Un avanzo di compassione, che pur mi resta, mi consiglia a non privarvi del dolce inganno in cui vi tiene la vostra vanità, e a lasciarvi godere di quelli stolidi applausi, che sono l’unica ricompensa delle vostre comiche inezie.
[54] Mi si dirà che il quadro da me abbozzato comprende il volgo soltanto, non già il pubblico signorile e rispettabile, che forma per lo più l’udienza dell’opera. Nulladimeno a rischio di passare per un quakero della Pensilvania, o per un non ancora civilizzato pampa del Paraguay, io ripiglierò francamente che, ove si tratta di pronunziar un fondato giudizio su ciò ch’è bello nelle arti rappresentative, quel pubblico “signorile e rispettabile” non differisce poco né molto dal volgo. Sì; volgo è in materia di spirito la massima parte delle vezzose dame e dei brillanti cavalieri, ai quali
«La gola, il sonno, e l’oziose piume»
l’occupazione importantissima di amoreggiare, o la più importante
ancora del giuoco o degli abbigliamenti, o il trasporto pei cani o pei cavalli maggiore
talvolta di quella che hanno pe’ loro simili, o il frequente e piacevole conversar coi
buffoni non lasciano loro né il tempo necessario ad istruirsi, né l’abitudine di
riflettere, sebbene non tolgan loro per lo più la prosunzione di decidere. Volgo è la
massima parte delle persone civili che frequentano il teatro o per le stesse cagioni che
i precedenti, o perché gli affari urbani o domestici, o lo studio ad altre cose rivolto
non concedono loro l’agio d’attendere a così delizioso pascolo della sensibilità. Volgo
è nelle cose musicali quella razza di sapienti accigliati e malinconici che stampano su
tutti gli oggetti l’impronta del loro carattere, e che fatti per abitar piuttosto il
mondo di Saturno che il nostro si stimerebbono
rei di lesa gravità letteraria, permettendo che la mano incantatrice delle Grazie venisse talvolta a vezzeggiarli. E volgo è
ancora l’aggregato degli uditori maggiore assai di quello che comunemente si crede, i
quali indifferenti per natia rigidezza d’orecchio al piacere della musica, e disposti a
pesar sulla stessa bilancia e , e un
dozzinale suonator di festino, potrebbero interrogati sul merito degli attori rispondere
come fece quel bolognese che, trovandosi in Roma in una veglia
presso ad un tavolino dove giuocavano certi abbati di condizione sconosciuti a lui e
insorto fra i giuocatori un litigio intorno ad una giuocata cui egli non aveva potuto
badare per aver dormito fino a quel punto, richiesto all’improviso da un abbate:
«Che ne dice ella, signore? Chi crede abbia il torto fra noi?»
rispose
con faceto imbarazzo «Ah! sì, sì. Dice bene, V. S. Illustriss., tutti hanno
ragione egualmente»
.
[55] Che se a questa classe voglionsi aggiugnerc gli ippocriti di sentimento, quelli cioè che affettano di provar diletto nella musica per ciò solo che stimano esser proprio d’uomo, di gusto il provarlo: se noveriamo anche i molti che, invasati dallo spirito di partito, commendano non ciò che credono esser buono, ma quello soltanto che ha ottenuta la lor protezione; se vorremo separare i non pochi che essendo idolatri di un solo gusto e di un solo stile circoscrivono l’idea del genio nella esecuzione di quello, e rassomigliano a quel capo dei selvaggi, il quale stimando esser le sue campagne il confine del mondo, e se stesso l’unico sovrano dell’universo, esce ogni mattina dalla sua capanna per additar al sole la carriera che dee percorrere in quel giorno; si vedrà che alla fine dei conti quel gran pubblico signorile e rispettabile si risolve in un numero assai limitato di uditori che capaci siano di giudicare direttamente. E questi assai lontani dall’incoraggiare coi loro applausi i pregiudizi dominanti sono anzi della mia opinione, e se ne dolgono apertamente della decadenza della musica, e inveiscono contro i musici e i cantori che l’hanno accelerata.
[56] Coloro poi che dal piacere del volgo traggono un argomento
per conchiudere che ad eccitar l’interesse che può esservi nella musica nulla vaglia la
connessione fra le parole e il canto, cadono a un di presso nello stesso sofisma di quei
pseudofilosofi, i quali perché lo sfogo materiale dei sensi nell’amore viene
accompagnato da voluttà, pretendono che niun’altra cosa debba pregiarsi in quella
passione fuorché la voluttà momentanea. Questi insensati discepoli di mostrano d’ignorare che i diletti meccanici
dell’amore si riducono pressocchè al nulla qualora manchino loro l’influenza della
immaginazione, o l’energia del cuore, o l’entusiasmo generato dalle qualità morali.
Quelli non capiscono che il piacere sensitivo ed esterno che producono i suoni sull’uomo
considerato semplicemente come una macchina fisica organizzata per riceverli, non è per
alcun verso paragonabile con quell’altro diletto più intimo che producono nell’uomo
morale, cioè nell’uomo considerato come un essere capace di conoscere la simpatia di
certi suoni con certe affezioni dell’anima, e di prevalersi di siffatta cognizione per
metter in esercizio le proprie passioni. Cose tutte che non ponno provenire da una serie
indeterminata di suoni, ma dalla determinazione bensì che ricevono essi suoni dalle
parole, le quali, facendo vedere la dipendenza in cui sono gli uni dalle altre, eccitano
le stesse idee e i movimenti stessi ch’ecciterebbe la presenza degli oggetti
rappresentati. Perciò definì la musica
l’«arte della modulatoti convenevole»
, e comparò la poesia separata dal canto ad un volto che perde la sua
beltà passato che sia il fiore della sua giovinezza144. Lo stesso filosofo parlando
della corruttela dell’antica armonia e dell’antico teatro attribuisce l’una e l’altra
alla debolezza de’ poeti e dei musici, che presero per regola del bello nelle due
facoltà il piacere del volgo trascurando quello dei più saggi145. Un altro scrittore non
minore di lui concorre nella stessa opinione deducendo apertamente la perdita della
musica, come ancora delle virtù politiche in Atene, dall’aver
tolto di mauo alle persone di miglior qualità le arti ginnastiche e le musicali
conferendone al popolo l’esercizio e il profitto146. Due autorità così rispettabili avvalorate da una costante
esperienza bastano a dileguar pienamente un sofisma che può chiamarsi l’ancora della
speranza per gli ignoranti.
[57] Che poi mancando nel canto moderno le due spezie d’imitazione esposte di sopra debba altresì mancare la terza che deriva dalla somiglianza dei movimenti che sveglia in noi la copia coi movimenti che sveglierebbe la presenza dell’originale rappresentato, non occorre fermarsi a lungo per provarlo. Imperocché egli è certo che altra via non hanno le arti rappresentative per commuoverci agli affetti se non quella di colpir la nostra immaginazione nel modo stesso che la colpirebbero le cose reali e per gli stessi mezzi; onde se con altri stromenti viene assalita, o le si parano avanti idee in tutto contrarie a quelle delle cose, non è possibile a verun patto eccitare la commozione. Perlochè avendo fatto vedere che la musica vocale non corrisponde al suo oggetto, e che le volate, i trilli, le vocalizzazioni, e le cadenze, e i lunghi passaggi che costituiscono il principale abbellimento del canto moderno, non rappresentano i moti di veruna passione, resta (se mal non m’avviso) dimostrata abbastanza la sua incapacità nel muover gli affetti.
[58] Quindi si può render ragione della osservazione fatta prima in Inghilterra dal 147 poi di nuovo in Italia dal più volte lodato 148, cioè che prendendo a legger , a fatica si può lasciar dalle mani per l’impazienza in cui siamo di vedere il fine di qualunque sua tragedia tanto ci intenerisce, attacca, e sospende la sua lettura, ma sentitolo cantare in teatro dai virtuosi restiamo indifferenti, né ci sentiamo punto rapire dall’interesse o dalla curiosità. La qual cosa non altronde deriva se non da ciò che il canto drammatico colle sue stranezze e inverosimiglianze sfigura in tal modo il senso delle parole, che tolta ogni connessione colla poesia, altro non rappresenta fuorché un quadro arbitrario e in tutto diverso. Quindi la contraddizione con noi medesimi e colla nostra sensibilità in cui ci pone il canto; poiché essendo certo che appena avremmo potuto frenare le lagrime per la compassione se fossimo stati presenti all’addio di Megacle e alle smanie di Timante, noi sentiam pure modular sul teatro il medesimo addio e rappresentar quelle smanie stesse non solo senza piagnere, ma sbadigliando, o ridendo, o facendo qualche cosa di peggio. Quindi la sorpresa mista di sdegno colla quale uno straniero nuovo alle impressioni riguarda l’insulto che si vuol fare alla sua ragione dandogli ad intendere che i soli Italiani hanno colpito nel segno, e che ad essi unicamente appartiene il conservar il deposito della bellezza musicale; asserzione, che vien provata da loro esagerando i pregi di questo brillante spettacolo, ma che resta subito smentita dall’intimo sentimento di chi gli ascolta, poiché invece della sublime illusione che gli si prometteva, invece di trovar quel congegnamento mirabile di tutte le belle arti che dovrebbe pur essere il più nobil prodotto del genio, altro egli non vede nell’opera fuorché una moltitudine di personaggi vestiti all’eroica, i quali vengono, s’incontrano, tengono aperta la bocca per un quarto d’ora, e por partono senza che lo spettatore possa capire a qual fine ciò si faccia, riducendosi tutto, come l’universo nel sistema di , a pure apparenze o prestigi. Quindi l’incertezza e varietà con cui si giudica d’una stessa composizione o d’un’aria, poiché non trovandosi un rapporto esatto fra l’imitazione e l’oggetto imitato, il pensier musicale dell’aria non meno che la sua esecuzione restano applicabili a cento cose diverse; dal che avviene che il gusto dello spettatore abbandonato a se stesso ora fa l’applicazione in un modo, ora in un altro, e diversamente in ognuno.
[59] La riflessione ultimamente accennata potrebbe, se mal non m’appongo, sparger qualche lume sul quesito che ho udito farsi da molti onde tragga origin cioè la rapidità con cui si succedono i gusti nella musica, i quali si cambiano non solo da secolo a secolo, ma da lustro a lustro, e perché siffatti cangiamenti siano più visibili in essa che in qualunque altra delle arti rappresentative. Io non posso trattenermi a dir tutto ciò che mi somministrerebbe un argomento così fecondo, il quale non potrebbe trattarsi a dovere senza lo scioglimento di molte questioni preliminari. Converrebbe cioè prima di tutto sapere se vi sia un genere di musica assoluto e universale, che debba piacere ugualmente in tutti i tempi, e presso a tutti i popoli della terra; se il diletto che genera la musica sia un diletto di educazione fattizio, oppure inerente all’azione intrinseca di quell’arte; se il carattere vago e arbitrario, del quale vien rimproverata la musica, sia peculiare della nostra oppure di ogni altra musica conosciuta finora; se il fondamento di tale accusa si debba ripetere dall’armonia o dalla melodia ovvero dall’una e dall’altra; se consista nell’uso che si fa delle consonanze o nella illimitata licenza che si prendono i musici nell’adoperare le dissonale; se provenga dalla mancanza in natura d’un suono generatore fisso e determinato che possa riguardarsi come principio inalterabile degli altri suoni; se la perdita della prosodia poetica possa aver contribuito a render l’azione della musica vaga ed incerta; se vi sia probabile speranza di dare una maggiore stabilità e fermezza ai gusti musicali ecc.
[60] Dirò soltanto che la varietà delle opinioni e il rapido loro cangiamento nasce dal principio medesimo che fece degenerar il teatro italiano nel secolo scorso. Il maraviglioso introdottovi non rappresentando alcun essere conosciuto in natura, né apportando seco alcun modello reale, al quale potesse rifferirsi dallo spettatore, prese quella forma e travvisamento, che vollero dargli la svogliatezza, l’immaginazione e il capriccio. Così nel canto moderno mancando la verità della espressione perché le modulazioni imitative sono troppo lontane dalla natura, altro diletto non resta se non quello che viene dal gradevole accozzamento dei suoni diretti non già a significar un pensiero, o ad eccitar una determinata passione, ma a piacere all’orecchio colla loro varietà e successione. Quindi non è da maravigliarsi se l’uditore, il quale prende i suoni per se stessi e non per quello che rappresentano, cerca appunto nella diversa combinazione di essi quel piacere, che non può ricavare da una poco intesa e mal conosciuta imitazione. E siccome dicesi a ragione che una è la strada della verità e quella dell’errore moltiplice, così, posta la disconvenienza delle modulazioni cogli oggetti naturali, ne vengono in conseguenza la necessità di cambiarle sovente per non infastidir l’uditore, la tortura che si danno i cantori per trovar cose che lusinghino le orecchie colla lor novità, e la varietà de’ gusti che da ciò ne risulta. Non avviene talmente nelle altre arti rappresentative come sono la scultura, la pittura e la poesia, o almeno non avviene così frequentemente, perocché in esse l’oggetto, cui si rapporta l’imitazione, è più vicino, e le relazioni sono più chiare, onde il gusto può aver un fondamento meno arbitrario. Della bellezza della Venere de’ Medici non meno che della perfezione del Misantropo di io giudico per la comparazione cogli oggetti che mi cadono sotto gli occhi. La proporzione fra le membra, la dilicatezza dei tratti, la bocca, le braccia, le mani, ciascuna parte insomma ha degli originali nella società che servono, a così dire, di puntelli al comun paragone, come l’hanno parimenti, e assai spesso, i caratteri di Climene, di Alceste, di Filinto, di Trissotino, di Vadio, e gli altri che si trovano in quella inimitabil commedia. Poco ci vuole a ravvisarli e non molto a farne il confronto. Ma nella musica, mercè al soverchio raffinamento cui si è voluto condurla, la verità della espressione è così poco adattata alla capacità della maggior parte, così poco riconoscibile l’imitazione, che necessario è che ondeggi anche il gusto fra tanti e sì discordi giudizi. Però mentre l’Apolline di Belvedere, il Laocoonte, e l’Ercole servono di modello tuttora agli statuari dopo tanti secoli; mentre la Venere di Tiziano, il S. Pietro di Guido, e la Madonna del Correggio riuniscono concordemente i suffragi de’ pittori; mentre un frammento di , un’oda di , una elegia di , un idilio di , un’ottava d’ e di , un sonetto di , le lagrime di Priamo inginocchiato avanti Achille, l’episodio della morte d’Eurialo nella Eneide si gustano pure, e s’assaporiscono perché spirano ancora la lor primitiva freschezza; niuna composizion musicale, niuna cantilena è, non dirò dei Greci o dei Latini, ma né meno dei moderni da fino al principio del nostro secolo, che si conosca, non che s’uniti sul teatro o in chiesa dai maestri o dai dilettanti. Le composizioni stesse dei primi maestri del nostro secolo sono oggi mai divenute anticaglie, non piacendo altro che lo stile dei moderni cantori, il quale nel giro di pochissimi anni dovrà cedere anch’esso ad un nuovo gusto che dee succedere sicuramente. Ed ecco un motivo di più della diversità delle opinioni in questo genere, il non rimanere cioè alla posterità un classico esemplare, che fìssi immobilmente lo studio dei giovani, perché dipendendo in massima parte la bellezza del canto dalla maniera di eseguirlo, questa non può conoscersi fuorché nella viva voce del cantore, morto ch’ei sia, il voler giudicare del suo merito dagli scritti che restano è lo stesso che giudicare delle bellezze di Elena sul suo cadavero. Così che niente v’ha di più inutile che il voler risapere lo stile di , di , di , o di da qualche composizion musicale publicata da essi. La mano del tempo, che stampa orme profonde di distruzione sù tutta la natura, perdona molto meno ai suoni rapidi e fuggitivi, e il canto prodigioso di quei cantori simile nella incostanza all’elemento dove fu generato dopo aver eccitata una serie di sensazioni transitorie al paro di lui andò a perdersi fra le infinite passaggiere vibrazioni, che prodotte a vicenda e cancellate dall’urto de’ corpi sonori rimasero inerti alla fine e mutole nell’abisso del nulla.
[61] Con ciò si risponde all’obbiezione di coloro i quali vedendo che le arie de’ trapassati maestri riescono fredde e disanimate quando s’eseguiscono col metodo moderno argomentano che la musica della nostra età è superiore di molto a quella degli altri tempi. Non vogliono riflettere che la più bella musica del mondo diventa insipida qualora le manchi la determinata misura del tempo e del movimento, che troppo è difficile conservar l’uno e l’altro nelle carte musicali prive dell’aiuto del cantore e della viva voce del maestro, che in quasi tutte l’arie antiche abbiamo perduta la vera maniera d’eseguirle, onde rare volte avviene che il movimento non venga alterato o per eccesso o per difetto, e che il gusto del cantore che s’abbandona a se medesimo nell’atto di ripeterle non può a meno di non travvisarle a segno che più non si riconosca la loro origine. Quindi a molti in Francia è venuta in pensiero la necessità d’un cronometro, ovvero sia pendolo destinato a misurar esattamente i movimenti nella musica, il quale al vantaggio di regolare anche nelle arie che si cantano in teatro la voce del cantore colla natura del suo movimento e col numero delle vibrazioni acciocché fregni tra l’orchestra e lui quella unione che vi si vede troppo soventemente mancare aggiungerebbe l’altro di potersi col suo mezzo trasmettere ai paesi lontani e alle future età il preciso grado del movimento con cui furono eseguite. ne’ suoi Principi di Musica dedicati alle dame religiose avea posto alla testa di tutte le arie altrettante ziffere, ch’esprimevano il numero delle vibrazioni del suddetto pendolo durante ciascuna misura149.
[62] Mio desiderio sarebbe di poter pubblicamente render giustizia in questo luogo a quei cantori viventi, che scevri del contagio comune ci porgessero altrettanti esemplari imitabili del vero canto drammatico. Ma l’austera verità, alla quale fa d’uopo che un autore sacrifichi fino ai primi movimenti d’un cuor sensibile, mi trattiene dal farlo. No: avvenga che molti siano i cantori da me sentiti in Italia creduti bravissimi (e che sono tali secondo l’idea che si ha comunemente della bravura) non ho trovato neppur un solo, il cui canto non sia più o meno imbrattato dei vizi esposti nel presente capitolo. Vi saranno al certo delle eccezioni a questa regola, ma non le conosco. Trovandosi tutti lontani dal retto sentiero, la maggior grazia che può loro farsi è quella di giudicarli per approssimazione. Tra gli altri molto si parla di Marchesi e di Pacchierotti, i quali con istile e gusto diverso tengono divisi ancora i giudizi del pubblico. Non è di mia competenza il decidere, ma se le descrizioni fattemi della loro maniera di cantare non sono state alterate, se le idee universali del bello non mi tradiscono, se l’amore del semplice, dell’appassionato, del vero non m’hanno incallito l’orecchio contro le seduzioni di uno stile pieno di artifizio e di sorpresa, Pacchierotti, oh patetico Pacchierotti! quantunque il tuo rivale ti superi in molte qualità brillanti, tu saresti il solo genio vivente, cui cingerei le chiome del vivace allora onde l’antica Grecia coronava le statue d’Arione e di Tamiri.
Capitolo decimoquinto §
Terza causa. Abbandono quasi totale della poesia musicale. Esame de’ più rinomati poeti drammatico-lirici dopo il . Stato dell’opera buffa.
[1] Le scienze, che hanno per oggetto la ricerca del vero, e le facoltà, che hanno per fine il perfezionar il gusto, corrono, allorché vengono coltivate in una nazione, delle fortune affatto diverse. Le prime, qualora siasi trovato il vero metodo di studiarle, e si seguiti a mantenerlo, acquistano maggiori progressi a misura che maggiore è il numero degli studiosi che le coltivano; imperocché dipendendo l’avvanzamento di esse o dalla moltiplicità e verificazioni e de’ fatti replicati, o dalle deduzioni che si cavano da un principio riconosciuto come incontrastabile, tutti sono in istato di rilevare l’esattezza di quelli, e d’aggiugnere loro maggior lume colle proprie scoperte, come molti possono ancora far una convenevole applicazione di questo. L’algebra dunque, la geometria, la nautica, l’idrostatica, l’astronomia, la medicina, la fìsica e le altre scienze consimili colà si veggono maggiormente avvanzare e fiorire dove lo studio è più universale, i tentativi più costanti e più frequenti, e la libertà nell’opinare è meno ristretta. Debbonsi nonostante escludere da questa regola la teologia e la metafisica. La prima, perché appoggiandosi principalmente sull’autorità e sul positivo, qualora si slontani da quei due punti polari, va a rischio di smarrirsi per via o di sfasciarsi in un laberinto di diverse opinioni contrarie non meno al conseguimento del vero che ai vantaggi della religione. La seconda, perché pochi essendo i principi veri sui quali s’appoggia e dipendendo in parte dalle nozioni di certe idee oscure di sua natura non ancor definite né da tutti universalmente accettate, non può far di meno che non divenga arbitraria e vaga nelle sue conseguenze. Ond’è che la regione de’ metafisici è per lo più la regione degli errori, e che per ogni spirito ben fatto l’annunziargli un nuovo sistema in quella scienza non è diverso dal proporgli una nuova modificazion di falsità.
[2] Nelle facoltà che hanno per oggetto il bello, avviene l’opposto che nelle scienze. In queste l’arte di riuscire dipende tanto dalla particolare organizzazione di chi le coltiva, dal maggior o minor grado di sensibilità e di fantasia, dall’attuale disposizione di coloro che ricevono le impressioni, e dalle idee dominanti in una nazione o in un secolo; le relazioni loro sono così fine, così complicate, così difficili; la natura ch’esse prendono a imitare si ripiega, s’asconde e si mostra in sembianze così differenti or nel morale or nel fisico, secondo le abitudini, gl’interessi, le passioni, i climi, e i governi che a superare cotanti ostacoli non basta un talento mediocre, ma vuolsi tutta l’estensione e l’energia del genio. Però mentre un uomo di mente assai limitata può colla fatica e lo studio aggiugner qualche particella di più alla massa generale del sapere nelle scienze naturali, e distinguersi per questo mezzo dagli altri, nessun ingegno di bassa lega per quanta cura ei ponga nell’esercitare le facoltà che riguardano il bello otterrà giammai i suffragi del pubblico, perché non sarà trovato capace di poterle promuovere una sola pedata. Ed ecco il fondamento della massima di , colà dov’ei dice che né gl’iddi, né gli uomini, né le colonne permettevano a’ poeti di essere mediocri150.
[3] Ora i sommi geni sono assai rari in qualunque genere. Talvolta molti secoli scorrono senza che la storia possa annoverarne uno solo. La pianta dell’aloè, che sta cent’anni a germogliare, altri cento a rinvigorirsi e un secolo poscia fino al suo dicadere è in generale l’emblema dell’origine, progressi, e annientamento delle arti del gusto e di coloro che le perfezionano. Qualora suppongasi non pertanto che la loro coltura diviene comune in un popolo, questa supposizione non può andare disgiunta dal sospetto della loro mediocrità, perocché abbandonate fra le mani del volgo o trattate da ingegni inferiori incapaci di sollevarsi fino a quell’altezza che richiede la loro natura, non può far di meno che non divengano triviali anch’esse, e che non contraggano la piccolezza e i pregiudizi di chi a dispetto pur di Minerva le vuol coltivare. In tal caso le arti e le belle lettere sono come i vaghissimi colori dell’iride allorché si riguardano a traverso d’un prisma non ben dirozzato.
[4] Ecco appunto lo stato in cui presentemente si trova la poesia italiana. Una folla di poeti, i quali, per valermi d’una espressione di , nascono in Italia all’usanza dei funghi, piove ogni giorno sulle pazientissime orecchie del pubblico un diluvio di canore inezie, di sonetti e di canzoni, ch’essi hanno la temerità di chiamare anacreontiche, petrarchesche, o pindariche, quantunque convenga loro siffatta appellazione colla stessa giustizia a un dipresso che convengono ad alcuni principi asiatici i titoli che scambievolmente si danno di signori del corno della luna, o di dominatori degli elefanti. Non potendo più applicarsi con frutto la più deliziosa fra le arti d’imitazione ai grandi oggetti della morale, della legislazione e della politica, come si faceva dai Greci, né trovandosi oggimai animata da quello spirito vivificante, che seppero in essa trasfondere i , i , i , gli , e i , si vede in oggi ridotta la meschinella a servir di patuito insignificante complimento per ogni più leggiera occasione di sposalizio, di monacazione, di laurea, di nascita, di accademia, e di che so io, senza che altre immagini per lo più ci appresenti fuor di quelle solite della fiaccola d’imeneo che rischiara il sentiero alle anime degli eroi, i quali attendono impazienti lassù nelle sfere il felice sviluppo del germe, o di quel cattivello d’Amore che spezza per la rabbia lo strale innanzi alle soglie che chiudono la bella fuggitiva, o di Temide che avvolta in rosea nuvoletta fa trecento volte per anno il viaggio dell’Olimpo fino al collegio dei dottori a fine di regalare la bilancia e la spada a saggio ed avvenente garzone, o della povera Nice, cui si danno dagli amanti più epiteti contradditori di pietosa e crudele, d’empia e benigna, di fera e di scoglio, di Medusa e di Aurora, d’angioletta o di tigre che non iscagliò contro a Giove il famoso Timone nel dialogo di . Immagini tutte le quali benché fossero belle nella loro origine, e capaci di produrre un piacere inaspettato allorché aveano il pregio della novità: sembrano
«Sogni d’infermi e fole di romanci»,
ora che lo spirito non rigusta più né il diletto che nasce dalla sorpresa, né quello che viene dal riflesso della loro convenienza. Da ciò deriva lo spirito d’imitazione e il ricopiarsi l’un l’altro necessario nella massima parte perché la massima parte scarseggia di ricchezze proprie. Da ciò ancora la monotonia di pensare e di scrivere, dalla monotonia la servilità, da questa il languore e non molto dopo il tedio dei lettori sensati che compresi da giustissimo sdegno condannano al ben meritato avvilimento l’arte e gli artisti, gli accademici e le accademie, le lodi e chi le dispensa151.
[5] Tra i generi però della poesia niuno v’ha più vilipeso e negletto che il dramma musicale. È cosa da stupire la contraddizione degli Italiani in questo punto. Mentre tanto si deliziano nello spettacolo, mentre si vantano di essere quei fortunati coltivatori che l’hanno sollevato alla maggiore perfezione possibile, mentre si dimostrano pieni di entusiasmo per tutto ciò che ha riguardo alla musica, soffrono ciò nonostante che la parte poetica primo fonte della espressione nel canto e della ragionevolezza nel tutto, giaccia obbrobriosamente in uno stato peggiore di una prosa infelice e meschina, in uno stato dove né il teatro conserva i suoi diritti, nè la lingua i suoi privilegi, in uno stato dove la musica non ritrova immagini dà rendere né ritmo da seguitate, in uno stato dove la ragioni non vede alcuna connession fra le parti, né il buon senso alcun interesse fondato nelle passioni, in uno stato finalmente dove s’insulta ad ogni passo alla pazienza di chi assiste alla rappresentazione, e al gusto di chi la legge. Gli insetti della letteratura, coloro cioè che ronzan dintorno alle più fangose paludi del Parnaso, sono appunto i soli che ardiscano a metter mano in una spezie di poesia la più scabrosa, la più dilicata, la più diffìcile di quante possa offrire la ragione poetica. Non vi dovrebbe essere il più arduo, ma non v’è in pratica impegno più triviale che il divenir autore d’un libretto dell’opera; titolo del quale, riconoscendo eglino tutto il valore, lo tacciono a bella posta sul frontespizio per quell’istinto che porta gli uomini a celar le proprie vergogne. Ed è ben ragione che il loro destino non sia punto migliore della loro capacità. Vili schiavi dell’impresario, del compositor, del cantore non hanno di poeti fuorché il nome, e l’obbrobrio di profanarlo. Chi compone drammi per musica è oggimai divenuto un fanciullo di scuola che non può discostarsi dalla riga senza tema di battiture, un fenomeno di questa natura merita che ci fermiamo alquanto per isvilupparne le cagioni. A due (per quanto giungo a comprendere) si riducono queste. Alla voga che ha preso in teatro il moderno canto, e al gusto eccessivo per le decorazioni. Esaminiamo l’una e l’altra paratamente prima nell’opera seria, indi facendo passaggio alla buffa.
[6] Si è parlato a lungo nell’antecedente capitolo del dominio che s’usurparono sulla scena i cantori, si è mostrato per quai mezzi pervennero ad ottenerlo, e si è trovata la radice dell’abuso nel trascurar i recitativi, nel porre ogni loro studio nel canto delle arie, e pello sfoggiare su queste con mille artificiosi sminuzzamenti di voce. Posto questo principio chiaramente si scorge che il canto è il dominante oggidì nel melodramma, che su questo perno si raggira tutta l’azione, che 1a poesia ubbidiente allo stabilito sistema non è altro che una causa occasionale, un accessorio che dà motivo alla musica ma che dipende affatto da essa, e che per conseguenza, rinunziando ai propri diritti per modellarsi su quelli della padrona, ha dovuto metter in non cale la condotta, lo sceneggiar, l’orditura, trasandar lo stile e la lingua, perder mille situazioni vive e appassionate e accorciar i recitativi divenuti ormai fastidiosi e languidi, in una parola strozzar i componimenti per badar solo al pattuito cerimoniale di mezza dozzina d’arie cantabili, d’un duetto, d’un trio, o d’un finale tratto, come suol dirsi, pe’ capegli. E piacesse al cielo che queste arie, questi duetti o questi finali isolati fossero tali almeno che colla loro vaghezza, novità od interesse ci ricompensassero dei sagrifizi che si fanno del buon senso in grazia del canto; terremmo allora con essi il costume, che suol tenersi col frammenti della greca scultura de’ quali in mancanza d’una intiera statua s’ammira pure e si custodisce un braccio solo, una gamba, od una testa. Ma il fatto è che quelli squarci staccati sono egualmente cattivi e peggiori forse che non è il restante. Dico peggiori poiché oltre l’esser privi di colorito poetico, oltre non aver armonia né stile né numero, altro poi non racchiudono fuorché pensieri triviali e insignificanti, ribattuti un millione di volte, e simili sul teatro ai sonetti che s’attaccano sulle colonne in occasione di laurea o di sposalizio.
[7] La poesia e la musica si sono ristrette a vicenda formandosi certi cancelli poetici e musicali che mantengono nella più servile mediocrità l’una e l’altra. Quantunque la musica sembri avere per oggetto diretto tutto ciò ch’è suono, e per indiretto molte cose che non lo sono, tuttavia questa idea generale si circoscrive di molto qualora si parla del canto rappresentativo in un’azione drammatica. Imperocché egli è necessario allora non considerare il gran numero di que’ corpi sonori, di quegli esseri fisici della natura che si rappresentgno cogli sgomenti e non colla voce. Bisogna altresì non pensare ai rapporti intrinseci che hanno i suoni fra loro, rapporti che formano, a così dire, la metafisica e l’algebra della musica, ma la cognizione de’ quali non è altrimenti necessaria al cantore. Né si dee far menzione di quella spezie di melodia o sensazione aggradevole prodotta da qualunque vibrazione sonora, e che fatta per lusingare unicamente l’orecchio va disgiunta da ogni idea d’imitazione. Ecco non per tanto che sottraendo dalla musica vocale gli accennati uffizi, il suo impiego si restringe solo a imitar i tuoni della umana favella. Ma il peggio è che non ogni favella, non ogni tuono di essa è proporzionato al canto. Lo sono unicamente quelli che hanno inflessione chiara e sensibile cosicché la loro espressione porti seco un significato da per se che non si confonda con verun altro. Lo sono i tuoni variati e distinti o per la loro gravità ed acutezza, o per la loro lentezza e velocità, essendo certo che un uniforme e per qualunque circostanza non mai alterato grado di voce non potrebbe divenir oggetto d’imitazione per la musica. Lo sono gli accenti che formano il tuono fondamentale d’una passione o un sentimento, poiché se l’anima ha per ogni sua affezione un movimento generale che la caratterizza, anche la musica, dovendo esprimere cotal movimento, avrà un tuono fondamentale che le serva di regola. Lo sono finalmente tutti i tuoni analogi al fondamentale, o che nella progressione armonica vengono generati da esso; poichè ciascun di loro corrisponderà colla sua individuale espressione ad eccitare i muovimene individui compresi nell’andamento generale della passione. E questa è la cagione per cui la semplice declamazione poetica scompagnata dal canto è naturalmente meno espressiva che non è la musica; cioè perché non trovasi in lei una moltitudine si grande di tuoni, i quali imitino fisicamente i muovimenti dell’anima. In contraccambio ha ella il vantaggio di sembrarci più verosimile e più conforme alla natura, dal che ne viene in conseguenza che sebbene la declamazion recitata abbia minor azione sopra i sensi, è bensì più acconcia a produrre in noi la persuasione, e pertanto ha molto maggior influenza sullo spirito. Da ciò ne ricevono ancora una ulteriore conferma i principi stabiliti altrove152 circa gli argomenti propri del melodramma e circa la natura dei personaggi dove si fece più diffusamente vedere che i lunghi racconti, le deliberazioni, le trame, i consigli, le discussioni politiche, morali e filosofiche, tutto quello che v’ha nell’umano discorso di tranquillo e d’indifferente non si conviene al canto, come non gli si convengon neppure le passioni sordide e cupe, i caratteri freddi, contiposti, severi e dissimulati, quegli oggetti insomma i quali benché non siano afoni di sua natura, lo sono tuttavia rispetto alla musica vocale, perché non le offrono varietà né chiarezza di accento. Ed ecco un’altra non piccola sottrazione da farsi nella materia opportuna per la melodia drammatica, la quale, come più volte si è replicato, non può afferrare nella sua imitazione fuorché i tratti originali e precisi delle passioni.
[8] Nonostante la mentovata scarsezza di esemplari imitabili resterebbe ancora alla musica una più che competente ricchezza, se la poesia meno schiava nella scelta degli argomenti le somministrasse tutta la copia di situazioni espressive ond’ella potrebbe servirsene. Se i Greci, non avvisandosi di eccitar nelle loro tragedie altri movimenti che il terrore e la pietà, ebbero pure un teatro sì patetico, sì variato e sì ricco, con più ragione dovrebbero averlo i moderni, i quali avendo adottato un sistema drammatico più dilatato perché più conforme al presente stato politico della società, non si sono limitati alla rappresentazione di quelle due sole passioni, ma hanno con felicissimo evento fatto sentir sulle scene l’ammirazione, la pietà, la tenerezza, l’amicizia, la gloria, l’amor coniugale, l’amor figliale, l’amor della patria con più altri affetti consimili sconosciuti nella maggior parte dei componimenti di , di , e di . E certo che la varietà degli affetti e la copia de’ caratteri da noi rappresentati non ha contribuito poco ad ampliar la sfera della musica, e che Temistocle, Arbace, Aristea, Megacle, Zenobia, Ipermestra, Timante e Cleonice non hanno aperto men fertile campo né meno leggiadro alla melodia di quello che a lei aprissero in Atene i caratteri di Ecuba, Oreste, Edipo, od Ajace. Ma per un difetto prodotto dai costumi ora dominanti fra noi, la poesia non osa più trattar argomenti che non versino sull’amore, e che non si rivolgano intorno ai sospiri, ai lamenti, e alle nenie di quella passione. E ciò perché? Perché un inveterato costume vuole che in ogni opera devano comparir sul teatro due donne e talvolta anche tré, della metà delle quali non sapendo che farsi il poeta perché inutili affatto all’intreccio, né qual occupazione dar loro, bisogna pure che pensi a trovar un paio d’amanti coi quali si vezzeggino a vicenda insipidamente. Vedendosi egli a tali angustie ridotto, e costretto a riserbare pei due primi personaggi le modulazioni più vere e più appassionate, che altro può metter in bocca agli attori subalterni se non sentimenti freddi e comuni da accompagnarsi parimenti con musica insignificante e noiosa? Anche esprimendo i caratteri principali non può far a meno di non coincidere spesso e ripetere le cose medesime, perché le situazioni sono a un dipresso le stesse in tutti i drammi, e perché gli uomini posti ineguali circostanze sempre si spiegano nella guisa medesima. Tanto più nella passione amorosa, la quale come chè sia la forte e la più intensa della natura, è tuttavia la meno estesa, uno solo essendo l’oggetto che la determina e semplicissimi i mezzi. Però forniti che siano quei pochi tratti caratteristici che distinguono quella tal situazione, i protagonisti cadono anch’essi in idee comuni applicabili a cento casi diversi, e incapaci per conseguenza di svegliare un vivo interesse. Non somministrando il cuore altri sentimenti che quelli che può infatti somministrare, fa di mestieri sostituire il linguaggio della immaginazione e dello spirito che signoreggiano ampiamente nel teatro moderno, dal che deriva la rovina della musica e della poesia; poichè siccome questa altro non fa sentire per il comune che l’“idolo”, il “nume”, il “rio destino”, le “stelle infauste”, gli “astri tiranni”, le “ritòrte”, le “catene”, la “prigionia d’amore” con siffatti riempitivi dell’affetto e del metro, così quella si riduce quasi tutta ad ariette inzuccherate e a rondò. Nella poesia musicale italiana si verifica esattamente quel verso che applicava ad un suo compatriota
«Et jusqu’à “je vous hais”, tout s’y dit tendrement»,
tenerezza che sebbene talvolta da vera passione proceda, non è per lo più che un linguaggio convenzionale posto in uso dalla galanteria, la quale è per il vero amore ciò che l’ippocrisia è per la virtù153.
[9] Questo abuso è stato poi abbracciato dai compositori drammatici perché favoreggia mirabilmente la loro ignoranza e s’accomoda più d’ogni altro alla loro inerzia. L’anzidetto pattuito gergo cava d’impaccio il poeta in mille occasioni. Non sa egli come condurre avanti un’azione priva d’interesse? Un intrico amoroso gli servirà di supplemento. Gli mancano parole da mettere in bocca a’ suoi personaggi? Basta fìngerli innamorati che larga materia di discorso sapranno essi trovare ricorrendo ai luoghi topici della galanteria. Vuol proccaciarsi la protezione e il favore delle giovani spose delle vezzose dame, delle spiritose e amabili cantatrici? Egli sa per una lunga esperienza che ad ottener ciò non havvi mezzo tanto opportuno quanto il titillare sovente le loro dilicatissime orecchie con siffatti bei concettici graziosini, piccinini, tuttti pieni d’amorini. Lo stesso dico delle similitudini posticcie attaccate in fine delle scene, lo stesso del numero e qualità dei personaggi, lo stesso della maniera d’intrecciare l’azione e dell’orditura di essa, cose tutte lavorate sul medesimo disegno e che dispensano il poeta dal badare alla retta imitazione della natura e alle difficoltà che presenti un tragico lavoro accontiamente eseguito. E che importa a lui della unità di pensiero e d’argomento tanto raccomandata dai gran maestri? Che della semplicicità de’ mezzi, della verità dei caratteri, della eleganza dello stile, della pittura del cuor umano e della forza ed evidenza delle passioni quando ha trovato il segreto di salire in Parnaso con minore fatica, e di essere incoronato d’un più facile benché men durevole alloro?
[10] In siffatta povertà di espressione poetica e musicale cagionata non da vizio inerente al melodramma, ma dagli abusi accidentalmente introdottivi, il gusto, che vuol pur trovare un compenso ne’ suoi piaceri, va riponendo l’essenziale in ciò ch’è meramente accessorio. Gli abiti, i lumi, le decorazioni, le comparse, i cangiamenti di scena, queste sono le bellezze che si sostituiscono in oggi sul teatro italiano al piano sì felicemente seguitato e con tante grazie abbellito da . La poco avventurosa riuscita dei poeti che hanno voluto imitare quell’insigne scrittore ha fatto attribuir al melodramma i difetti della loro incapacità, e perché non hanno essi saputo superare gli inciampi i che offrono nel presente stato della musica gli argomenti storici nel condurre passabilmente un’azione, si è con troppa fretta conchiuso che gli argomenti tratti dalla storia e il sistema generale dell’opera italiana non si confacciano più colle circostanze del teatro. Al che aggiugnendosi la vincitrice influenza del nome francese e i brillanti sofismi di alcuni loro filosofi altrove da me confutati154 gli Italiani cominciano a rinunziare alle bellezze del proprio paese per adottar le foggie straniere, modellando cotesta singolar produzione del cielo italico sul gusto degli abitatori della Senna. Ed ecco che ritornando indietro da quasi un secolo degenera visibilmente la poesia musicale in una nazione dove si loda e tanto s’ammira , il cui genio elevato e gentile non saprebbe conciliar, se vivesse, la troppo aperta contraddizione di chi onora con sì magnifici elogi la sua memoria e fino a tal segno si slontana poi nella pratica dal suo esempio e dagli suoi ammaestramenti.
[11] Non è facile il prevedere a qual punto di corruzione sarà portata la tragedia musicale colle massime recentemente adottate; ma s’è lecito anticipar un vaticinio più sicuro nelle cose letterarie che non nelle politiche e nelle materie ancora di maggior importanza, asserirò francamente che nel caso che non risorga un novello spirito in Italia simile al nobil discepolo del , il quale, promovendo le di lui virtù, compisca ciò ch’egli non ebbe coraggio d’intraprendere, il melodramma è per cadere in un grado di depravazipne non diverso da quello in cui giaceva nel secolo passato. Il , e il del teatro lirico credettero che l’eccellenza dell’opera italiana consistesse principalmente nella bella musica e nella bella poesia; si crede ora che il suo pregio maggiore consista nel favellar agli occhi piuttosto che agli orecchi, e nell’interessare collo spettacolo e con le superbe comparse anziché colla ben pensata modulazione e coi fiori della eloquenza. Siffatto principio avrà delle pericolose influenze su tutto il sistema. In primo, luogo dee ricondur sulle scene quel maraviglioso d’immaginazione, quel macchinismo arbitrario che siede benissimo in un poema narrativo qual è l’epopea, ma che distrugge affatto e perverte, secondo che pensa con molta ragione 155, i poemi drammatici. La cagione si è perché le orecchie, che sono le giudici nella epopea, ponno essere più facilmente sedotte dalla narrativa e farci credere le cose mirabili, laddove gli occhi innanzi ai quali si suppone che si rappresenti l’azione drammatica sono più disposti a discernere il falso dal vero, e più diffìcili a lasciarsi sorprendere dai prestigi della fantasia.
«E giungeCiò che va per l’orecchio ognor più tardiGli animi ad agitar di ciò, ch’espostoÈ allo sguardo fedel»156
e però si va a rischio di distruggere l’illusione dello spettatore. In secondo luogo la necessità di riempire le scene in uno spettacolo, dove altro non si cerchi che di abbagliare la vista, vi ricondurrà l’uso frequente o perpetuo dei cori, e con esso tutti gli abusi ai quali è solito di andare soggetto, per esempio di urtare in mille inverosimiglianze palpabili e di restringer la sfera degli argomenti drammatici di già troppo limitata per gli altri motivi indicati. Sarà in ultimo luogo lo sterminio dello stile e della musica. Di quello per la regola generale che la poesia non può fare una convenevol figura nel melodramma, ove preponderi qualcheduna delle sue compagne, cioè l’armonia o la decorazione. Di questa perché quanto più d’attenzione porgerà l’uditore allo sfoggio delle macchine e ai colpi di scena tanto meno gli resterà per la melodia, e perché non potendo gl’impressari, a motivo del gran dispendio delle comparse, dare ai musici le paghe considerabili che davano loro per lo passato, questi scoraggiti nell’arringo rallenteranno l’ardore per lo studio a misura che verrà meno la speranza del guadagno e degli applausi. Chi sà dirmi cosa diverrà la tragedia musicale ridotta a sì misero stato?
[12] Le ricerche analitiche fatte finora sull’opera seria potrebbero ricevere una illustrazione maggiore dalle pruove di fatto s’io volessi imbrattar la mia penna col racconto delle innumerabili scipite produzioni che disonorano oggidì la scena italiana. Ma contento di leggiermente accennarle, e persuadendomi che sarebbe una pedanteria mista di malignità il considerare soltanto il cattivo d’una nazione senza voler fissare gli occhi sul buono, passerò con piacere a far menzione di quelli scrittori melodrammatici che o meritano un luogo distinto pe’ i loro talenti, o non meritano andar confusi collo stolido gregge dei dozzinali oscurissimi poetastri. Vengono essi divisi in due classi. La prima di coloro che dopo il miglioramento del melodramma hanno tentato di richiamar sul teatro il sistema francese. La seconda di quelli che seguitarono le vestigia del gran .
[13] , romano scrittor elegante e delicato, celebre traduttore del poema inglese di , felice imitatore di nelle elegie, emolo di negli endecasillabi, e seguace di nelle sue canzonette, scrisse due melodrammi intitolati l’Eroe Pastore e Teti e Peteo, di merito assai inferiore agli altri suoi componimenti. Benché vi si scorga correzione di lingua e qualche aria ben lavorata, ciò nonostante non si ritrova in essi spezzatura né concisione nel recitativo, né rapidità nelle scene, né calore nell’azione, né contrasto negli incidenti, nulla insomma di ciò che rende interessanti e vive cotali produzioni. Difetti cagionati in lui dall’aver preso ad imitare senza poter pareggiare le sue ragguardevoli doti, e dall’aver trascurato , di cui neppur fa menzione nella sua storica prefazione premessa alla Teti quantunque non gli potesse essere ignoto in tanta luce di gloria, specialmente avendo vissuto entrambi sotto la direzione di . Laonde il suo silenzio suppone o un troppo sfavorevole pregiudizio, o un certo livore poco degno d’un sì gentile cultor delle muse.
[14] ,
poeta fra i primi del suo tempo in Italia per la robustezza dello
stile, per la forza dell’epitettare e per la fertilità e chiarezza delle imagini,
compose alcuni drammi musicali da rappresentarsi con regia magnificenza nel teatro della
corte di Parma, i quali pruovano quanto siano limitati i confini
dell’umano ingegno, e come una spezie di talento suppone per lo più l’esclusione d’un
altra. Non insisterò per tanto nella irragionevolezza del piano, nei caratteri
arbitrari, negli esseri fantastici personificati, nello slegamento delle scene, nella
versificazione dura e poco a proposito per la musica. Perdoniamogli codesti abortivi
parti di una musa invecchiata in attenzione alle altre sue cose bellissime, e
contentiamoci della ingenua confessione che fa egli medesimo della sua inesperienza in
fatto di poesia drammatica. «Mal venga (diceva
il in una lettera scritta a ragguardevole personaggio
bolognese) ai drammi musicali ed a chi primiero li pose sopra i nostri teatri
a far perdere il cervello ai poeti, a far guadagnare enormi somme ai castrati, a
rovinar la poesia, ad effemminare la musica, guastare i costumi. Io non so più dove
m’abbia il capo. Cammino una strada, che non è in Parnaso la
mia. Incespo ad ogni passo, e se non bestemmio, si è perché sono un poeta dabbene. Voi
vedrete questa mia ladra fatica quando sarà finita e stampata. ecc.»
Tuttavia
per quella “ladra fatica” n’ebbe il poeta dugento e cinquanta zecchini di regalo oltre
l’annua sua pensione, premio che certamente non ebbero né l’Artaserse, né
il Catone, né l’Ezio dell’incomparabile . È per altro piacevole in bocca di la doppia accusa intentata contra ai drammi musicali
cioè di guastar i costumi e di rovinar la poesia. Nella prima mi sembra udire uno dei
Ceteghi che rimprovera a Catilina la sua ribellione. Parmi nella seconda di
ravvisare una di quelle donne sgraziate, alle quali l’avara natura negò il fortunato
dono di piacere e che mossa da invidia anziché da zelo pei costumi declama contro alle
galanti mode oltramontane, che tanta grazia aggiungono al portamento e vieppiù fanno
apparire le naturali bellezze e la vivace leggiadria delle giovani donne più avventurose
di lei157.
[15] Parecchi drammi parte seri e parte buffi scritti con bella
versificazione e con viste musicali ha lavorato il Signor , i quali ponno vedersi nel tomo secondo delle sue
opere. Tra questi si distinguono l’Orfeo e l’Alceste
benché più celebri per la musica eccellente del
che gli accompagna che per il proprio merito. La sorte di cotai componimenti è stata di
aver avuto degli accusatori illustri. Dell’Orfeo è fama che dicesse
dopo averlo letto: «In questo
dramma vi sono tutti i quattro Novissimi eccettuato il giudizio.»
Difatti vi
si trova la morte di Euridice,
l’Inferno e l’Eliso. Circa
l’Alceste è ben nota la critica fatta da nella lettera intorno alla musica di indirizzata all’Inglese : critica che gli uomini di buon senso troveranno assai giudiziosa
se vorranno riflettere alla monotonia che vi regna dappertutto, alla poca varietà negli
affetti e nelle situazioni, all’interesse che va scemando di atto in atto invece di
crescere, al poco felice scioglimento della catastrofe, e alla inverosimiglianza di
alcuni incidenti. Tali sono fra gli altri il far che i numi infernali sconsiglino
Alceste dal morire, laddove sarebbe più
confaccente al loro carattere e al loro interesse il confermarla nella sua risoluzione,
come fa la morte parlando con Apolline nella
tragedia di , e la fretta altresì con cui si
prepara nell’atto secondo una festa di ballo tra i cortegiani per festeggiare
l’inaspettato ristabilimento di Admeto senza
che in tanta allegrezza alcun si ricordi dell’assente regina che ne dovea pur essere il
principale personaggio. L’autore, il quale non manca certamente d’ingegno né di
cognizioni, avrebbe dovuto riflettere che una composizione così uniforme e così tetrica
come l’Alceste, era forse buona per il teatro di
Atene, ma che dovendosi fra noi metter in musica da un uomo
conseguente a se stesso e alla poesia qual’è il Cavalier , non poteva far di meno che non istancasse la pazienza degli uditori
italiani dotati da una sensibilità meno pofonda, e avezzi a un’armonia più leggiera e
più brillante. Avrebbe ancora dovuto badare a non cadere in contraddizione con se
medesimo; poiché dopo avere nella sua dissertazione sopra inalzato fino alle stelle il merito del , e poste nel più chiaro lume le stranezze e le irregolarità
del sistema melodrammatico francese, s’avvicina poi altrettanto nella esecuzione a
questo quanto si disparte dal retto sentiero indicato da quello ai poeti italiani. Il
piano adottato dal sembra essere non di
fare che la poesia somministri da se stessa i colpi di scena e le situazioni, ma di far
che le situazioni e i colpi di scena si tirino dietro la poesia. Dato un tale argomento
altro egli non cerca se non di colpir gli occhi e la fantasia. A questo fine ei rivolge
il dialogo, stiracchia l’orditura, prepara a suo modo gl’incidenti, e travvisa come più
gli torna in acconcio i caratteri. «Rem quocumque modo rem»
: ecco la sua
divisa. Un siffatto sistema può per accidente generar l’effetto in teatro qualora il
compositore con una bella musica, il macchinista colle vaghe decorazioni, e il ballerino
coll’opportuna esecuzione dei balli assalgano lo spettatore da tutte le bande cosicché
non gli rimanga l’agio di badare più che tanto alla poesia. Ma svaniti che siano cotali
estrinseci e passaggieri prestigi, l’uomo di gusto non potrà far a meno di non dolersi
nel vedere la poesia, che dovrebbe primeggiare qual donna e regina in ogni spettacolo
drammatico, servire come di mero strumento alla prospettiva e alla composizione, e
invece d’ostentare il pregio delle proprie ricchezze rimanersi come la cornacchia
spennacchiata d’ «furtivis nudata
coloribus»
. Dovrebbe soprattutto aver misurato un poco meglio le proprie forze
allorché volle maneggiar l’arco d’Ulisse
ritoccando un argomento trattato in prima da , lo scontrarsi col quale sul cammin della gloria non è e non
può essere vantaggioso per chicchesia. Di fatti le Danaidi del , dramma ultimamente pubblicato in Napoli è
paragonato coll’Ipermestra, ciò che sarebbe uno stravagante quadro di
Giordano posto accanto ad una pittura di
Correggio. Se v’ha qualche carattere o qualche
situazione che possa dirsi appasssionata, come per lo più lo sono gli avvenimenti
d’Ipermestra e di Linceo, quelle sono ricopiate dal romano originale; del
suo non ha egli messo fuorché una serie di quadri dove si vede essersi il poeta
abbandonato alla falsa massima attribuita a
«frappez plutôt fort que juste»
. L’illustre non avrebbe certamente cominciata una tragedia colle nozze per
finirla poi colla casa del diavolo; non avrebbe
in mezzo a personaggi veri e reali fatto comparir fantastici amorini che ballassero
senza necesssità cogli sposi; non avrebbe sagrificato alla vana pompa della decorazione
l’orditura, la verosimiglianza e il buon senso. Né si dee credere che finite appena le
nozze avesse egli introdotto il padre ragunando le cinquanta figlie nel tempio di
Nemesi, e consigliando loro l’uccisione degli
sposi senza che questi maravigliati della improvvisa lontananza in un giorno di
sposalizio ne facessero qualche ricerca col fine di penetrare l’arcano, e senza che le
novelle spose mostrassero la menoma renitenza ai barbari comandi del padre. Tanto più
che il carattere di Danao e delle Danaidi non ci vien dipinto dall’antichità cogli
abborriti e tetri colori, con cui l’ombreggia il Signor de’ , presso al quale le figlie sembrano altrettante energumene
sanguinarie e il genitore comparisce un perfido, uno spergiuro, un mostro; laddove nelle
Supplicanti di sì quelle che
questo altro non respirano fuorché riconoscenza, umiltà, tenerezza e divozione verso gli
dei. Mancò egli non per tanto al gran precetto di Orazio
«O la comune opinion seconda,O cose in ogni parte a se conformiFingi o scrittor.»158
[16] Nè il si sarebbe immaginato che per render interessante e teatrale la sua tragedia fosse di bisogno che le figlie, dopo aver commesso l’atroce misfatto, si vestissero tutte da baccanti e venissero sulla scena a cantare e a ballare senza che anteriormente venga indicata la cagione di così improvvisa e furibonda allegrezza, e senza che la loro venuta abbia verun altro oggetto fuorché quello di formar un coro e una comparsa. E trovò egli benissimo la maniera d’eccitare gli affetti, di strappare le lagrime, di dipigner a meraviglia i caratteri, di far brillare la musica, di condurre per tre atti un’azione, e di scioglierla con somma felicità senza ricorrere al solito ripiego di , ch’è di far apparire l’inferno coi demoni, mettendo in bocca loro per giunta una moralità tanto ad essi appropriata quanto lo è a S. Giovanni Evangelissa il ridicolo discorso che gli fa tenere col paladino Astolfo nel globo della luna. Però non ostanti i suoi talenti poetici, nonostante la dovuta stima ch’esige il Signor de’ per lo studio posto nelle cose teatrali di cui ci porge egli eccellenti saggi non meno nella citata dissertazione che nella sua lettera al Conte ; bisogna pur accordare esser egli uno de’ principali corruttori del moderno musicale teatro.
[17] Ma non tutti i poeti del nostro tempo si sono rivolti alla imitazion dei Francesi: molti ancora vi sono che vollero piuttosto seguitar nella sua luminosa carriera somiglianti a que’ satelliti che s’accerchiano intorno all’orbita del pianeta maggiore. Il , l’, il , il , e il lavorarono qualche componimento passabile. Nei drammi di , poeta cesareo alla corte di Pietroburgo, si scorge chiarezza di stile, varietà nelle arie, bellezza nei recitativi, qualche scena di forza insiem coll’arte pregevole di acconciamente innestare le massime filosofiche nel corpo dell’azione. Lo spettacolo altresì ha gran luogo ne’ suoi componimenti, ma si trae per il comune dai fonti della storia, e i costumi e i riti de’ popoli vengono osservati a dovere. Egli è un peccato che nell’ordire i piani non sia stato abbastanza felice, che non dipinga i caratteri colla costanza che si richiederebbe, che gli scioglimenti siano freddi e per lo più inverosimili, e che il desiderio di ridurre il melodramma ad un certo sistema adottato da lui, il quale consisteva nell’intrecciar insiem nell’azione la poesia, il ballo, la musica e la decorazione, l’abbia talvolta fatto cadere in istravaganze. Per tali devono riputarsi nell’Antigono la scena muta dei due fratelli Eteocle e Polinice, che compariscono sul teatro nella prima scena unicamente col fine di ammazzarsi senza profferir una parola: combattimento introdotto dal poeta per cagione della comparsa, ma che troppo funesta fin dal principio l’immaginazione dello spettatore non preparato ad un simile orrore. E tali sono ancora le danze fuori di luogo frapposte almeno nella maggior parte, essendo certo che un giorno di lagrime e di lutto quale dovea essere per gli Argivi quello ove perduta aveano ad un solo tratto pressoché tutta la stirpe dei loro re, non era il più a proposito per ordinare quattro balli differenti. Tralascio l’inverosimile cambiamento di Creonte nell’ultima scena contrario al maligno e scellerato carattere che da tutta l’antichità gli viene attribuito, e fatto solo per cavar d’impaccio il poeta terminando col solito formolario d’uno sposalizio. Gli stessi pregi e i difetti stessi s’osservano nella Ifigenia, tragedia musicale assai lodata del medesimo autore.
[18] Larga sorgente di poetica vena, gran rapidezza, e gran lettura di appariscono nelle poche produzioni drammatiche stampate fra l’opere del celebre Signor Don , napoletano. La traduzione de’ salmi di quest’autore eseguita con ispirito, con disinvoltura e con brio benché inesatta in più luoghi perché troppo libera, e mancante forse di quella dilicatezza e finitura alla quale difficilmente pervengono i troppo fervidi ingegni, fa vedere che nessuno più di lui era forse in istato di rimpiazzare la perdita dell’illustre amico se la feconda fantasia che non s’appaga di una sola spezie di gloria, o le circostanze domestiche non l’avesser costretto a rivolgere la sua attenzione ad altri diversi lunghi e moltiplici studi. Mi confermo nella mia opinione osservando la felicità con cui ha egli trasferita nella italiana favella una scena dell’Ecuba di , la quale ci fa vivamente desiderare di veder dalla stessa mano in simil foggia vestito non solo quel poeta ma tutti gli altri drammatici antichi. Senza però ch’io inclini per questo ad abbracciare i brillanti e poco solidi pensamenti che intorno alla convenienza del sistema drammatico degli Ateniesi col nostro ha l’autore con molto ingegno ed erudizione ma non con uguale giustezza proposti nella sua dissertazione intorno alla maniera d’interpretare i tragici greci.
[19] Un colto spagnuolo, che con esempio non facile a rinvenirsi ha avuto il coraggio d’intraprendere in lingua non sua uno de’ più difficili lavori della ragione poetica qual è la tragedia, ha parimenti voluto sperimentare le sue forze pubblicando un dramma musicale. Lo Scipione in Cartagine dell’Abate merita un luogo distinto fra quelli del nostro tempo, ed io non avrei difficoltà di dir che fosse il primo, se alla semplicità della condotta, alla scelta e varietà nei metri, alla ricchezza lirica delle arie, e al merito di qualche scena degna di avesse l’autore voluto congiugnere maggior rapidità nell’intreccio, più di calore nell’azione, e un più vivo contrasto negl’incidenti. Altri forse avrebbe desiderato, che la virtù di Scipione fosse meno tranquilla, e che i personaggi subalterni non s’usurpassero tanta parte di quell’interesse che dovea principalmente cadere sul protagonista; essendo certo che sebbene il carattere di Scipione considerato filosoficamente sia grande ed eroico, non è tuttavia sì teatrale né sì atto alla musica quanto quello di Arminia e di Lucio. La cagione si è perché a produrre l’azione (ch’è l’anima del teatro musicale) assai più acconcio è il combattimento e il contrasto delle passioni, qualmente si vede in que’ due sfortunati sposi, che non la saggia fermezza d’un eroe di cui poco si pregia la vittoria perché poco gli è costato il sagrifìzio. e vorrebbero che gli uomini fossero simili ad una rocca, la quale immobile nella propria base spezza le onde che furiosamente le romoreggian d’intorno, e talmente ha l’Abate dipinto il suo protagonista; ma il teatro, che ha una statica tutta sua, gli vorrebbe somiglianti piuttosto al naviglio, che sferzato da venti contrari ondeggia incerto del proprio destino in mezzo ai tempestosi flutti, eccitando in chi lo guarda dalla riva una sensazione mista di timore per il pericolo del navigante e di compiacenza per la propria salvezza159.
[20] Purgatezza di lingua, venustà di stile, colorito poetico, varietà e delicatezza d’immagini espresse con ottimo gusto, sono le doti che caratterizzano l’Alessandro e Timoteo del Conte rappresentato anni fa nel regio ducale teatro di Parma Pochi, o per dir meglio, nessuno fra i drammi musicali moderni è scritto con uguale vaghezza. Ha inoltre il pregio incontrastabile della novità, essendo egli stato (per quanto a me pare) il primo che, cambiando il sistema di cotesto spettacolo, abbia renduta drammatica un’ode puramente descrittiva qual è quella dell’inglese intitolata Gli effetti della musica a le cui sorgenti ha l’autore italiano largamente bevuto. Un’altro inglese chiamato gli ha somministrata l’idea nella sua dissertazione sulla unione della musica e della poesia. In altro luogo ci converrà parlare più a lungo degl’inconvenienti e dei vantaggi annessi al metodo proposto dall’inglese. Per ora non si può far a meno di non lodare la buona intenzione di chi cercando di rimediare agli abusi del moderno teatro, propone al pubblico un tentativo di questa sorta. Nelle regioni del gusto, come nelle vaste pianure dell’oceano, molti paesi sarebbero sconosciuti ancora senza l’intrepido coraggio di alcuni navigatori simili ai Cooki e ai Draki. Eppure non sembra che il pubblico la intenda così se giudicar dobbiamo dalla fredda accoglienza che ha fatta al dramma del Conte . A che attribuire quest’apparente ingratitudine? Ecco il motivo s’io non m’inganno. In primo luogo il suo stile benché assai poetico ed elegante manca di quella mollezza e di quella facilità senza le quali non è possibile adattar acconciamente le parole alla musica. Veggasi quanto su tal proposito s’è detto nel tomo primo di quest’opera, dove si parlò delle qualità che deggiono avere lo stile e la lingua per rendersi musicali, e dalle ragioni ivi allegate si conoscerà essere manifestamente false e insussistenti le teorie d’alcuni moderni italiani che vorrebbero trasferire alla poesia accompagnata dai suoni le leggi medesime di stile che voglionsi per le poesie non inservienti alla musica. In secondo luogo l’argomento scelto da lui buono per un poema narrativo manca intrinsecamente di quella illusione e interesse che richiede il teatro. L’autore, imitando troppo esattamente il suo , ci fa intendere fin dalla prima scena che Taide e Timoteo vogliono rappresentar innanzi agli occhi di Alessandro un fìnto spettacolo
«Non soloColla voce e col suon l’orecchie e l’almaIn questo dì, ma le pupille ancoraVuol di vano terror, di piacer vanoAffascinarti con portenti.»
[21] Non è dunque da maravigliarsi se mancando in chi ascolta la sorpresa derivata dal creder vero ciò che gli si racconta, manca in lui l’illusione eziandio, figurandosi d’esser presente ad una mascherata invece di assistere ad un’azione vera e reale. La natura dell’argomento è la cagion parimenti dello slegamento delle scene, succedendosi queste in tal guisa fra loro, che tolta via qualunque di esse, poco o nulla ne soffre l’intiera composizione160. Aggiungasi che il protagonista il cui nome dovrebbe eccitare l’idea dell’eroismo, non m’offre nel dramma del Conte veruna di quelle qualità che risvegliano l’interesse. Ivi non comparisce magnanimo, né eroe, né uomo di genio, ma piuttosto un farnetico divenuto giuoco della sua eccessiva sensibilità, uno schiavo della mollezza che ci vendica fra le sue catene dell’ascendente che aveva sopra di noi acquistato la sua fortuna. Pecca altresì nel fine morale. Volendo far conoscere i prodigiosi effetti della musica, non dovevano questi manifestarsi spingendo un giovin sovrano ad una risoluzione così violente e disumana come è quella di abbrucciare fin colle proprie mani una popolatissima città che, deposte le armi, era pacificamente divenuta sua suddita. Se fosse stato vero che Alessandro (com’egli pazzamente s’imaginava) era figliuolo di un nume, questo fatto solo m’obbligherebbe a crederlo anzi prosapia delle Furie infernali che germe di Giove. Mi si risponderà ch’egli è mosso a farlo dal desiderio di vendicar i Mani de’ Greci trucidati in altri tempi dai persiani, lo che ad un atto di giustizia o di patriotismo dovrebbe attribuirsi piuttosto che ad un capriccio irragionevole. Ma cotal difesa non giova. In primo luogo perché non da principio riflesso di virtù si suppone ivi che fosse spinto Alessandro, ma da macchinale furore eccitato in lui dai prestigi d’un musico e dalle istigazioni d’una cortigiana. In secondo luogo perché nel caso ancora che un falso amore della patria determinato l’avesse ad eseguire quell’atto di crudeltà, né il teatro, né la filosofia dovrebbero autorizzarlo giammai esponendolo sulle scene alla pubblica imitazione. Oh mortali! Non è abbastanza feroce lo spirito della guerra senza che voi cerchiate d’inferocirlo ancor più divinizzando l’alloro che gronda di vostro sangue? E sì poco barbaro vi sembra il despotismo, che non avete orrore d’inghirlandarlo colla corona immortale, che le belle arti non dovrebbon servare fuorché pei talenti superiori o per la benefattrice virtù?
[22] Ma tempo è ormai di venire all’opera buffa. Se si riflette ai vantaggi che ha la commedia musicale sopra la tragedia, parrà strano che giaccia quella nell’obbrobrioso stato in cui si ritrova oggi in Italia. La sfera d’imitazione per la moltiplicità de’ caratteri, per la forza di essi, e per la verità della espressione è più dilatata nella prima che nella seconda. Gli argomenti tragici, e conseguentemente quelli che danno motivo ad una musica nobile e patetica, devono essere meno frequenti, perché nell’universo morale, come nel fìsico, le grandi catastrofi sono più rare, e perché, sebbene la vita umana sia una serie di muovimenti or dolorosi or piacevoli, la natura che attacca la conservazione dell’individuo allo stato di mezzo, gli risparmia, in quanto è possibile, gli estremi del dolore, come gli è pur troppo scarsa degli estremi piaceri. Attalchè la crisi d’una passione violenta non è più durevole nell’uomo di quello che lo sia in una stagione l’eccessivo rigore del freddo, o gli sconvolgimenti del tremuoto in un paese. Ora le passioni tragiche non divengono musicali se non quando sono vicine alla violenza, e dall’altra parte la classe dei personaggi illustri, a’ quali appartengono esse, è di numero troppo scarso rispetto alla massa generale della nazione; quindi minore altresì esser deve la somma degli argomenti onde formare una tragedia musicale. L’opposto avviene nella commedia. I soggetti che vi s’introducono formano la classe più numerosa della società. Gli avvenimenti che vi si rappresentano sono frequentissimi nella vita comune. Ecco non pertanto una dovizia maggiore per il poeta nelle persone e nelle cose. Quidquid agunt homines è la divisa del comico. Ma bisogna andare più oltre. Le affezioni della gente popolare sono meno riconcentrate, e conseguentemente sono più aperte. I loro caratteri meno artefatti e perciò più facili ad essere rappresentati. L’accento della loro voce più sfogato e vivace, e in conseguenza più musicale. I ridicoli loro più evidenti e più caricati che è lo stesso che dire più acconci a piegarsi sotto la mano di chi vuol imitarli. Tutto ciò deriva dalla eterna providenza di colui che, reggendo con invariabil sistema le cose di quaggiù, mette un perfetto equilibrio fra gli esseri morali, amareggiando col sospetto, col rimorso, colle spinose e tacite cure la condizione de’ potenti schiavi sempre della fortuna e del pregiudizio nell’atto stesso che alleggerisce i disagi involontari del povero colla maggior apertura di cuore, indizio d’un’anima più ingenua, e colla non mentita allegrezza, indizio d’uno spirito più contento.
[23] Per poco che il lettore voglia inoltrarsi nelle idee accennate, troverà dunque che il sistema dell’opera buffa considerato in se stesso è più ferace e più comodo di quello che sia il sistema dell’opera seria per il poeta, per l’attore e per il compositore. Lo è per il primo mercè la gran copia che gli somministra di caratteri o sia di natura imitabile. Lo è per il secondo a motivo della più facile esecuzione sì perché i tratti dell’oggetto rappresentato sono più spiccati e decisivi, come perché ritrova ovunque originali da poter agiatamente studiare. Lo è per il terzo a motivo della ricchezza delle modulazioni che scaturisce dalle stesse sorgenti, e dal non vedersi obbligato ad alterar la natura almeno fino al grado che s’altera e si sfigura nell’opera seria. Imperocché il timore di non slontanarsi troppo dal parlar familiare proprio de’ personaggi che rappresentano, fa che i buffi non si perdano in gorgheggi o cadenze smisurate, e che non facciano uso di quel diluvio di note, col quale inondandosi nella tragedia le arie più patetiche e interessanti, hanno gli altri cantori non so se disonorato o abbellito il canto moderno. E questa è la cagione per cui la musica delle opere buffe è, generalmente parlando, in migliore stato in Italia che la musica seria, e perché per un motivo di quest’ultimo genere che si senta composto con qualche novità e caratterizzato a dovere, se ne trovano dieci nella musica buffa.
[24] Mossi da tali ragioni vi sono di quelli che preferiscono ed amano, e mostrano di pregiare assai più la commedia musicale che la tragedia. E a dirne il vero, quantunque io non gusti nella caricatura dei buffi quel diletto intimo che pruovo nelle lacrime dolci e gentili che mi costrigne a versare una bella musica tragica, e benché per una non so quale disposizione del mio temperamento mi vegga sospinto ad amare nella letteratura tutto ciò che parla fortemente alla immaginazione e alla sensibilità senza curarmi gran fatto di ciò ch’eccita il riso; nulladimeno siccome la prima legge del critico filosofo esser debbe di non istabilire massime generali su casi particolari, e molto meno ritraendole da se medesimo, così, riflettendo ai pressoché incorreggibili abusi dell’opera seria e alla maggiore verità di natura e varietà di espressione che somministra l’opera buffa, concederò volontieri che non deve facciarsi di stravaganza o di cattivo gusto chiunque sopra di quella a questa dasse la preferenza.
[25] Fin qui è vero della musica, e lo dovrebbe essere parimenti della poesia: ma se da ciò che dovrebbe e potrebbe essere vogliamo argomentare a quello che è, resteremo sorpresi nel vedere che non havvi al mondo cosa più sguaiata, più bislacca, più senza gusto di questa. Come la famosa statua di Glauco descritta da , la quale posta sul lido del mare era stata dai flutti talmente battuta e corrosa che non vi si scorgeva né un dio né un uomo ma uno scoglio informe, così i pregiudizi e gli abusi hanno in tal guisa sfigurata quella sorta di componimento che non vi si ravvisa veruna delle spezie appartenenti alla ragione poetica. Per farlo vedere più chiaramente figuriamoci un poco il discorso che tiene l’impresaro coll’autore quando gli raccomanda di scrivere un libretto da mettersi in musica. Esso non sarà tutto di mia invenzione; tale a un di presso è stato fatto anni sono anche a me con un aria di persuasione capace di ottener il suo intento se il Messer , che mel fece avesse trovato il Damone di per proselito, o le orecchie di Mida per ascoltatrici. Io toccherò i principali difetti dell’opera buffa riducendoli ad una spezie di teoria.
«I bolognesi, (mi diceva egli) sbigottiti dal terremoto, sono stati gran tempo privi di teatrali divertimenti, il primo adunque che si rappresenterà tornerà in profitto considerabile dell’impresaro. Io ho divisato non per tanto d’aprire a questo settembre uno spettacolo, e voglio che sia nuovo perché il pubblico è ormai ristucco delle anticaglie di , di cui (sebbene sia il primo drammatico del mondo) vuolsi fare quell’uso che si fa nelle case dei vasellami d’argento e delle gioie di gran valore, le quali si cavano fuori in una occasione straordinaria, mentre il restante dell’anno s’adoperano altre masserizie più triviali.
«Potrei accomodarmi all’uso corrente d’Italia che è quello di strozzar i drammi di quell’autore, levando via a capriccio il più bello per inserire in sua vece arie e duetti fatti da qualche versificator dozzinale; dal che restano essi così sfigurati e mal conci che più non gli riconoscerebbe il padre che li generò, se per nuovo miracolo di Esculapio tornasse a viver fra noi. Ma non mi piace siffato costume. L’eunucare un povero poeta che non ha fatto alcun male, è crudeltà che ripugna al buon cuore. Il sostituire poi a ciò che a lei manca le altrui fanfaluche o le mie è cosa, che pute un cotal poco di prosunzione.
«Ricorro a voi non per tanto, attendendo prima di tutto dalla vostra discrezione, che non sarete difficile intorno al prezzo. Io ho da pagar somme tanto considerabili ai virtuosi, ai ballerini, al maestro di cappella, ai suonatori, ho da far tante spese negli abiti, nelle decorazioni, nei lumi, nell’affito del teatro e in altre cose che poco o nulla mi rimane per voi. Inoltre le parole sono quello che meno interessa nell’opera e nel caso che voi non vi troviate i vostri convenevoli, ci è una folla di poeti in Bologna che me le venderono a buonissimo mercato. E vedete, se si compone una canzone per cinque paoli, non basterà un paio di scudi per un libretto, il quale alla fin fine val meno assai d’una canzonetta passabile?
«Io vi credo abbastanza istrutto ne’ principi dell’arte drammatico-musicale; nulladimeno siccome trattasi del mio guadagno o della mia perdita, così mi permetterete che vi dia alcuni suggerimenti dai quali non vi dovrete dipartire.
«Non vorrei che il dramma fosse intieramente serio, perché vi vorrebbono troppe spese, né tampoco buffo del tutto, perché si confonderebbe colle opere dozzinali. Vorrei che fosse di mezzo carattere (lo che in sostanza vuol dire che non abbia alcuno) che facesse piangere e ridere allo stesso tempo, che il giocoso entrasse in una lega che mai non ha avuta col patetico, che ad un’aria appassionata tenesse dietro una di trambusto, e che aprisse campo di mostrar la sua abilità alla virtuosa Pelosini, che spicca nel tenero e virtuoso Gnaccharelli, che sostiene la parte di buffo per eccellenza. Non vorrei nemmeno che l’argomento fosse tratto dalla storia; esso diverrebbe troppo serio, né sarebbe buono per altro che per comporre secondo le leggi di , le quali nulla han che fare coll’opera: mi piacerebbe bensì che ci entrassero dentro dei cangiamenti di scena e delle macchine in quantità secondo il gusto de’ Francesi. Oh quei Francesi hanno sfiorato il bello in tutte le cose! Oltre che le decorazioni piacciono moltissimo al popolo, io ho desiderio di far vedere una bellissima dipintura d’una prigione e d’un bosco che si trovano nello scenario preso ad affitto.
«Voi altri poeti avete certe regole di stile che vi fanno lambiccar il cervello per tornire acconciamente un periodo. Si dice che v’abbia con i suoi precetti comunicata cotal malattia contagiosa un maestro dell’arte, chiamato , e che i Greci e i Francesi v’abbiano fornito l’esempio. Quanto a me vi dispenso volontieri dalla eleganza, e se vi piace anco dalla grammatica, insegnandomi l’esperienza che si può senza l’una e senza l’altra riscuoter sul teatro un durevole applauso. Non ha guari che si replicò più di quaranta volte sulle scene un’opera buffa dove un’aria cominciava
“Lei si figuri adesso”e finiva con uguale proprietà di sintassi
“Lei asino sarà”.«La vostra malizia applicherà senza dubbio le ultime parole al poeta.
«Ho sentito dire altresì che il ridicolo comico dev’essere cavato dalla esperienza non tratto dalla fantasia, che si devono studiare profondamente gli uomini prima d’esporli sul teatro, che le debolezze di temperamento non i vizi di riflessione, i difetti nati da una stranezza di pensare innocente non i delitti odiosi e nocivi sono la materia propria della scena comica, che questa materia dee rappresentarsi abbellita da un colore alquanto caricato e forte ma non esagerato, con cert’altre filastrocche che voi altri autori dite esservi state prescritte dal buon senso. Ma vi torno a dire che il buon senso non è fatto per noi. Il teatro non ha altra poetica che quella delle usanze, e poiché queste vogliono che deva ognor comparir sulle scene un martuffo con un visaccio da luna piena, con una boccaccia non differente da quella de’ leoni che si mettono avanti alla porta d’un gran palazzo, con un parruccone convenzionale, e con un abbigliamento che non ha presso alla civile società né originale né modello; poiché è deciso che cotal personaggio ridicolo abbia ad essere ognora un padre balocco, od un marito sempre geloso e sempre beffato, od un vecchio avaro che si lascia abbindolare dal primo che gli sa destramente piantar le carote, poiché il costume comanda che per tariffa scenica devano mostrarsi in teatro ora un Olandese col cappello alla quakera che sembri muoversi colle fila di ferro a guisa di burattino, ora un Francese incipriato e donnaiuolo che abbia nelle vene una buona dose d’argento vivo, ora un goffo tedesco che non parli d’altro che della sciabla e della fiasca, ora un Don Quisciotte spagnuolo che cammini a compasso come figura geometrica, pieno di falsi puntigli, ed abbigliato alla foggia di due secoli addietro, poiché insomma tutto ha da essere stravagante, esagerato, eccessivo e fuori di natura, voi mi farete la grazia d’accomodarvi mandando al diavolo quanti precettori v’ammonissero in contrario.
«V’avverto che non dovete introdurre più di sette personaggi, né meno di cinque. Sapete qual carattere devono avere le due prime parti. Al terz’uomo, ovvero sia al tenore, darete carattere sostenuto di padre, di vecchio, di geloso, di mercante Olandese, o di qual più vi aggradi. Se colui che fa la parte del padre ha quindici o vent’anni meno del figliuolo poco mi cale. Il viso acconciamente forbito, il rossetto in buona dose e la lontananza aggiustano ogni cosa. Ma che il rimanente de’ personaggi parli assai poco, imperocché quei che mi sono toccati in sorte quest’anno cantano male. E siccome l’amore è il regno delle donne e l’anima del teatro, così v’avvisarete di fare che il primo uomo sia innamorato della prima donna, e il secondo della seconda; senza codesta legge non ci sarebbe verso di contentar le mie virtuose, le quali vogliono ad ogni modo smaniar un tantino in presenza del pubblico. E poi questi amori o siano principali, ovvero di episodio si confanno mirabilmente col genio della musica. In ricompensa del disagio potrete sceglier i mezzi che più v’aggradino per maneggiare lo scioglimento. Ne fo così poco conto della condotta che nulla mi cale se va piuttosto così che altrimenti.
«Ho la buona sorte di avere un primo uomo dotato di voce snodatissima e leggiera, onde converrà aprirgli campo acciocché brilli al suo talento. Egli ama poco il recitativo, dal che ne siegue che voi dovete essere estremamente laconico a costo ancora di affollare gli avvenimenti, ma si compiace nelle ariette principalmente, in quelle dove si può gorgheggiare come sono le romorose, o che chiudono qualche comparazione. E siccome incontrò una volta assai bene cantando il
“Vo solcando un mar crudele”,così vorrebbe un’aria lavorata sullo stesso metro e con delle parole consimili. Se non vi vien fatto di lavorarla, come ei vuole, poco importa, attaccheremo quella stessa, e tutto anderà a dovere. Sarà poi mio pensiero far che il maestro vi adatti sopra una musica sfoggiata e pomposa, e affinchè spicchi di vantaggio la di lui abilità, faremo nascere una tenzone musicale fra la voce del cantante e un qualche strumento con botte, e risposte da una parte e dall’altra, che sarà proprio una delizia.
«Vi metterete un solo duetto, il quale, come sapete, appartiene esclusivamente al primo uomo e alla prima donna. Guai se venisse cantato da altri che da loro! Nascerebbe un dissidio poco minore di quello che accese in altri tempi i Geminiani contro ai Petroniani per la Secchia rapita. A fine di schivar le contese fa di mestieri parimenti che tutti i personaggi cantino per ordine le loro ariette incominciando dal primo uomo o dalla prima donna infino all’ultimo, e siccome vorrei che vi si mescolasse il buffo, così non farebbe male un finale dove tutti cantassero ad un tratto. Meglio poi se ci entra nelle parole un non so che di mulinello, di tempesta, di zuffa o di cosa che apportasse gran fracasso. Allora l’orchestra batterebbe fuoco, e gli uditori sguazzerebbero per l’allegrezza. Egli è vero che codesti finali rassomigliano per lo più ad una sinagoga di ebrei anzi che ad un canto ben eseguito, ma nelle cose di gusto non bisogna essere cotanto sofistico.
«Avrete cura di fare che tutti gli attori abbandonino il teatro dopo aver cantato le loro ariette, e che verso la fine dell’atto vadino sfilando a poco a poco. Cotal costume mi piace assai ed è caratteristico dell’opera. Lascio poi in vostra balia il tirar giù a grado vostro l’ultimo atto; basta che sia curto, che non vi si frammezzino arie d’impegno, né decorazioni importanti, e che i personaggi alla perfine si rappattumino insieme così che ogni cosa fornisca amichevolmente. Mi direte che ciò non si conviene, e che anzi l’ultimo atto dovrebbe essere il più vivo e incalzante. Ma coteste sono sottigliezze dell’arte, nelle quali non me ne intrico. Quello ch’io so è che, fornito il secondo ballo, l’uditorio va via, e che i suonatori e virtuosi non vogliono più faticare.»
[26] Con tali principi, su quali s’aggira in pratica tutto l’edifizio dell’opera buffa, non è da maravigliarsi se i lettori non degnano di gettare uno sguardo sul libretto, se il poeta da sovrano, quale dovrebbe essere, è divenuto ligio, e se va a soqquadro ogni cosa. Da questa proscrizion generale vanno esenti pochissimi scrittori. Se e hanno fatta in questo genere qualche composizione passabile, il loro merito è comparativo, e non assoluto. Essi non devono confondersi tra i Bavi o i Mevi, ma qual distanza fra loro e gli o i ? Ma se l’Abate applicherà a siffatti lavori la sua vivace imaginazione, il suo talento pieghevole e il suo stile agiato e corrente (cercando però di rammorbidirlo alquanto secondo i bisogni della melodia, e mettendo un poco più di contrasto e di forza nelle situazioni e nei caratteri) avrà egli fra poco la gloria di regnare senza rivali sul teatro buffo italiano. Mi fanno pensare in tal guisa il Teodoro re di Corsica, e molto più la Grotta di Trifonio, due commedie musicali di questo poeta che si sono rappresentate nell’imperial corte di Vienna e che ci fanno desiderare di vederne sortire altre molte dalla stessa penna.
Capitolo decimosesto §
Ragionamento sopra il ballo pantomimico. Della sua applicazione al teatro. Se convenga o no bandirlo dal melodramma.
[1] Abbiamo finora osservati i fondamenti del brillante edifizio che potrebbero le belle arti inalzare al piacere non meno che alla gloria d’una nazione. Non è colpa nostra se l’esecuzione si è trovata disforme al disegno, e se i pregiudizi hanno sfigurata nella pratica quella sublime idea del bello che negli annali del gusto avea tracciata la penna luminosa del genio. Al presente restano a disaminarsi gli ornati fra i quali il ballo ottiene un luogo così distinto che il passarlo sotto silenzio sarebbe lo stesso difetto che il tralasciare fra le regole dell’architettura quelle che insegnano la maniera ci abbellire una facciata o di render luminoso e capace l’ingresso d’un palazzo. Oltradicchè diventa oggimai tanto più necessario il parlarne quanto che la possente influenza della imitazione francese ha reso il ballo a giorni nostri quasi parte essenziale del melodramma italiano. Però seguitando il mio solito metodo ch’è quello di risalire fino ai principi a fine di cavare più ovvie e più legittime le conseguenze, cercherò di restringere colla brevità e nettezza possibile tutto ciò che nella presente materia ha uno stretto legame col mio argomento ai capi seguenti.
Primo. Dell’origine naturale e della energia del ballo.
Secondo. Della sua applicazione e uffizi ai teatro.
Terzo. Della sua prima introduzione e progressi in Italia.
Quarto. Dei principali abusi introdottisi nel ballo pantomimico italiano.
[2] Ogni passione interna dell’uomo si manifesta in due maniere o coll’azione o col suono. La stessa sensazione che ci strappa un urlo di spavento o un grido di gioia, ci spinge a fare eziandio certi determinati gesti analoghi alla natura dell’affetto che ci predomina. Se l’apprensione è d’un male, i muovimenti del corpo sono diretti a slontanarlo lungi da noi, come si cerca con ogni sforzo di avvicinarlo qualora si crede di ritrovar in queir oggetto la propria felicità. L’uno e l’altro è stato dalla natura con mirabile provedimento ordinato. Negli affetti di gioia i segni esterni servono a comunicare coi nostri simili parte di quell’allegrezza che tanto giova a rinserrare i vincoli dell’amicizia. Negli affetti di spavento o di mestizia servono essi ad eccitar in nostro aiuto l’altrui commiserazione facendo vedere, che ci sovrasta un qualche pericolo. Si vede adunque che l’origine naturale del ballo e del canto è la stessa che l’istinto (quella facoltà indiffinibile, ma vera, che negli esseri sensibili è il supplemento della ragione) è la cagion produttrice dell’uno e dell’altro, e che siccome i suoni inarticolati della voce umana sono la materia elementare della melodia, così le attitudini della fisionomia e del corpo sono, a così dire, la materia primitiva della danza.
[3] Ma non qualunque aggregato di suoni è un canto, né qualunque serie di attitudini è un ballo. Gli accenti scomposti e fuori di regola non formano modulazione nella stessa guisa che i gesti fuori di misura non formano cadenza. Gli uni e gli altri, per costituire un’arte, hanno bisogno d’essere imprigionati fra certe leggi inalterabili e severe, le quali sono le medesime per la danza che per la musica. Come questa ha bisogno d’una misura che regoli la durazione di ciascun tuono, d’un muovimento che affretti o rallenti la misura, d’un’armonia che combini e temperi le parti simultanee, e d’una melodia che disponga i tuoni in una successione aggradevole, così nel ballo fa d’uopo dar un determinato valore e una durazione ai gesti, accelerarli o rallentarli secondo le leggi del ritmo, regolar acconciamente le figure subalterne, e dar ai muovimenti del corpo una continuazione concertata ed armonica. La comparazione fra il canto e il ballo può condursi ancora più avanti. V’è un canto naturale e un canto imitativo. Nel primo chi canta non ha altro disegno che di eccitar in se stesso o in altrui quel diletto meccanico che risulta dalla dolcezza inerente a qualunque tuono. Nel secondo raccogliendo gli accenti precisi della voce umana in qualunque situazione dell’anima, prende a rappresentarli con esattezza tessendone, se occorre, una lunga azione. Dell’uno e dell’altro molto si è parlato in quest’opera. Così due sorta possiamo considerare di ballo. Una dove l’uom non ha altro disegno che di ballar per ballare, cioè di eseguire certi salti regolati o per manifestare la sua allegrezza, o per mostrar il brio e l’agilità della persona, o per porre in movimento i suoi muscoli intorpiditi dall’ozio soverchio. Questo ballo senz’altro fine riflesso si chiama propriamente danza ed è quello che s’usa nei festini, nelle accademie, e nei domestici diporti. Allorché per renderlo più aggradevole vi si mischiano parecchie sortite, evoluzioni ed intrecciamenti, prende comunemente il nome di ballo, o danza figurata. L’altra sorte si è quando chi balla, non contentandosi del piacer materiale della danza, prende ad eseguire un intiero soggetto favoloso, storico od allegorico esprimendo coi passi figurati de’ piedi, coi vari atteggiamenti del corpo e delle braccia, e coi tratti animati della fisionomia tutta la serie di situazioni che somministra l’argomento nello stesso modo che la esprime colla voce il cantore. Questa seconda maniera di ballare si chiama pantomimica, la quale costituisce un linguaggio muto di azione inventato dalla umana sagacità affine di accrescer la somma dei nostri piaceri, e di stabilire fra uomo e uomo un novello strumento di comunicazione indipendente dalla parola.
[4] Noi ignoriamo fino a qual grado di energia potrebbe condursi un siffatto strumento, ma havvi ogni apparenza di credere che se gli uomini non avessero sviluppato giammai l’organo della voce, né inventata l’arte della parola, l’idioma de’ gesti perfezionato dal bisogno, e avvivato dalle passioni avrebbe potuto comodamente supplire all’uno e all’altra. La sperienza ci fa vedere che i fanciulli, non sapendo ancora articolare gli accenti, trovano pure il segreto di farsi intendere a meraviglia dalle loro nutrici, e l’educazion ragionata, onde sono capaci i muti nati, pruova con evidenza che la natura non ha stabilito su questo punto verun impreteribil confine, e che un senso potrebbe acconciamente far le veci d’un altro. La storia inoltre ci insegna che il linguaggio primitivo de’ popoli fu dappertutto più d’azione che di parole composto, e che dalla usanza appunto di parlar agli occhi acquistaron le loro espressioni un carattere di forza, cui tenterebbe indarno agguagliare l’artifiziosa e per lo più inefficace verbosità de’ nostri più rinomati oratori. , il quale invece di rispondere all’ambasciatore de’ Gabini, lo mena nel proprio giardino, e alla sua presenza recide senza profferir parola la sommità de’ papaveri, che grandeggiavano sopra gli altri; Dario re dei Persi, che essendosi inoltrato nella Scizia con intenzione di muover la guerra a que’ popoli, si vede comparir avanti da parte loro un araldo che gli appresenta una rana, un topo, un uccello e cinque freccie, e poi si diparte senza pronunziar un sol motto; il famoso Levita di Efraimo, il quale volendo vendicar la morte della sua sposa barbaramente trucidata da certi Israeliti della tribù di Beniamino, taglia l’amato cadavero in dodici parti, ed una ne manda in regalo a ciascuna delle dodici tribù per eccitarle con sì feroce eloquenza alla comune vendetta; l’Indiana descritta da un poeta orientale, che interrogata dall’amante chi sia il fortunato oggetto de’ suoi frequenti sospiri, e obbligandola il pudore a tacere mentre l’ardenza de’ suoi desideri la sprona a manifestarlo, prende senza dir parola un lucidissimo specchio, e l’affaccia innanzi a chi le avea fatta la dimanda; l’altrettanto bella quanto incontinente Frine, che vedendo i giudici dell’Areopago non essere in suo favore dall’aringa d’ abbastanza commossi, s’inginocchia avanti loro, si straccia i veli che le ricoprivano il seno, offre ai loro sguardi una candidezza abbagliante, e per la muta facondia di due persuasive oratrici si vede assoluta dal delitto d’irreligione nel più rigido tribunale della Grecia; i Salams ovvero sia specie di muta comunicazione inventata nei serragli dell’oriente, la quale consiste nel mandarsi a vicenda in regalo un nastro, un pannizuolo, o qualche altra cosa triviale, ma che avendo nella sua piegatura e configurazione diversi pattuiti significati, serve a trasportare da un luogo all’altro tutti gli arcani della galanteria, senza temer la gelosa vigilanza dei mariti; mille altri esempi di questa natura, de’ quali abbonda non meno la sacra161 che la profana storia, pruovano che certa classe di sentimenti e di passioni ponno dipignersi alla fantasia con più vivaci colori per mezzo della vista che per mezzo dell’udito. E se non temessi diffondermi troppo in una materia ch’è il fondamento del diletto che ci procurano tutte le belle arti, farei ancora vedere che l’ascosa origine del piacere, che certi tratti arrecano nella musica, nella poesia e nella eloquenza, è nel linguaggio d’azione principalmente riposta; che ciò che rende eloquenti i quadri oratori o poetici è l’arte di radunare in una sola idea più immagini, le quali rappresentino muovimento, come la maniera di render la musica espressiva si è quella di far sentire la successione regolata de’ tuoni e del ritmo; che la forza di certe lingue massimamente delle orientali deriva dall’accennato principio: osservazione che può farsi ancora nello stile de’ più grandi scrittori antichi e moderni, la magia del quale allora è portata al maggior grado quando le parole e le idee fanno l’effetto dei colori.
[5] C’è non per tanto l’eloquenza de’ gesti, come c’è l’eloquenza de’ suoni, e la maniera di render efficace quanto si può la pantomima (della quale sola e non delle altre spezie di ballo si farà discorso nel presente capitolo) sarebbe quella d’applicarla all’esercizio delle passioni utili alla società, o ai motivi che interessano generalmente il cuore umano; posciachè i mezzi in apparenza più triviali possono fra le mani d’un legislatore filosofo divenire molle possenti di rinforzo nel governo degli stati, e nella politica.
[6] I Greci, che seppero tutto inventare e perfezionar tutto, i
Greci che non lasciarono inoperosa veruna facoltà del corpo o dello spirito, i Greci che
fecero servire fino i propri divertimenti agli oggetti più rispettabili e più sublimi, i
Greci insomma quel popolo estraordinario il cui nome io non posso leggere né nominare
senza entusiasmo, intesero così bene questo gran principio, che non temettero di dover
essere accusati di leggerezza divinizzando siccome fecero la danza, e applicandola poi
insiem colla musica e la poesia alla politica, alla educazione pubblica, alla guerra e
al culto religioso. Come gli dei e gli eroi furono tenuti poeti e musici così furono
ancora tenuti ballerini. Ballava Venere,
Ebe, e le Grazie; ballavano Castore,
Polluce e Minerva; ballarono Teseo,
Pirro, Achille e tanti altri, e perfin colui che al detto di chiamò la filosofia dal cielo, colui che
dall’oracolo fu riputato il più saggio fra gli uomini, il maestro di , di , e di
, in una parola il gravissimo ebbe fama di bravo danzatore. Questa, che nelle
nostre idee tanto diverse da quelle sembra una prostituzione della filosofia, veniva
accompagnata da un altra spezie di prostituzione in apparenza più scandalosa. Non solo
adoperavano i Greci la danza come un atto di religione, o come un incentivo all’amor
della patria, non solo si danzava nell’entrare in una battaglia per accendersi al
coraggio, nel sortire di essa per ringraziare gli dei, d’intorno al talamo coniugale per
augurare la fecondità, nella palestra per indurarsi alla fatica, nelle campagne per
implorare dai numi l’abbondanza delle raccolte, fra le mura domestiche per educare la
gioventù e in mille altre occasioni, ma eravi ancora una danza chiamata della Innocenza
dove le donzelle di Lacedemonia ballavano affatto ignude e divise in più cori innanzi al
simulacro di Diana sotto gli occhi della
gioventù maschile, e in presenza del rispettabile magistrato degli Efori, il quale
autorizzava colla sua compostezza e taciturnità uno spettacolo così strano. Gli occhi
nostri lo ritroverebbono senza dubbio biasimevole, né io voglio in modo alcuno
giustificarlo avendo la fortuna di professare una religione non meno rispettabile per la
purità della sua morale che veneranda per la santità ineffabile de’ suoi dogmi; ma
riguardandolo unicamente con occhio politico, né potendo argomentare dalla profonda
sagacità del legislatore di Lacedemonia che un sì bizzarro
costume fosse privo d’ogni ragion sufficiente che rendesse non solo utile ma legittima
la sua istituzione, bisognerà confessare, come dice un moderno filosofo, il quale aveva
l’anima Spartana e le viste di , «che
l’usanza di cui si tratta conveniva solamente agli allievi di Licurgo; che la vita frugale e laboriosa, il costume
puro e severo, la loro naturale robustezza d’animo erano qualità e circostanze atte a
render innocente uno spettacolo così stravagante per qualunque popolo non d’altre
virtù posseditore che della sola decenza»
162.
[7] I Romani meno sensibili che non lo erano i Greci ai piaceri dello spirito oltre l’applicazione che sul loro esempio fecero della danza propriamente detta ad alcune istituzioni religiose e politiche, furono ancora i primi a introdur sul teatro la danza pantomimica. Dico che furono i primi, poiché sebbene trovinsi fra i Greci surriferiti alcuni gesti esprimenti un qualche fatto, ciò nonostante l’idea d’una intiera commedia o tragedia rappresentata da capo a fine senza il soccorso delle parole e col solo aiuto dell’azione non fu conosciuto per la prima volta fuorché in Roma sotto il comando di Augusto. Il mio metodo non mi permette il trattenermi a narrare i progressi di quest’arte sotto gl’imperatori, né i miracoli de’ celebri pantomimi che tanta impressione fecero su i Romani, e sì pericolosa influenza ebbero sulla loro libertà e su i loro costumi. L’Abate 163, il 164, e il 165 appagheranno ampiamente la curiosità di coloro che di sapere più oltre avessero vaghezza. Tuttavia due cose relative al mio assunto meritano di essere rilevate. L’una si è l’evidenza di espressione che conservavano i pantomimi nonostante la somma difficoltà che dovevano sentire nel rappresentare, essendo privi dell’aiuto degli occhi e della fisionomia a motivo della maschera, onde, come sa ognuno, aveano coperto il volto. L’altra l’energia del ballo pantomimico riconosciuta persin nel guasto che dava ai costumi, e nell’oscurar che fece la tragedia e la buona commedia con ogni altro spettacolo drammatico più giudizioso. La prima delle accennate osservazioni è diretta a far vedere di qual perfezione sarebber capaci fra noi le arti pantomimiche avendo mezzi più efficaci che non avevano essi per ben riuscirvi. La seconda può far temere una sorte uguale per l’odierna musica e l’odierna poesia, qualora si lasci al ballo un’illimitata licenza sul teatro senza restringerlo fra quei cancelli che prescrivono il buon gusto e la sana filosofia. Ma quali sono codesti cancelli? Tempo è ora mai divenire a disaminarlo.
[8] La pantomima può essere considerata sotto due relazioni differenti. La prima in quanto è un’arte rappresentativa somigliante alla poesia e alla musica. La seconda in quanto viene applicata al melodramma o come parte costitutiva di esso e coll’azione intimamente connessa, o come facendo classe di per sé qual semplice intermezzo frapposto tra atto ed atto.
[9] Considerata in genere come un’arte rappresentativa la pantomima è precisamente soggetta alle leggi stesse alle quali soggiacciono tutte le arti d’imitazione, cioè di dare alla spezial materia che scelgono esse come strumento tutta la possibile somiglianza coll’oggetto che vogliono imitare. Così perché la danza rappresenta le azioni umane per mezzo de’ muovimenti e de’ gesti, l’arte del bravo pantomimo consiste nel fare che i suoi gesti e i suoi muovimenti esprimano con tutta la verità ed evidenza compatibile coi principi dell’arte sua l’originale preso a rappresentare. Dissi a bella posta “con la verità ed evidenza compatibile coi principi dell’arte sua” affine di prevenir il sofisma di coloro che indicate vorrebbero nella imitazione delle belle arti tutte quante le particolari circostanze del vero, senza riflettere che l’oggetto di quelle non è la semplice natura ma la bella natura, e che l’arbitraria non meno che stitica teoria di quei pretesi filosofanti sbandirebbe ogni piacere ed ogni decenza dal teatro, facendo apparire in un ballo per esempio di villani o di marinari avvolti i danzatori fra le squallide vesti, coi muovimenti scompassati e colle maniere rozze ed improprie, che realmente in simili personaggi s’osservano. E ciò sotto pretesto di esatta rassomiglianza fra l’imitazione e l’imitato.
[10] Dalla necessità che ha la danza di esser vera e conforme nasce in lei altresì la necessità di esser chiara e distinta. Non basta che il danzatore faccia dei gesti e delle attitudini, bisogna che i gesti abbiano un senso e le attitudini un significato, il quale, essendo dagli spettatori facilmente compreso, faccia loro nascer tosto in mente l’immagine della cosa che vuolsi rappresentare. Senza questo requisito essenziale l’idioma de’ gesti è simile appunto ai simboli degli antichi egiziani, ovvero a quelli inintelligibili caratteri trovati dal celebre nei suoi viaggi alia Lapponia166. Ogni sentimento del cuore umano, ogni slancio di passione ha, come dice , i suoi tratti corrispondenti nel volto, nella voce, e nell’atteggiamento167. Il saperli afferrare e il combinarli fra loro, formando una serie ragionata, è quello che costituisce il vero linguaggio d’azione. Se nella serie accennata si trovano dei muovimenti che m’imbarazzano, o perché nulla significano, o perché hanno una significazione ideale, arbitraria, non fissata dall’uso e dalla convenzione, o perché non sono abbastanza connessi cogli antecedenti e coi posteriori, o perché distornano la mia attenzione dalla idea principale, o perché si distruggono a vicenda e si contraddicono; il linguaggio della pantomima è non solo cattivo, ma al fine delle arti imitative perfettamente contrario.
[11] Quindi le qualità generiche richieste nel ballo rappresentativo sono le stesse che esigono le azioni drammatiche, e gli argomenti della oratoria. Debbe cioè apparire la danza una, varia, ordinata, conveniente e patetica. Una, che rappresenti cioè un’unica azione principale senza divagarsi in episodi inutili e fuori di luogo, facendo anzi che tutte le sortite e le entrate, tutte le scene e le mosse corrispondano ad un solo oggetto168. Varia, che senza cangiar il piano generale dell’azione sappia svegliar negli animi degli spettatori la novità che nasce dai diversi incidenti somministrati dall’argomento169. Ordinata, che rappresenti le situazioni in maniera che le ultime cose si confaccino colle prime, e queste colle medie e colle ultime170. Conveniente, che nell’adattare ai personaggi i rispettivi gesti abbia sempre in vista l’indole della passione, i caratteri, il tempo, il luogo, e le circostanze171. Infine patetica, cioè che così acconciamente dipinga i movimenti propri dei vari affetti umani, che lo spettatore sia costretto a risentirli in se stesso172. L’ultima circostanza è più d’ogni altra legge necessaria alla pantomima, perché non avendo verun altro compenso, qualora non esprima una qualche situazione viva dell’anima, essa non significa niente. La ragione si è perché nessuna operazione dell’uomo porta seco un gesto animato e imitabile fuorché la passione. Un re che parla posatamente, un filosofo che silogizza (e in questi esempi si racchiudono tutti gli altri di simil genere) non sono modelli opportuni per un danzatore. Le smanie di Merope, le lagrime di Andromaca, l’iracondia d’Achille, le tenerezze di Aristea, il furore di Oreste, l’ansietà d’Ipermestra, e l’abbandono di Armida; ecco i gran fonti del gesto umano e per conseguenza della pantomima.
[12] Come la poesia ha i suoi diversi stili così gli ha parimenti la danza, e i vizi e le virtù di entrambe tengono regolati cogli stessi principi. Attitudini scherzose e festevoli nei balli buffi, nei tragici animate e terribili, maestose e gravi nei seri, vaghe e semplici nei boscherecci, vezzose e dilicate negli amorosi, regolari ed eleganti in tutti; questi sono i requisiti dello stile nella pantomima. S’aggiunge come prerogativa essenziale che debbano essere aggiustate, perspicue e scelte. L’aggiustatezza richiede che si dia alle cose il loro genuino colore senz’alterarle per eccesso o per difetto, acciocché il danzatore non incorra nella taccia di colui che cita, il quale facendo Aiace furioso si trasportò in modo e cagionò un tale scompiglio in teatro che si sarebbe detto che non contrafaceva il furioso, ma che lo era173. La perspicuità vuole che ogni gesto esprima con nettezza e precisione ciò che vuol rappresentare affinchè lo spettatore non sia indotto in abbaglio. La mancanza di questa virtù rende simile la espression pantomimica alle fosche nebbie, che addensandosi su una valle ne tolgono alla vista ogni vaghezza. La sceltezza esige che il danzatore, non contentandosi di cavar dal suo corpo i movimenti ovvi e comuni i si studi di svegliare e mantenere la sospensione con quelle mosse inaspettate e decisive così atte a produrre il loro effetto, e che sono il frutto più pregiato dello studio e del genio. Bello è il rappresentarmi Galatea nell’atto che scherzevolmente colpisce col pomo l’innamorato pastorello; ma la danzatrice non avrà altro merito che quello d’una imitazione volgare se non mi fa vedere ancora quel misto di ritrosia e d’amabile petulanza, quegli inviti significati in aria di ripulsa, quel chiaro e facile riso interprete non dubbio degli ascosì desideri, insomma quell’inesprimibile atteggiamento della ninfa, che fugge verso il boschetto, e fuggendo cerca di essere più attentamente guardata174.
[13] Dal semplice abbozzo esposto finora, si vede che l’arte pantomimica è capace di teoria ragionata al paro delle altre facoltà, e che potrebbe acconciamente scriversi la retorica e la poetica de’ ballerini, come e hanno scritto quelle de’ poeti e degli oratori. Ma lasciando cotal impegno (più utile e di maggior conseguenza che non si crede comunemente) ad altri scrittori più profondi, passiamo a disaminare qual uso possa farsi della danza nel melodramma.
[14] In tre maniere può questa entrare in uno spettacolo teatrale o accompagnando costantemente la poesia per tutto il tempo che dura l’azione, o in qualche determinata occasione soltanto, o come un intermezzo frapposto nel silenzio degli atti.
[15] L’unione delle belle arti e il fratellevole combaciamento che hanno insieme la danza, la poesia e la musica esigerebbe forse l’applicazione del ballo nella prima maniera, e così è fama che facessero gli antichi, appo i quali le intiere azioni tragiche o comiche si cantavano, si suonavano, e si ballavano nel medesimo tempo da un solo ed unico attore. Ma siffatto sistema eseguibile forse per poco tempo e mentre gli spettacoli erano sul nascer loro non poteva continuarsi allorché divennero essi più lunghi e più complicati. Così tanto i Greci che i Latini si videro astretti a sciogliere quella rigida alleanza delle tre arti distribuendo in diverse persone le moltiplici incombenze che dianzi erano affidate ad una sola. S’ignora chi fosse il primo nella Grecia a separare la pantomima della poesia; presso a’ Romani fu il poeta , il quale facendo, secondo il costume di quei tempi, da attore nella sua commedia, fu forzato dal popolo a ripetere diverse volte alcuni passaggi favoriti; per lo che ottenne la permissione di sostituire in suo luogo uno schiavo, che cantasse il poema insieme col musico mentre egli medesimo rappresentava la stessa azione col gesto muto175. In progresso di tempo anche questa usanza fu levata via, e la danza non accompagnò più la tragedia fuorché nei cori, o in qualche scena particolare. Ciò ch’essi fecero mossi dalla necessità, non potendo più reggere alla fatica, è stato poi confermato dalla esperienza e dalla sana ragione. La filosofia, ai dettami della quale fa d’uopo assoggettare non meno le facoltà appartenenti al gusto che le più elevate scienze, ha insegnato ai coltivatori di quelle che un discorso fatto simultaneamente allo spirito in due idiomi affatto differenti non può far a meno di non confonderlo, che se la danza dice lo stesso che la compagna il suo linguaggio diviene inutile, come diviene contraddittorio se dice l’opposto; ch’essendo la pantomima fondata sulla supposizione che debba parlarsi ad un uditorio di sordi o di muti, cotal supposizione diventa ridicola qualora si senta nel medesimo tempo sulla scena un altro linguaggio che distrugga l’ipotesi, e che se gli spettatori si prestano di buon grado ad un genere d’illusione, soffrono però mal volentieri di dover assoggettare la loro imaginazione ad un altro, il quale sia in contraddizione col primo.
[16] Strana non per tanto è da dirsi che fosse l’opinione del Signor , il quale desideroso di riunire a’ nostri tempi la danza colla poesia vorrebbe, appoggiandosi al testé citato esempio di , che i ballerini cantassero eglino stessi nell’atto di danzare, oppure che mentre danzano, una voce nascosta dietro alle scene spiegasse cantando l’argomento del loro ballo. Una siffatta idea è non meno stravagante a proporsi che impossibile ad eseguirsi. Lo spiritoso ed elegante autore del discorso intorno al poema lirico non ha riflettuto essere incompatibile colla natura del nostro canto sminuzzato acuto squisito e sottile l’azione violenta che richiede la danza, mettersi i polmoni e la glottide dei cantanti nell’atto d’eseguire l’arie in una posizione che verrebbe alterata necessariamente dal ballo o affatto distrutta, trovarsi nella poesia molte idee astratte, molte relazioni puramente riflessive e mentali che non potrebbono in verun conto eseguirsi dal ballerino, contener la musica strumentale mille artifizi, mille pitture degli oggetti esterni che non possono essere rappresentate coi piedi, dover non per tanto l’imitazione della natura riuscir imperfetta oscura ed equivoca, essere finalmente nel presente nostro sistema la simultanea riunione del ballo e del canto in una sola persona una caricatura non minore di quella che sarebbe il prevalersi d’una traduzione ebraica per facilitare l’intelligenza d’una lettera scritta in latino.
[17] Le ragioni che vietano l’accompagnamento perpetuo della danza nel melodramma, sono le stesse per doverla bandir eziandio come episodio. Un ballo improviso che venga sul più bello a sospender l’azione, indebolisce l’interesse e fa dimenticare l’oggetto principale. E siccome l’effetto d’ogni spettacolo dipende dalla costante e non interrotta impressione che fa esso sull’animo, così qualunque ornamento straniero che vi si frapponga diminuisce l’impressione, e per conseguenza l’effetto; tanto più se l’ornamento frapposto è di tal natura che invece d’agevolare l’intelligenza di ciò che dicono le parole, non serve che a renderla più difficile. Tale appunto è il ballo, il quale per essere meno naturale all’uomo che non è l’uso de’ vocaboli, ha un significato men chiaro e meno intelligibile perché men fissato dalla convenzione, e meno atto a rappresentare l’idee complicate e riflesse dello spirito. Si può nondimeno far uso talvolta di esso purché non si prenda come una vana ripetizione delle parole, o come una voglia indeterminata di ballar per ballare, ma come una usanza propria del popolo o dei personaggi che parlano, appoggiata sulla storia o sulla tradizione. Così perché la storia ci assicura che gli Spartani usavano d’un certo ballo particolare nell’atto d’azzuffarsi coi loro nemici in battaglia, non disdirebbe punto ad un poema melodrammatico che vi s’introducesse acconciamente siffatto ballo, come non disdirebbe nemmeno rappresentandosi un trionfo, uno sposalizio, un’allegrezza pubblica, una festa campestre, o nei funerali degli antichi, nei sagrifizi, nell’espiazioni, nei vari riti o costumanze delle nazioni. Così seppero felicemente innestarlo i Francesi come si vede nell’Orlando di , dove il ballo de’ pastori è a meraviglia legato coll’azione, e quello dei piaceri nel palazzo d’Armida, e quello delle Baccanti nella Lavinia, e quello dei lottatori nei funerali di Castore, e in più altri drammi. Ma s’avverta che in questi e simili casi la danza non è propriamente pantomimica, cioè rappresentativa d’una qualche azione determinata, ma soltanto un ballo figurato, che contiene l’espressione vaga d’un affetto passaggiero, o d’un costume nazionale, o lo sviluppo naturale di quell’attività momentanea frutto della giovinezza, del temperamento o della giovialità. Conseguentemente non deve innestarsi nel melodramma fuorché nelle circostanze accennate, e i poeti che si sono dimenticati di farvi riflessione hanno mancato alla filosofia dell’arte propria, come fece il Signore de’ introducendo a ballare nell’Orfeo le furie e le figlie di Danao insiem coi demoni nell’inferno quantunque nessuno al certo dovesse in tal luogo e da tali persone aspettarsi volteggiamenti e carole.
[18] Ci rimane a disaminare se deva o no legittimamente introdursi la pantomima in iscena come intermezzo tra atto ed atto. Se il fatto valesse quanto la ragione, il problema non farebbe nemmeno una questione, poiché basterebbe volger gli occhi a qualunque teatro per vedere quanto spazio di tempo ivi occupi il ballo, come interrompa smodatamente l’azion musicale, e a qual grado d’importanza sia oggi mai pervenuto, cosicché direbbesi non la danza essere un intermezzo del dramma, ma piuttosto il dramma un frammesso della danza. Nondimeno siccome i pregiudizi per quanto siano essi fissi e radicati altamente non distruggono punto l’essenza inalterabile degli oggetti, così riguardando noi la bellezza delle arti sceniche non già nella modificazion passaggiera che ricevono dagli abusi; ma nell’idea archetipa del bello assoluto ed intrinseco, siamo costretti a pronunziar francamente che l’usanza di frammettere la pantomima negl’intervalli del dramma è un’assurdità palpabile, un’eresia in materia di gusto che deve affatto proscriversi innanzi al tribunal del buon senso. Difatti se tutto ciò che distrugge il fine principale d’uno spettacolo è da condannarsi; se il fine principale del melodramma, come d’ogni altro componimento è di produr l’interesse; se niuna cosa contribuisce tanto a produr questo quanto l’illusione; se non è possibile ottener l’illusione ove manchi l’unità; se l’unità non può conservarsi qualora l’azione primaria non continui dal principio sino alla fine senza interrompimento, e se la pantomima è appunto quella che interrompe il progresso dell’azione, ne seguita dunque che la sua introduzione come intermezzo è condannabile perché viziosa e contraria al fine dello spettacolo. Comunque voglia intromettersi sarà sempre una mutilazione che si fa al melodramma, uno svagamento straniero che fa perdere il filo al restante, un riempitivo fuori di luogo che tronca il tutto musicale e poetico in parti independenti, le quali non producono l’effetto perché vien loro impedito lo scambievole rapporto. Se sarebbe cosa sconcia e ridicola in un oratore dopo aver diviso in tre punti la sua orazione, il mettersi a ballare ad ognuno dei punti frapponendo dei lunghi intervalli alla continuazione delle sue pruove, perché dovremo pensare altrimenti di cotesto stravagantissimo ballo che viene appunto a far lo stesso nel melodramma? E se sarebbe deriso uno storico, che sul più bello d’un racconto fatto in volgare mi saltasse in campo con un paragrafo tedesco che da Firenze portasse il lettore fino a Sarmacanda, e dall’epoca dei Medici perfino a quella di Tamberlano, perché il sorriso del buon senso non dovrà parimenti confondere la strana fantasia di coloro che, mentre io porgo attenzione al linguaggio della musica, mi saltano all’improviso fuori col linguaggio dei muti, e togliendomi per forza dal luogo dove sono, mi trasportano in un altro mondo dove non ho per ora genio d’andare e dove cercano di rapirmi il piacere del cuore per darmi in contraccambio quello degli occhi? I Greci, dai quali gl’Italiani si vantano d’aver tratto il loro spettacolo, cosiffatto abuso mai non conobbero. Le loro azioni drammatiche formavano un tutto non mai interrotto dal principio sino alla fine, e persino ignota fu a loro la divisione delle tragedie in iscene oin atti, nomi che noi abbiamo appresi soltanto dai latini autori. Ballavano essi, egli è vero, nella tragedia e nella commedia, ma il loro ballo era innestato col componimento, come lo era anche il coro, il quale non si dipartiva dalla scena per tutto il tempo della rappresentazione. Così fecero ancora i Romani in ciò che appartiene a non mischiare la pantomima colle azioni musicali. Erano queste presso a loro due cose affatto separate, e se ad imitazione dei Greci intromettevano la danza insieme col coro, non lo facevano essi se non rapportandola all’azione principale, come apparisce chiaramente da questi versi d’ nell’Arte poetica:
«D’attor le parti, e d’un sol uom sostenga,Quando bisogna il coro: e ciò che suoleCantar fra un atto e l’altro, al fin propostoBen s’adatti e convenga…»176
dove ciò che si dice del canto s’intende ancora del ballo che non s’eseguiva da altre persone, che da quelle del coro. Non è questo il luogo d’esaminare se male o bene fossero introdotti cotesto ballo e cotesto coro, né se i poeti conservassero l’uno e l’altro più per l’autorità imperiosa della religione, o d’un inveterato costume che per proprio sentimento177, ma sarà sempre vero a confusione di quelli che vorrebbono legittimare l’abuso coll’esempio degli antichi, che questi non introdussero mai la danza nelle azioni teatrali come un episodio straniero al soggetto, ed io sfido tutti i , e tutti gli dell’Europa a trovare un ballo pantomimico presso ai Greci e ai Latini che servisse d’intermezzo in una tragedia o in una commedia.
[19] Nello stato di decadenza in cui ricevettero i moderni l’arti musicali e rappresentative, e nella poca filosofia di coloro che furono i primi a restituirle, non è maraviglia che s’introducessero non pochi abusi avvalorati in seguito dall’usanza, e dal gusto del popolo. E fu probabilmente il desiderio di piacere a questo che sedusse gl’inventori della drammatica, determinandoli fra gli altri errori a troncar i componimenti per mettervi fra atto ed atto intermezzi d’ogni maniera, i quali facevano, a così dire, da ciascun atto una nuova azione. Giova fermarsi alquanto su questo curioso punto di storia per maggior istruzione dei lettori; tanto più che pochissimo o nulla si trova raccolto dagli scrittori delle arti italiane intorno alla prima introduzione del ballo e le sue vicende in quésta nazione.
[20] , nel dedicar che fa l’opere d’ suo zio agli accademici Alterati di
Firenze, asserisce essere stato desso il primo a condurre da
Francia in Italia l’uso dei balli.
Questo elogio non è che un ritrovato dell’amor proprio per accumulare nella sua famiglia
tutte le glorie possibili. Il ballo imitativo o pantomimico (giacché di questo solo è il
discorso) è tanto antico in Italia quanto il teatro. Nella
Calandra del Cardinale , la prima commedia in prosa recitata in
Italia furono eseguiti quattro balli bellissimi, dei quali
eccone la descrizione come la trovo in una lettera di inserita nella raccolta dell’ all’anno 1565. «Le intromesse (dic’egli scrivendo al
Conte Ludovico Canossa, vescovo di Tricarico) furono tali. La prima fu una
moresca di Jason, il quale comparse nella
scena da un capo ballando, armato all’antica, bello, con la spada ed una targa
bellissima; dall’altro furon visti in un tratto due tori tanto simili al vero che
alcuni pensorono che fosser veri, che gittavan fuoco dalla bocca ecc. A questi
s’accostò il buon Jason, e feceli arare posto
loro il giogo, e l’aratro, e poi seminò i denti del dracone; e nacquero a poco a poco
del palco uomini armati all’antica, tanto bene quanto cred’io che si possa; e questi
ballarono una fiera moresca per ammazzar Jason; e quando furono all’entrare, s’ammazzavano ad uno ad uno, ma non
si vedevano morire. Dietro ad essi se n’entrò Jason, e subito uscì col vello d’oro alle spalle ballando
excellentisissimamente; e questo era il moro, e questa fu la prima intromessa. La
seconda fu un carro di Venere bellissimo
sopra il quale essa sedeva con una facella sulla mano nuda; il carro era tirato da due
colombe, che certo parevano vive, e sopra esse cavalcavano due amorini con le loro
facelle accese in mano, e gli archi, e turcassi alle spalle. Innanzi al carro poi
quattro amorini, e dietro quattro altri pur con le loro facelle accese al medesimo
modo, ballando una moresca intorno e battendo con le facelle accese. Questi giungendo
al fin del palco infocorno una porta, dalla quale in un tratto uscirono nove galanti
tutti affocati, e ballorno un altra bellissima moresca al possibile. La terza fu un
carro di Nettuno tirato da due mezzi cavalli,
con le pinne, e squame da pesce, ma benissimo fatti; in cima il Nettuno col tridente ecc. dietro otto mostri, cioè
quattro innanti, e quattro dappoi tanto ben fatti, ch’io non l’oso a dire, ballando un
brando; ed il carro tutto pieno di fuoco. Questi mostri erano la più bizzarra cosa del
mondo; ma non si può dir a chi non gli ha visti, com erano. La quarta fu un carro di
Giunone pur tutto pieno di fuoco, ed essa
in cima con una corona in testa, ed uno scettro in mano sedendo sopra una nube, e da
essa tutto il carro circondato con infinite bocche di venti. Il carro era tirato da
due pavoni tanto belli e tanto naturali, ch’io stesso non sapeva come fosse possibile,
e pur gli avevo visti e fatti fare. Innanti due aquile e due struzzi; dietro due
uccelli marini e due gran papagalli di quelli tanto macchiati di diverso colore, e
tutti questi erano tanto ben fatti, Monsignor mio, che certo non credo che mai più si
sia finto cosa simile al vero; e tutti questi uccelli ballavano ancor loro un brando,
con tanta grazia quanto sia possibile a dire né immaginare. Finita poi la commedia,
nacque sul palco all’improviso un amorino di quelli primi, e nel medesimo abito, il
quale dichiarò con alcune poche stante la significazione delle
intromesse.»
[21] È probabile che gl’Italiani traessero la prima idea di
cotali rappresentazioni dalle azioni mute dei Francesi, presso ai quali erano in uso
anche prima. Lo assicura ,
testimonio di veduta, colle seguenti parole cavate dal primo volume della raccolta de’
migliori componimenti del teatro italiano ch’egli fece stampare nell’anno 1554, con
alcune note infine, in una delle quali parlando della Calandra dice:
«Onde a questi tempi in Francia sogliono rappresentare
quelle loro farse mute ove solamente coi gesti senza una minima parola al mondo si
fanno intendere con tanta gratia e con tanta sodisfatione degli spettatori, ch’io per
me non so s’ho veduto giammai spettacolo che più mi diletti e molto mi meraviglio, che
sin qui l’Italia, ove non si lascia indietro veruna sorte
d’operatione valorosa, non abbia incominciata a riceverle e rappresentarne ancor ella
ecc»
178. Questa lode è
tanto più dovuta a quella nazione quanto che in ogni tempo si è in tal genere di
gentilezza maravigliosamente distinta. Ciò nonostante gl’Italiani non devono escludersi
dalla gloria che giustamente ad essi appartiene. Tre fra loro seppero acquistarsi un
gran nome anche fra le nazioni oltramarine, e l’oltramontane.
[22] Il , di cui altrove se ne fece gloriosa menzione, fit l’inventore delle più leggiadre feste, e dei balletti più rinomati che fossero al suo tempo eseguiti nella corte di Catterina de’ edici, e in quella d’Arrigo terzo, tra le quali levò gran fama una intitolata Gl’incanti di Circe rappresentata nelle nozze di Margherita di Lorena col Duca di Gioiosa, dove si spesero venti millioni in circa della nostra moneta.
[23] Il , italiano anch’egli dimorante in Londra, verso il principio del passato secolo divenne celebre presso agl’Inglesi a motivo d’una singolare rappresentazione in ballo inventata e condotta da lui in occasione delle nozze di Federigo V. Palatino del Reno con Isabella d’Inghilterra. Lo scopo di quest’opera diretta non meno al progresso dell’arti imitative appartenenti al teatro che a far conoscere il merito della nazione italiana nel coltivamento di esse sembra esiger da me che se ne faccia in questo luogo la descrizione.
[24] Trecento gentiluomini rappresentanti tutte le nazioni del mondo e divise in varie truppe comparvero sul Tamigi sovra piccoli navigli ornati in foggia che annunziava la sontuosità e la leggiadria. Erano essi preceduti e seguitati da un numero infinito di strumenti che suonavano diverse sinfonie rispondendosi gli uni agli altri a vicenda. Dopo aver fatto mostra di sé avanti ad una moltitudine inumerabile, giunsero al palazzo reale dov’eseguirono un ballo allegorico, e magnifico sopra ogni credere. La religione, che univa la Gran Bretagna al resto della terra, era l’argomento di questo spettacolo. Il teatro rappresentava il globo terraqueo. Da una banda della scena vedeasi tranquillamente sdraiata la verità sotto il nome d’Alithia. Terminata l’apertura le Muse esposero l’argomento. Atlante comparve insieme con esse dicendo aver egli appreso in altri tempi da Archimede, che se trovar si potesse un punto d’appoggio fuori del globo sarebbe assai facile il sollevare tutta quanta è la massa della terra; a tal fine esser egli venuto dalla Mauritania nella Gran Bretagna creduta da lui questo punto così difficile a trovarsi, voler non per tanto smuover il globo e scaricarsi da un peso enorme che gli avea per tanti secoli gravate le spalle, consegnandolo ad Alithia compagna inseparabile del più saggio e del più illuminato fra i re. Dopo questo recitativo il vecchiardo accompagnato da tre Muse Urania, Tersicore e Clio avvicinossi al globo, il quale toccato con una verga tosto s’aprì. La prima ad uscire fu l’Europa vestita da regina, e seguitata dalle sue figliuole la Francia, la Spagna, l’Italia, la Germania e la Grecia, le quali avevano al loro seguito la Loira, il Guadalquivir, il Reno, il Tevere, e l’Acheloo. Ciascuna delle figliuole dell’Europa aveva tre paggi caratterizzati cogli abiti delle respettive loro provincie. La Francia menava seco un basso Bretone, un Normanno, ed un Guascone. La Spagna un Castigliano, un Aragonese ed un Catalano. L’Alemagna un Ongarese, un Boemo, ed un Danese. L’Italia un Napoletano, un Veneziano, ed un Bergamasco. La Grecia un Turco, un Albanese, ed un Bulgaro. Questo seguito numeroso danzò una spezie di prologo in ballo, e i principi di tutte le nazioni, che sortirono dal globo- con un sontuoso corteggio, danzarono successivamente facendo più sortite di diverso carattere coi personaggi che si trovavano sulla scena. Atlante fece sortire coll’ordin medesimo l’altre parti del mondo, lo che formò una divisione naturale e semplice del balletto, ciascun atto del quale fu terminato cogli omaggi, che dalle mentovate nazioni furono resi alla giovine principessa d’Inghiltera e coi magnifici presenti che le furono fatti.
[25] , inventore del dramma musicale in Italia nel lungo tempo del suo soggiorno in Francia dove, come in altro luogo179 si disse, era andato con Maria de’ Medici, e grandemente promosso in quella nazione il gusto delle cose musicali, si distinse ancora colle più gentili invenzioni ne’ balli eseguiti a Parigi, dove la danza era stata a gran incremento condotta. I balli, che in allora avevano voga presso ai Francesi, erano quelli detti della corte antica, ne’ quali fra gli altri compositori si distinse particolarmente . Formavano essi una spezie di dramma composto di parole e di danza. La poesia consisteva in qualche piccola canzonetta, a ciascuna scena delle quali si ballava in diversa foggia. La loro musica non meno che la loro cadenza consisteva in una serie di note lunghe lente e posate accompagnate dal pochi strumenti, e questi de’ più gravi, cosicché i brillanti giovani e le vezzose giovanette rassomigliavano piuttosto ad un coro di Certosini che volteggiassero, che non ad una truppa di giulivi danzatori.
[26] Vennero in seguito i balli tratti da soggetti allegorici
dove gli enti di ragione, e le figure imaginarie come il Riso, la Paura, l’Odio, la
Verità, l’Allegrezza, la Moda, la Curiosità, la Vendetta, e simili altre ballavano alla
foggia umana insieme cogli Uomini. Ma una imitazione così imperfetta che non aveva verun
modello nella natura, una rappresentazione così misteriosa che faceva pensare agli
spettatori tutt’altro che quello che s’offeriva ai loro sguardi, un linguaggio de’ gesti
così oscuro che mai non si comprendeva il significato, una serie d’argomenti dove tanta
parte n’aveva la fantasia, e tanto poca n’aveva il sentimento, un’arte insomma così
sterile che non somministrava alla musica né sentimenti né immagini, non poteva
lungamente resistere ai progressi della critica. Così dopo d’avere lusingata per qualche
tempo la vanità di coloro che si contentavano di far pompa d’ingegno colà dove
abbisognavano di far mostra di buon senso, sparì il gusto dei balli allegorici insieme
con quello degli acrostici, degli anagrammi, delle paranomasie, degli equivoci, delle
antitesi, e dell’altre argute putidezze ch’ebbero tanta voga nel secolo passato180. e
, quegli come poeta e questi come compositore,
furono i primi a dar qualche idea d’una danza teatrale più ragionevole. Sotto la
direzione del primo il canto s’intrecciò più felicemente col ballo in varie feste
teatrali rappresentate alla corte, in qualcheduna delle quali, cioè pel Trionfo
d’Amore ballò il medesimo re Luigi decimoquarto accompagnato dalla reale
famiglia, e dal fiore della nobiltà francese. Sotto la direzione del secondo s’udirono
per la prima volta l’arie dette di prestezza, perché in esse il movimento divenne più
vivo e la cadenza più marcata, dalla qual novità commossi secondo il solito gli
adoratori del rancidume si diedero tosto a gridare che la musica si corrompeva, e che il
buon gusto andava in rovina. Per fortuna dell’arte non badò punto alle loro declamazioni, e seguitò l’intrapresa
riforma contentandosi di segnar talvolta le figure e i passi a’ maestri di ballo, che
pon ben sapevano tener dietro al suo violino. Dalle arie di prestezza passò a quelle di
carattere, dando alle nazioni e ai personaggi rappresentati l’atteggiamento e le mosse
che convenivano loro, e si vide Plutone per la
prima volta conservar danzando la maestà propria d’un imperador degli abissi, e la
fuggiasca Galatea, e il selvaggio Polifemo, e i nerboruti ciclopi, e i satiri, e le
nereidi, e i tritoni uniformi insino allora e indistinti nell’arte di menar carole
cominciarono anch’essi a variar le loro danze, come variavano altresì le arie negli
strumenti. Il ballo divenne allora un ornamento essenziale del dramma, e vi fu impiegato
ora come parte costitutiva, ora come intermezzo. , e più altri compositori
di sommo merito perfezionarono a tal segno la musica de’ balli che
«al mio tempo (dice l’Abbate , da cui tratte abbiamo in parte le predette notizie) i maestri
assegnano fino a sedici diversi caratteri nella d’anca teatrale»
181.
[27] L’Italia frattanto non potendo uguagliare non che superare i Francesi, in cotal genere di gentilezza, contentavasi d’imitarli frammettendo balletti d’ogni maniera e graziosi intermezzi all’opere in musica tratti per lo più da argomenti buffi o mitologici. Di già erasi veduto fin dalla prima origine del melodramma , il quale all’altre sue abilità congiugneva quella d’essere danzatore bravissimo, inventar balli assai leggiadri per la rappresentazione delle pastorali da lui modulate e celebre fra gli altri divenne uno chiamato il Granduca. In seguito la corte di Torino si distinse in questo genere con vaghissime invenzioni. Diamone anche un qualche saggio di esse rimettendo coloro che più oltre cercassero alla storia della danza del e al bel trattato de’ balletti del gesuita .
[28] Il gridellino fu il titolo d’un ballo eseguito a Torino in un carnovale, così denominato perché tal era il colore di cui compiacevasi negli abiti la duchessa. All’alzarsi la gran tela compariva l’Amore, il quale, levandosi dagli occhi la benda, chiamava la luce invitandola che venisse a diffondersi dappertutto, affinchè dando alle cose co’ suoi colori mille forme diverse, egli ne possa scegliere quella che più a grado le sia. Giunone ode gl’inviti d’Amore e cerca di secondarli. L’Iride vola per ordin suo mostrando l’arco fregiato di mille colori un più vivo dell’altro. L’Amore dopo averli tutti osservati, ne sceglie il gridellino come il più vivo e il più perfetto, volendo che in avvenire codesto colore divenga il simbolo dell’amor senza fine. Comanda inoltre ch’esso si vegga brillare ne’ fiori, che traluca nelle pietre più preziose, che gli uccelli più rari se ne adornin le piume, e che serva di fregio agli abiti de’ più felici mortali. Tutte le quali cose avvivate dalla danza e da gran numero di decorazioni sorprendenti rappresentarono uno de’ più ingegnosi divertimenti in quel genere. Nella medesima corte si fece mostra d’un altro ballo assai leggiadro nel 1634. celebrandosi la nascita del Cardinal di Savoia. Il titolo fu: la verità nemica dell’apparenza sollevata dal tempo. All’aprirsi la scena apparve un coro de’ falsi romori e de’ sospetti, i quali givano avanti all’Apparenza e alla Menzogna. La parte più interna del teatro si scopri. Sopra una gran nube portata dai venti si vide l’Apparenza vestita a colori cangianti, e con piccole striscie d’argento collo strascico a guisa di pavone, e coll’ale. Veniva adagiata su una spezie di nido, onde sortivano le menzogne perigliose, gl’inganni, le frodi, le menzogne piacevoli, le lusinghe, gli artifizi, le buffonerie, le lepidezze, e le novelle galanti. Questi personaggi fecero per ordine le loro sortite, dopo le quali comparve il tempo, che mandò via l’Apparenza. Indi facendo aprir la nube su cui era venuto, si vide in lontananza un gran orologio d’arena, onde uscirono la Verità e l’Ore, che fecero varie mutazioni e sortite, dalle quali si formò il gran ballo.
[29] Ma la danza non era per anco pervenuta
nell’Europa moderna a quel grado di perfezione a cui, secondo i
suoi partigiani, era giunta presso ai Romani, a quel grado di perfezione cioè che nasce
dall’eseguire col solo aiuto de’ gesti e senza intervento alcuno delle parole una
intiera tragedia o commedia condotta
secondo le più esatte regole della drammatica. La gloria di condurla a tal segno era
riserbata ad una nazione tenuta fin allora comunemente più abile nel promuovere
l’erudizione e le scienze che nel coltivare l’arti di leggiadria e di gusto. I Tedeschi
svegliandosi ad un tratto nella carriera delle belle lettere, e di tutte quante l’arti
d’imaginazione, aveano fatto vedere all’Europa col mezzo di
, di , di , di , di e
d’altri poeti stimabili non meno che cogli ,
gli , i , i , i , gli , i
e tanti altri rispettabili professori di
musica quanto fosse stato indecente e ridicolo il quesito proposto dal , gesuita francese, «se un Tedesco poteva aver
dello spirito»
. Essi fecero ancora di più. Mostrarono d’averlo in quelle cose
che sembrano appartenere soltanto alla sveltezza ed agilità delle nazioni meridionali.
Verso l’anno 1740, offri agli occhi di
tutta la corte per la prima volta sul teatro di Dresda (altri
dicono su quello di Vienna) il Britannico del
eseguito nell’accennata maniera cui poi
tennero dietro l’Idomeneo di
e l’Alzira di . I Francesi
disposti ognora a perfezionare l’invenzioni altrui, e adatti per educazione e per
istudio alla scienza del ballo, si prevalsero tosto della scoperta rendendola in tal
guisa propria di loro che parve affatto francese all’altre nazioni. Contribuì non poco a
rinforzare la comun opinione il celebre
pubblicando le sue lettere intorno alla danza, dove partendo dall’esempio degli antichi
si cerca con molto ingegno e con eguale spirito di ristabilirla nelle forme e col metodo
usato da Ila, Pilade, e Batillo. Giammai
scrittore ha tanto nobilitato il ballo quanto . I misteri ch’egli vi ritrova sono così mirabili, l’eloquenza con
cui assalisce la fantasia per finir poscia colle gambe e coi piedi è tale che per lui
non istà se tutti i letterati non abbandonano le altre scienze per far i ballerini. Né
si contentò egli di letterarie specolazioni, ma volle ancora mettere in pratica quanto
colla voce e colla penna insegnava agli altri. Lodati furono e da tutti concordemente
ammirati la morte d’Ercole, l’uccisione de’
propri figli fatta da Medea, ed altri balli da
lui ritrovati e felicemente eseguiti sul teatro di Stougard sotto
la protezione del Duca di Vitembergh Mecenate
dichiarato delle arti drammatiche e musicali. La sua Semiramide inoltre
cavata da , posta in musica dall’immortale
e rappresentata in
Vienna fece quasi fremere dallo spavento e dalla sorpresa gli
spettatori lasciando in dubbio gli astanti se il prodigioso effetto che risentivano
provenisse dal terribile argomento, o dalla forza e semplicità dell’azione, oppure dalla
espressione e verità dell’armonia.
[30] Trovata in tal guisa la pratica e stabilita la teoria non è maraviglia che si propagasse subito cotesto genere di pantomima eroica nei teatri esteri, e per conseguenza in quelli d’Italia. , che s’era distinto a Parigi col famoso ballo di Telemaco allorché fugge dall’isola di Calipso, fu il primo a introdurre l’usanza di qua dai monti, dove prese gran voga e trovò maestri bravi e compositori eccellenti che perfezionaron la musica e rappresentarono i più rinomati componimenti182. campeggia in oggi fra gli altri non meno per la bravura nell’inventare e nell’eseguire che per le sensate dottrine esposte da lui nelle lettere scritte su questa materia. Dietro agl’insegnamenti di questo maestro e d’alcuni valenti Francesi, s’è coltivata altresì la pantomima comica, e quella di mezzo carattere cosicché il ballo rappresentativo può dirsi in oggi salito (se crediamo agli encomi de’ suoi partigiani) ad un grado di maggioranza quale non ebbe mai per l’addietro sulla scena italiana fra le mani principalmente di , di , di , di , di , e d’altri professori di minor grido.
[31] Dopo avere in succinto narrate le rivoluzioni del ballo pantomimico siami lecito in mezzo al plauso generale e le grida d’approvazione che dappertutto si sentono per così fatta scoperta, fare due richieste al rispettabile pubblico italiano. Questa mimica tanto da lui pregiata è ella veramente giunta al grado di perfezione che comunemente si crede? Nel caso che realmente potesse perfezionarsi converrebbe ai progressi del teatro il coltivarla con tanto impegno? Attendendo una convenevole e decisiva risposta, verrò svolgendo i motivi di dubbio che m’hanno suggerita l’idea delle due accennate interrogazioni.
[32] Un’arte qualunque ella sia, allora soltanto può dirsi aver toccata la perfezione quando i mezzi che adopera sono in perfetta corrispondenza col fine, quando la corrispondenza apparisce chiara e sensibile agli occhi dell’ottimo giudice, e quando gli effetti che ne risultano sono tali appunto quali l’arte stessa mi prometteva di produrli. Così conosciuto il fine che si propone una facoltà, disaminata la convergenza de’ mezzi che vi pone l’artefice, e ponderato l’effetto che in me cagiona il rapporto tra questi e quelli, io n’avrò una misura inalterabile e certa per giudicare dello stato d’essa facoltà. Il fine dell’arte oratoria è di persuadere, i mezzi che adoperava erano i più atti alla persuasione, egli otteneva l’intenta di volgere ovunque gli tornava in acconcio le menti e lo spirito dei Romani; l’arte oratoria toccò dunque la perfezione a’ tempi di quel celebre oratore. Lo scopo della musica è quello d’eccitar le passioni per mezzo d’una combinazione aggradevole di suoni. Presso a niun altro popolo seppe ella rinvenire le vie di conseguirlo come presso ai Greci; la musica greca fu dunque e dovette essere fra tutte la più perfetta. Per la ragione de’ contrari se conosciuto il fine ultimo d’un’arte in se stessa nol riconoscerò più nelle operazioni degli artefici, se vedrò che le linee tirate da loro invece di tendere ad un centro comune gli sono anzi divergenti, se attenuta non ritroverò né dalla parte di quella facoltà né dalla parte di coloro che la coltivano veruna di quelle magnifiche promesse che m’erano state fatte da essi; allora io conchiuderò (e conchiuderò con ragione) che o l’arte è fallace e imperfetta di sua natura, o che gli artefici lontano dall’averla perfezionata l’hanno piuttosto avvilita e corrotta.
[33] Applichiamo questi principi semplici, chiari e verissimi all’odierna pantomima.
[34] Qual è il fine che si propone la mimica? Quello di rappresentare coi gesti un’azione in maniera che s’ecciti in chi la guarda l’interesse e l’illusione. Che mi promette l’inventore d’un ballo teatrale? Di farmi distintamente comprendere l’azione ch’egli mi metterà sotto gli occhi, di regolarla colle leggi che prescrive il buon senso, d’accrescere maggior energia allo spettacolo drammatico riunendo la danza all’altre due sorelle germane la musica e la poesia. Che mi promette l’esecutore del ballo? Di non iscostarsi dal disegno propostogli dall’inventore, di scordarsi d’essere ballerino per non essere che pantomimo, d’usare di que’ gesti soltanto, la significazione dei quali essendo fissata da una convenzione generale e non dal capriccio, può facilmente essere intesa dagli spettatori. Ecco le belle parole che mi danno l’arte e gli artefici. Le attengono in pratica? Esaminiamolo.
[35] Non negherò già che la mimica, considerata in quanto è un linguaggio muto d’azione, non abbia in se stessa, come l’osservai sul principio del presente capitolo, una grande energia per generare l’interesse e l’illusione. Ciò che per mezzo degli occhi si tramanda allo spirito comunica, generalmente parlando, a’ nervi del sensorio delle scosse più efficaci e più veementi che non sono quelle che per mezzo degli altri sensi vi si trasmettono; perocché gli altri sensi non rappresentando all’anima se non se alcune poche qualità de’ corpi, e queste delle più inerti non isvegliano se non se uno scarso numero d’imagini, laddove per gli occhi manifestandosi tutto quanto è l’oggetto alla potenza visiva, e riconoscendosi anche le proprietà intrinseche dell’animo per mezzo de’ movimenti che partono da tutte le membra, la fantasia di chi lo riguarda ne raccoglie un maggior numero d’immagini, e il di lui sensorio ne riceve maggior copia di vibrazioni, onde i nervi subalterni che sono scossi più fortemente mettono in maggior esercizio la sensibilità, dalla quale in ultima analisi nasce l’interesse che ci attacca alle cose rappresentate. Da ciò ne conseguita che la mimica ha tutti i vantaggi della pittura e della scultura nella varietà, nella scelta, e nella forza delle attitudini avendo di più l’impareggiabile prerogativa di poter mettere ne’ suoi quadri una successione, un muovimento che mettervi non ponno i pittori o gli scultori condannati a non esprimere fuorché un solo atteggiamento nelle figure, né tampoco negherò che veduto non si sia un qualche ballo pantomimo in Italia, il quale ben composto, ben eseguito, accompagnato da una musica espressiva, e afferrando nella sua imitazione i tratti più caratteristici e più terribili d’un argomento, abbia prodotto sugli spettatori un effetto eguale e forse maggiore di quello ch’è solita a produrre la tragedia recitata. Ma quello che dirò sempre e costantemente affermerò si è che tali effetti della mimica, come si coltiva fra noi, sono accidentali, ch’ella ha dei vizi intrinseci che non potranno estirparsi giammai, e che se riesce bene una qualche volta per mille altre volte è uno spettacolo assurdo. La cagione si è perché la materia primitiva de’ gesti su cui s’esercita l’imitazion pantomima, essendo di già molto scarsa nella natura, è divenuta scarsissima nella società, cosicché si rende assai diffìcile, per non dire impossibile, il tessere un’azione di qualche durata che condotta sia colla necessaria chiarezza, e che interessi per la novità. Che l’idioma de’ gesti deva essere scarso nella natura apparisce da ciò che accompagnandosi ogni concetto mentale dell’uomo espresso al di fuori con due segni il gesto cioè, e la voce; ciascuno d’essi segni dee perder molto della sua influenzi a misura che prevale e si perfeziona quell’altro; dimodochè ove l’arte della parola è molto in uso, ed ovunque sia stata ad un cetto grado di raffinamento condotta, ivi l’espressione del gesto è più rara e meno efficace, come all’opposto dove il costume o le circostanze o la necessità diminuiscono il vicendevol commercio della voce, il linguaggio de’ gesti diviene più comune e più energico, siccome accade ne’ fanciulli, ne’ muti presso alle nazioni selvaggie, e in quegli stati altresì della politica società dove l’educazione o il rispetto, la convenienza o il timore impongono freno all’ardente e talvolta troppo pericoloso desiderio di spiegar con parole i propri sentimenti. Ora i progressi della società e il successivo sviluppo della cultura ci hanno messi appunto nel primo caso. Obbligandoci ad un numero senza fine di riguardi ci hanno costretti a stare in perpetua veglia sopra di noi. Prescrivendoci una compostezza che annunzia la disuguaglianza delle fortune e dei ranghi ci hanno ispirato un contegno che imprigiona la naturale scioltezza. Avvezzandoci ad una dissimulazione cui la malizia degli uomini rende necessaria, ci hanno parimenti insegnato a frenare i gesti perché non ci tradiscano a dare ad essi un significato contrario a quello che vorrebbe la natura, a reprimere i primi movimenti delle passioni, i quali appunto per essere i più genuini e i meno artefatti sarebbero i più acconci ad essere imitati dal mimo. La facilità inoltre di spiegare le nostre idee in un linguaggio ripolito abbondante e pieghevole ha renduta se non del tutto inutile almeno men necessaria la copia e la veemenza dei gesti. Conseguentemente a quanto si è detto la mimica eroica dev’essere più scarsa di modelli che non la pantomima comica, perocché nella prima l’influenza di quella qualità, che si chiama “politezza”, non può far a meno di non rendere i personaggi sublimi che vi si rappresentano, misurati, contegnosi, e lontani da quello sfogo spontaneo onde traggono i gesti la loro espressione; dovechè nella seconda la più rozza, o se vogliamo pur dirlo, la men travisata educazione, rendendo le persone imitate più spensierate e più schiette, fa sì che s’abbandonino al loro istinto con minore ritegno secondando più liberamente gl’impulsi della loro sensibilità.
[36] A siffatta scarsezza nella materia primitiva della danza s’aggiunge l’altra che risulta dalla costituzione intrinseca di qualunque lavoro rappresentativo. È impossibile ordire un’azione che abbia il suo cominciamento, il suo mezzo e il suo fine senza intrecciarla di mille circostanze che suppongono un significato convenzionale, una relazione, un rapporto, né può trovarsi alcun argomento dove non si faccia allusione frequentemente a cose passate o future, ad oggetti lontani o segreti, a riflessioni puramente mentali che non cadono sotto i sensi, per non dir nulla delle infinite idee accessorie e subalterne che hanno bisogno d’un vocabolo ad esser comprese, e senza le quali il voler continuare pel lungo corso di tante scene diverse una rappresentazione sarebbe lo stesso che l’accingersi a compiere un quadro senza prepararne opportunamente e degradarne i colori. Ma tali preparazioni, degradazioni e circostanze sono affatto perdute per la mimica, la quale circoscrivendosi come la pittura e la statuaria nella sua imitazione alle cose presenti, e incapace di significare le preterite o le future, l’idee di pura convenzione, l’interrogazioni, l’ironie, la speranza, l’agnizioni od altre cose somiglianti, è acconcia bensì a mostrare una rapida successione di quadri che siano in movimento e in azione, ma non può se non che troppo difficilmente farci vedere la connessione fra essi. Come ci farà ella, per esempio, conoscere ciò che dipende dalla memoria, come sarebbe a dire che Bruto nella Morte di Cesare è figliuolo di Giulio, che l’ebbe egli da Servilia sorella di Catone, che l’ha colmato insin allora di benefizi, e che ha fatto di già il suo testamento dove gli lascia un immenso retaggio? Come mettere avanti gli occhi l’idee riflesse di Bruto, i suoi rimorsi, le alternative tra l’amore della patria e quello del padre? Come far sapere a questo giovine per mezzo d’un gesto o d’una capriola, che Cesare è suo genitore? Come esporre alla vista ciò che accadde dietro alle scene cioè il biglietto trovato da Bruto sotto la statua di Pompeo, l’intrapresa di Marcantonio di voler incoronar Cesare re dei Romani, il simulato rifiuto del lottatore, le trame ordite dai congiurati? Come far sentire la gradazione diversa nei caratteri de’ personaggi, per esempio in Cesare la nobiltà dell’animo mista d’ambizione e di tenerezza, in Marcantonio il cortigiano che serve senza perder di vista il proprio interesse, in Cassio il republicano inesorabile, in Bruto lo stoico feroce che porta fin nell’esercizio della virtù, i pregiudizi della sua filosofia? Nessuna di queste cose, né molt’altre ancora può rappresentare la pantomima, eppure ognun vede quanto essenziali siano esse all’orditura di quella tragedia, cosicché chiunque levarle di mezzo volesse, verrebbe a tessere un insipido canevaccio anziché un ordinato drammatico componimento. Talmente avverrà in qualsivoglia azione continuata che si prenda ad imitare dalla mimica, la quale non potendo per mancanza intrinseca di mezzi proporzionati esporre agli occhi la legatura degli oggetti fra loro, né il risalto che acquistano dalla riflessione, altro non farà che mutilare sconciamente i teatrali componimenti, e rendere la propria imitazione confusa inintelligibile oscura, e per conseguenza non atta ad eccitare quell’interesse che mai non si genera senza la chiara percezion dell’oggetto. Come farebbe uno scultore che si credesse d’aver maravigliosamente espresso per aver messo in una serie di gruppi alcune figure ch’egli volesse far passare per Tito, Berenice, ed Antioco, ma che altri collo stesso diritto prender potrebbe per Ezio, Fulvia, e Valentiniano.
[37] Adoperando l’inventore dei balli uno strumento così difettoso come lo è una tragedia od una commedia fatta coi soli gesti non è da maravigliarsi che non possa mantener le promesse fatte allo spettatore. È bensì da stupire ch’ei non conosca la difficoltà d’eseguire ciò che promette, oppur conoscendolo, abbia il coraggio d’accingersi a così malagevole impresa. Peggio per noi se cotesto sconsigliato ardimento ci costringe a non vedere se non mostri ed enimmi sul teatro pantomimico. Per tali devono stimarsi la maggior parte degli odierni balli che ad eterna infamia di Tersicore, a perpetuo scorno del coturno e del socco sulle degradate scene italiane superbamente passeggiano. Balli, che niuna connessione avendo col dramma né pel genere, né pell’argomento, interrompono quell’unità ch’è la regola fondamentale d’ogni spettacolo, ne distruggon l’effetto generato in prima dal canto, mi trasportano violentemente dal buffo al serio e dal patetico al buffo, e quasi a colpi di verga incantata mi fanno all’improvviso passare dalle sponde del Tevere dove condotto m’aveva il poeta tra Romolo ed Ersilia o tra Clelia ed Orazio, al castello di Langres tra Eponnina e Sabino coi loro figliuoli, compagnia non per tanto di cui non potrei dolermi riflettendo a quella che toccò in sorte ad altri, che dall’isola di Lemno tra Isipile, Giasone e gli Argonauti si videro trasferiti dal pantomimo ai campi di Montiel in Ispagna tra Don Quisciotte e Sancio Panza, tra Rozzinante il più leale fra i cavalli e Ruzio il più mansueto fra i giumenti183. Balli dove niuna convenienza si serba al paese, al grado, al luogo e alla età dei personaggi, dove s’atteggiano nella stessa foggia il freddo svedese e l’Asiatico voluttuoso, il severo Bruto e il leggiadro Alcibiade, l’attempata e dignitosa regina e la fanciulla vivace, dove non si mette veruna differenza tra chi danza nel proprio gabinetto e che si diverte in sollazzevole compagnia, tra chi si trova oppresso da un amaro cordoglio e chi s’abbandona ad una spensierata allegrezza. Balli dove si fanno gambettare gli esseri meno a proposito traendo dal loro ritiro i solitari e penitenti bramini, e persin dall’inferno i non troppo galanti né troppo gesticolatori demoni, dove non solo si da senso e vita agli spettri (lo che pur si concede ai pittori ed ai poeti) ma si fanno vedere dibattendosi in iscena colle donne come nella Semiramide dell’; lo che sebbene formi un quadro spaventoso e terribile, fa tuttavia esposto sotto gli occhi troppo gran violenza all’imaginazione184. Balli per lo più di soggetto così recondito che pochissimi spettatori ne sanno la storia, d’orditura così complicata che non vi si può tener dietro da chicchesia, d’azioni così cariche d’episodi, che il principale si confonde e si travvisa nell’accessorio, di significazione così arbitraria che ad ogni sortita vi si vorrebbe il suo dizionario, ogni scena rassembra un indovinello, né cotal difetto d’oscurità si scontra soltanto nei balli dozzinali, ne sono ripieni anche i più celebrati. Io sfido il leggitore più acuto e lo spettatore più sagace a sapermi dire dopo averlo letto o veduto cosa significhi il seguente ballo di cui ne soggiungo in appresso la descrizione, il quale passando dai teatri di Francia in quelli d’Italia viene dai facoltativi considerato come il modello dei balletti chiamati di mezzo carattere.
[38] La scena s’apre rappresentando una pianura deliziosa posta in sulla riva del mare. Una truppa di danzatrici s’avvanza abbigliata in guisa che non sapete se greche siano od orientali, giacché le vesti teatrali eroiche pressoché tutte si rassomigliano. Viene quindi a non molto a scontrarsi con esse un’altra bella fanciulla vestita parimenti all’eroica, la quale parlando all’orecchio ad una delle anzidette, la scosta dal coro, e si danno scambievolmente ballando segni di tenerezza, senza che gli spettatori possano comprendere il perché. Ecco apparir in lontananza un vascello che veleggia verso la riva. I marinari sbarcano, adocchiano l’incaute danzatrici, e divisano fra loro di rapirle. Quella ch’era arrivata l’ultima fa degli sforzi per sottrar se stessa e la sua compagna dalla invasione. Un’altra truppa di marinari che sopraggiunge improvvisamente si scaglia contro la prima per rubbar quelle prigioniere, che con mille salti e scambietti esprimono la sorpresa e il terrore. Ma i rapitori stanchi della reciproca pugna vengono ad un accomodamento, i cui patti sono di dividersi fra loro l’amabil preda. Benché le greche si mostrino paurose non mancano di significare la loro paura cogli stessi salti, e coi passi medesimi con cui esprimerebbero la tranquillità e la sicurezza. Frattanto il fischio de’ venti, i cupi tuoni, i lampi interrotti, e il cielo che tratto a tratto nereggia annunziano la vicina procella. Una pioggia dirotta cade sul teatro accompagnata da fulmini. Durante la tempesta, le due truppe si ricoverano in una grotta che giace sulla riva del mare. Ivi le fanciulle non più impaurite si lasciano ammansare dai rapitori, mangiano, beono, e si trastullano con loro, escono mezzo ubbriache dalla grotta, intrecciano scompostamente una breve danza finché oppresse dal sonno e della stanchezza cadono sdraiate sul terreno insieme coi marinari che non le perdono d’occhio giammai. Né prima s’erano addormentate che si vede muovere verso la scena un fanciullo appariscente e bello come l’amore, ma in assai cattivo arnese, e pressoché intirizzito dal freddo. Le sue vestimenta sono ancor bagnate dalla pioggia. Egli si dibatte volteggiando per riscaldarsi, e dopo aver eseguito alcune fanciullesche riprese s’adagia con non soverchia decenza sul seno della danzatrice ch’era venuta in ultimo. Le greche si svegliano, si mettono attorno al fanciullo, il vezzeggiano, e consigliate da lui divisano d’uccidere i rapitori, e fuggirsene. Ma destatisi questi inseguiscono il pargoletto, che s’invola frettoloso ai loro sguardi. Tornate in iscena le danzatrici lo cercano dappertutto, finché trovatolo che s’era nascosto dietro ad uno scoglio, il riportano in mezzo alla scena, e danzano in segno di ringraziamento. In mezzo a siffatta allegrezza il fanciullo fa un cenno, lo scoglio si trasforma in un carro trionfale, sul quale egli ascende. Nell’atto di partire avventa un piccolo dardo contro alla giovine greca che resta facendo delle contorsioni apparentemente pel dolore della ferita. Le compagne la sollevano portandola dietro alle scene. Qui la decorazione si cambia. La grotta, il mare, il boschetto e la pianura spariscono per dar luogo alla piazza d’una città dove una folla di raccolto popolo sembra congratularsi a forza di salti colle danzatrici del loro fortunato ritorno.
[39] Ho cercato di mettere sotto gli occhi l’argomento dell’anzidetto ballo con una chiarezza che certamente da niuno fra gli spettatori si ravvisava sul teatro di Bologna dov’io lo vidi per la prima volta. Io stesso non lo compresi allora, né avrei giammai potuto comprenderlo se procurata non m’avessi in particolar modo la spiegazione. Eppure ancora dopo la mia esposizione chi è quel lettore che abbia capito rappresentarsi in questo ballo le Feste d’Imeneo? La giovane danzatrice essere Imeneo stesso travestito in ninfa per poter più liberamente vagheggiare la sua vezzosa Temira? Le compagne altrettante donzelle dell’isola di Gnido? Il fanciullo esser l’amore fratello d’Imeneo, che viene a secondar le sue brame? La freccia scagliata contro Temira significare la corrispondenza di questa ninfa verso Imeneo? Davvero, farebbe d’uopo diventar una Tiresia senz’occhi od una chiaroveggente sacerdotessa di Delfo per capir tutto ciò dalla sola rappresentazione. Sfido poi quel Tiresia e quella sacerdotessa a capire cosa abbiano a fare colle feste d’Imeneo la grotta, il mare, il vascello, i marinari, la tempesta con tutti gli altri episodi posticci ed inutili.
[40] A tale pressoché irremediabile oscurità comune alla maggior
parte dei balli credono d’ovviare gl’inventori del ballo, presentando il programma che
spiega l’argomento. Ma la necessità d’un sì meschino ripiego che spesso è insufficiente
a capir l’orditura, e che sempre ne distrae l’attenzione dello spettatore dividendola
fra lo spettacolo e il libro, non pruova ella più d’ogni altra cosa che i balli sono
altrettanti enimmi, i quali hanno bisogno di commento e d’interprete? «Ciò è lo
stesso, diceva un uomo di spirito, che se un pittore dopo
aver fornito un quadro mi presentasse nell’atto di mostrarmelo un paio d’occhiali per
poterlo vedere»
.
[41] Se grandi sono i difetti che si veggono nella composizione,
non sono minori quelli che nella esecuzione s’osservano. Privi per mancanza d’educazione
e di studio d’ogni idea filosofica dell’arte propria, i ballerini non sanno distinguere
ciò che vuole una danza artifiziosa da ciò che vorrebbe una facoltà imitativa, ma
mischiano l’una coll’altra, e la confondono in guisa che tu sei costretto a non vedere
che il danzatore colà dove non cercavi che il pantomimo. Ciò si scorge ora nell’adoperar
che fanno sì spesso e senza verun discernimento il ballo chiamato “alto” dai
facoltativi, il quale per ogni buona ragione dovrebbe dal teatro pantomimico onninamente
sbandirsi siccome quello che nulla immitando, ed ogni muovimento del corpo ad una
insignificante agilità riducendo, è inutile a produrre qualunque buon effetto
drammatico; ora negli atteggiamenti uniformi e consimili con cui si presentano in
iscena, cosicché in ogni circostanza, in ogni situazione, in ogni carattere ti si fanno
avanti colla testa sempre alzata ad un modo, colle braccia incurvate a foggia di chi
vorrebbe volare, coi talloni in aria sospesi, o premendo il terreno leggierissimamente
come se Ninia, Ulisse, Idomeneo, Telemaco venissero allora da una sala da ballo dove
pigliata avessero insieme lezione da uno stesso maestro; ora in quella smania di far ad
ogni menoma occasione brillare le gambe quasiché in esse riposte fossero l’imitazione
della natura e l’espressione degli affetti, e non piuttosto nei muovimenti delle altre
membra, negli occhi e nella fisionomia lasciati per lo più da essi pressocchè inoperosi
e negletti. Non così la intende il loro capiscuola , il quale nella decima delle sue lettere assai chiaramente e
distintamente intuona loro all’orecchio: «Se vogliamo approssimare l’arte nostra
alla verità, farebbe d’uopo curarsi meno delle gambe e dar più attenzione alle
braccia; lasciar le cavriuole per l’interesse dei gesti; abbandonar i passi difficili,
e far più conto della fisionomia; non mettere tanta forza nell’esecuzione, ma
apportarvi più senso; discostarsi senz’affettazione dalle strette regole della scuola
per seguitare gl’impulsi della natura; dare infine al ballo l’anima e il muovimento
che deve avere per generare l’interesse.»
Quindi è che gli eroi della favola o
della storia imitati dai ballerini fanno presso a poco la stessa figura che i personaggi
d’una tragedia rappresentata dai burattini, non comparendo meno sconcio né meno ridicolo
agli occhi di chi stima dirittamente un Vespasiano, per esempio, che vestito all’eroica e in maestoso paludamento
decide della vita di Sabino con una cavriola od
un mulinetto che un Augusto, il quale perdona a
Cinna col gesto e la voce di
Pulcinella: né contrario è meno all’idea della vera imitazione
drammatica l’introdurre, per esempio, Achille
librandosi con artifiziosa proporzion d’equilibrio in un “a solo” sulla punta d’un
piede, poi girando lentamente coll’altro, e dandosi leggieri gentilissimi calci
all’intorno nell’atto che si tratta di liberar Ifigenia dal sagrifizio di quello che lo sia il far vedere Pilade ed Oreste, che con un palmo e mezzo di statura vanno qua e là saltellando
pella scena guidati da segreti invisibili ordigni.
[42] Questi raffinamenti dell’arte mal applicati che travisano e sformano qualunque idea d’imitazione, hanno avuta nel ballo la stessa origine che nella musica. Perciò quanto s’è detto dell’una è perfettamente applicabile all’altro. E siccome abbiam veduto che i vizi introdottisi nella scienza armonica non altronde hanno avuto principio se non se dall’aver voluto i musici primeggiare colla sveltezza della loro voce o de’ loro strumenti senza curarsi punto della subordinazione comune, così il volerne ora i ballerini far pompa dell’agilità della loro persona e della destrezza delle loro gambe (nel che non può negarsi che molti e bravi professori non annoveri in oggi l’Italia) senza badare alla vera espressione degli affetti, quello è che ha rovinato la pantomima. Al che s’aggiunge come un altra causa il cercar di spiegare ad ogni modo col mezzo de’ gesti cose, che per le ragioni addotte di sopra non sono in verun modo spiegabili; onde avviene che i ballerini si veggano costretti parte per impossibilità, e parte per ignoranza a dar ai loro atteggiamenti un significato così strano, così capriccioso, così involuto che rimpetto ad esso diverrebono chiarissimi i cinesi gieroglifìci e la scienza simbolica degli egiziani. Potrei ad evidenza dimostrare quest’asserzione prendendo a disaminare le prima pagine, a così dire, del dizionario ballerinesco185; ma basti il fin qui detto per far comprendere al lettore che l’arte pantomimica o si riguardi la facoltà in se stessa, o si ponga mente all’invenzione e all’esecuzione, lunghi dall’essere stata condotta a quel segno di perfezione, cui giunta pur la vorrebbono a’ nostri tempi i suoi fautori, appena può dirsi che sia nella sua fanciullezza, della quale havvi ogni apparenza di credere che non sia per sortire così presto.
[43] Ma facciasi pure la supposizione che arrivi un giorno a perfezionarsi, converrebbe forse ai progressi del gusto lasciar che la mimica regni sulle scene dispoticamente, come fa ora, in compagnia del dramma? Permettasi ai miei giusti timori la dura sentenza che m’ispirano essi. Se vogliamo conservare gli altri piaceri più delicati e più gentili farebbe d’uopo assolutamente bandirnela. Il primo e più immediato effetto della pantomima sarà sempre quello di disgustarci d’ogni altro spettacolo drammatico agguisa dei liquori forti che incalliscono, a così dire, il palato, e insensibile il rendono al gusto più indebolito degli altri vini. Ella ha in se tutti i mezzi onde rendersi gradita dal volgo, e richiamare la moltitudine. Piace ai sensi, e ne parla d’una maniera efficace. Se la intende cogli occhi più facili ad essere ingannati che non lo sono le facoltà dell’anima. Mette in particolar movimento l’imaginazione. Coltiva una qualità comunissima all’umano spirito ch’è l’inerzia mentale, ovvero sia la cessazione di riflettere invitando lo spettatore a vedere senza obbligarlo a pensare. Dispensa da quell’attenzione laboriosa che richiede una tragedia recitata, od una commedia. Colpisce l’anima con una folla di sensazioni complesse, che tengono in perpetua azione la sensibilità. Unisce all’energia del gesto l’impressione vaga e indeterminata ma viva e voluttuosa de’ suoni. Offrendo alla vista le varie mosse, e le seducenti attitudini che possono prender le membra del corpo umano regolate dall’arte, risveglia altresì l’idee della bellezzan fisica, e con esse l’immagine dei diletti che ne vanno congiunte. Gli occhi veggono, la fantasia idoleggia, il pensiero si spazia per entro alle delizie create da lui
«Poscia al desio le narra, e le descrive,E ne fa le sue fiamme in lui più vive».
[44] Questo complesso di cause che producono quasi sempre il loro effetto, siccome rende ragione del trasporto che mostra il pubblico per la pantomima, così ne porge fondati motivi di credere che ovunque sarà coltivata quest’arte torrà infallibilmente la mano alla tragedia, alla commedia, al canto, e ad ogni altro spettacolo che abbisogni di più dilicatezza a comporsi, e di maggiore finezza a comprendersi. Bisognerebbe conoscere assai poco il sistema dei teatri italiani per lusingarsi che possa altrimenti accadere. Il volgo (e in questo nome comprendo non la sola plebe, ma tutti coloro che nella mancanza di coltura e di gusto s’avvicinano ad essa) il volgo, dico, è quello che regola gli spettacoli, e della sorte loro imperiosamente decide. Serve per tutt’altrove, ma nel teatro la moltitudine è la sovrana. Come dunque si può con qualche ragionevolezza aspettare da lei che diventi sobria di propria scelta e regolata nell’uso de’ suoi piaceri? Che voglia preferire i divertimenti men vivi e più difficili ad un altro più piccante e più facile? Che si procacci con una riflessione faticosa quel godimento ch’è sicura di conseguire in maggior dose in mezzo alla disattenzione e alla spensieratezza? Ah, che tale non è il pendio dell’umana natura, né tale l’esperienza costante di tutti i secoli! Si faccia riflessione ai progressi sorprendenti della mimica presso ai Romani, e si vedrà non solo il guasto che diede ai costumi, ma il danno che indi si derivò alla drammatica più giudiziosa, cosicché a misura che venne crescendo il regno de’ pantomimi disparve affatto dalle scene latine quello dei buoni poeti. S’attenda al piede che va ora pigliando in Italia, e se v’ha qualcheduno che assistito si creda da profetico spirito, mi dica di grazia cosa debba aspettarsi o temersi dalla sua pericolosa influenza.
[45] Nulladimeno la sua totale proscrizione potrebbe sembrar troppo rigorosa a più d’uno de’ miei lettori. Ned io contrasterò che atteso lo stato attuale degli spettacoli in Italia, dove la mancanza di ragionevolezza nel tutto rende pressocchè necessario un qualunque compenso, e attesa l’indole degli spettatori, cioè di que’ sibariti in materia di gusto, che vogliono il godimento senza la fatica di ricercarlo e che amano la diversità nei piaceri perché si confà colla loro intolleranza, l’esiliare affatto la pantomima dal melodramma sarebbe lo stesso che togliere un diletto di più senza rimediare alle altre sconvenenze che vi s’osservano. Però se si vuol lasciare si lasci, ma in guisa tale che punto non nuoca all’effetto del dramma spezzandolo e dividendolo negl’interatti, donde pei sovraccennati riflessi la vorrei esclusa irremissibilmente. So che mi s’opporrà in contrario l’usanza, ma io ho avvezzato tanto i miei lettori a non regolare i loro giudizi sull’esempio di essa, che un’autorità di più non avrebbe oramai a generare in loro un effetto diverso da quello che una scomunica del muftì produrebbe su un controversista romano. Dovrebbe soltanto la pantomima aver luogo terminato che fosse il dramma, e se questo sarà troppo lugubre e tragico, il ballo che vi s’introduce potrebbe convenevolmente essere d’un genere diverso; dal che ne risulterebbero non pochi vantaggi. Il primo di temperare la troppo forte impressione di mestizia che lasciata avesser nell’animo dello spettatore i tuoni imitativi della musica. Il secondo di non iscemar nell’atto della rappresentazione l’interesse prodotto dalla continuità dell’azione. Il terzo di schivar il difetto della trasposizione di scena nel tempo che si suppone esistere ancora quella del dramma, difetto che rinuova in certo modo sul teatro il miracolo della “bilocazione”. Il quarto vantaggio si è di poter rappresentare colla pantomima qualunque argomento senza discapitare nel buon senso; perocché allora si suppone che sia essa non un intermezzo ma uno spettacolo nuovo, il quale non è obbligato ad averne verun riguardo, veruna relazione col primo.
[46] Ma come riempiere allora (m’obbietterà taluno) lo spazio di tempo che resta tra un atto e l’altro del dramma? Nel modo stesso che suol riempirsi nella tragedia anzi più acconciamente. Il dramma musicale è una spezie di libro scritto nel linguaggio de’ suoni, e però fa d’uopo conservare dappertutto lo stesso idioma. La musica strumentale dee non per tanto seguitar a parlare nel silenzio degl’interatti mantenendo nel cuore degli spettatori le disposizioni che vi lasciò l’ultima scena, preparandoli a gustare i sentimenti che verranno dopo, e mettendo in tal modo una connessione, un vincolo fra tutte le parti dello spettacolo. Costume che riesce quivi assai meglio adattato e più naturale che nella tragedia o nella commedia recitata, perocché nel dramma si mantiene così facendo l’ipotesi ammessa fin dal principio, ma negli altri componimenti, essendovi soltanto ammessa la convenzione di parlare e non quella di suonare, il sentir poi gli strumenti che fanno in certo modo da interlocutori, non va disgiunto dal sospetto di piccola eresia in materia di gusto. Così quando dopo le vive agitazioni di Seid e di Palmira, che tanto m’aveano intenerito alla fine dell’atto quarto del Maometto, sento all’improviso la prima arcata dei violini, parmi che questi vogliano rasciugar le mie lagrime dicendomi: «Non istate a creder niente; non è altro che una traduzione dell’Abbate .»
Capitolo decimosettimo, ed ultimo §
Tentativi di riforma nel melodramma. Lettera d’un celebre letterato francese che contiene l’idea d’un’opera eccellente da farsi intorno alla musica.
[1] Tal è lo stato presente del dramma musicale italiano quale noi finora l’abbiamo descritto nel presente volume, e ne’ due ultimi capitoli del secondo. Il nostro divisamento è stato d’inoltrarci nella natura del gusto dominante, di risalire fino alle cagioni degli abusi, d’indicare paratamente i rimedi, e di ridurre la musica, la poesia, il ballo, e gli altri rami appartenenti a cotesto delizioso spettacolo a quella semplicità, e a quella verità d’espressione, alle quali dovrebbono aspirare tutte quante le arti imitative per conseguire pienamente l’effetto loro. Siccome lo scopo di quest’opera era di parlare principalmente dell’arte, e sol per incidenza degli artefici: così non s’è creduto opportuno il far menzione di tanti professori o passati o viventi, i quali, comecché meritino un qualche elogio per la loro abilità, non hanno però contribuito al miglioramento dello stile, o alla perfezione della musica. A maggiore e più compita illustrazione della materia io aveva pensato d’aggiugnere alcune riflessioni intorno alla storia della tragedia e della comedia italiana, e intorno all’influenza che deve avere sull’indole dello spettacolo lo stato attuale civile e politico dei costumi della nazione; ma i consigli di qualche amico illuminato e sincero m’hanno fatto cangiar opinione mostrandomi esser inutile il trattar brevemente di queste cose, e sconvenevole il trattarle alla lunga in up’opera che ha tutt’altro fine ed oggetto. Tanto più che l’Italia avrà fra poco il piacere di leggere le vicende dei due mentovati rami della drammatica esposte con molta erudizione e criterio nella Nuova Storia de Teatri che si va preparando in Napoli da un mio cortese e gentile amico, il Dottor Don , degnissimo segretario di quella Reale Accademia; della quale opera benché nulla abbia io veduto finora, ho però diritto di giudicarne anticipatamente e pel talento dell’autore di già conosciuto in altre sue stimabili produzioni, e per lo studio che attualmente vi pone nell’arricchirla di scelte ed opportune notizie. Per ciò che riguarda il secondo argomento vi sarà luogo a più ampiamente e più di proposito dilucidarlo in un altro libro di cui nella nota qui apposta troverà per ora il lettore una brevissima idea186.
[2] Altro non resta dunque per compiere l’intrapreso lavoro che il parlare dei mezzi imaginati da alcuni celebri autori per ricondurre la musica e la poesia drammatica al grado di perfezione, del quale la filosofia le credè capaci; perlochè m’è sembrato opportuno l’inserir per intiero una lettera del Sig. , stimatissimo scrittore francese, che può chiamarsi un capo d’opera nel suo genere per l’eccellenti riflessioni e per le viste utilissime che racchiude concernenti la filosofia della musica e delle arti rappresentative. Essa è diretta ad un celebre letterato della sua nazione, e contiene l’idea d’un’opera da eseguirsi intorno alla musica, ma che per isventura della filosofia e del buon gusto non è stata finora intrapresa. Essendo la suddetta lettera divenuta rarissima anche in Francia ho creduto di non poter meglio terminare l’opera mia intorno al teatro musicale che dandola tradotta a’ lettori italiani, e corredata con alcune mie note a maggior illustrazione dell’argomento. Al vantaggio non mediocre che gli amatori illuminati di siffatte materie potranno cavare da tal lettura s’aggiunge ancora un conforto non debole per il mio amor proprio quello cioè di trovare gran parte di quelle idee sparse nella mia opera, che da alcuni imperiti sono state riputate insussistenti, avvalorate dall’autorità d’uno scrittore non meno rispettabile per la sua filosofia che per la sua critica, e la sua erudizione.
Lettera sopra la musica indirizzata al Sig. Co. di e stampata l’anno 1754 §
[3] L’opera mia ha per oggetto la musica. Quell’arte deliziosa, che i saggi dell’antichità risguardavano come il dono più grande che gli dei avessero fatto agli infelici mortali, formò mai sempre la passione delle anime bennate, e divenne insieme lo scopo delle meditazioni, e delle ricerche de’ più illustri filosofi. Né ho difficoltà di asserire che fra tutte le materie questa è forse quella intorno alla quale gli uomini si sieno vieppiù esercitati. Ma da una banda il maggior numero di coloro che hanno professata quest’arte l’han considerata non altramenti che s’ella fosse una cosa di puro istinto e d’abitudine, ned hanno rivolto l’ingegno loro se non se a considerare la sua parte grammaticale, di cui ci esposero soltanto gli elementi; dall’altra poi i filosofi a niente badarono fuorché alle varie combinazioni de’ suoni fra loro, cioè a dire alla sua parte scientifica. Quanto a me, senza imbarazzarmi in una teoria, in ogni arcano della quale credo impossibil cosa il penetrare, sono d’avviso che guardar si possa la musica sotto un altro punto di vista ancor più vantaggioso de’ primi. Si sono finora limitati gli uomini ad insegnarci l’accozzamento de’ suoni, a ordinar de’ concerti, a conoscere i moti e le misure anzi che a darci a divedere le differenti energie di essa, a indicarci le forme particolari, alle quali la musica deve la sua possanza di commovere, e di dipingere, e ad illuminarci finalmente intorno all’uso che di tali forme dee fare chiunque voglia ottenere il suo intento. Noi abbiamo sopra l’archittetura, la pittura, e la poesia de’ trattati analitici ripieni di precetti e d’esempi, e la musica, quella di tutte le belle arti che più ci commove, quella che ha maggior imperio sugli animi nostri, è l’unica facoltà a cui niuno, ch’io sappia, ha prestato per anco il servigio medesimo. E siccome gli obbietti d’imitazione nella musica sono infinitamente più moltiplicati e molto meno costanti e sensibili che gli obbietti delle altre arti, avendo essa di più il privilegio di poter piacere anche allor quando non ottiene il fine di acconciamente imitare gli oggetti, così fa d’uopo convenire essere oltre modo difficile l’analizzar bene questa facoltà. Per altro l’abuso sorprendente che di tali obbietti fanno i più degli artisti, i quali non gli adoperano le più delle volte fuorché ad abbellire i capricci della loro fantasia, ne ha in tal guisa sformati i lineamenti, e confasi i caratteri, che si credette impossibile il ravvisarli. Pure a ciò sono diretti i miei tentativi. Io presento a’ musici la rettorica della musica, e quest’è l’oggetto mio principale. Dico così perch’io imprenderò a trattare lungamente della musica degli antichi, e di quanto ha relazione con essa. Confesso però ch’io debbo l’idea della mia opera, e i migliori mezzi onde sarà eseguita allo studio per me fatto della loro musica e in un della poesia loro. Quando si parla o si scrive sopra le belle arti, si sono giammai consultati gli antichi senza ritrarne gran frutto? Egli è vero bensì che la via d’intenderli bene e di gustarli non è tanto quella della discussione, e dell’analisi, quanto quella del gusto, e d’un certo tatto squisito somministratoci dal sentimento. Pare che que’ grand’uomini vogliano essere conosciuti nella guisa stessa ch’essi conobbero la bella natura. Io non riguardo adunque la musica, se non come un’arte imitativa ricercando e mettendo dinanzi agli occhi i mezzi, ch’ella pone in opera per riuscire acconciamente in tale imitazione. E a fine di procedere col miglior metodo che per me si potrà nella lettera che mi dò l’onore d’indirizzarvi, io mi farò imprima a scomporre la musica, e ne esaminerò in seguito separatamente le parti principali cioè il ritmo, la melodia, e l’armonia. Non già ch’io adotti questa divisione nell’opera mia. No, mio Signore, egli è impossibile il ridurre tutte le parti di essa a questi capi generali. Dopo molti e molti riflessi mi sono anzi avvisato che non potrei trattarla felicemente se non se dividendola per capitoli, giusta l’esempio delle istituzioni oratorie di .
[4] Gli antichi consideravano il ritmo come la principal parte della musica. Qui non cade in acconcio l’esporvi, o Signore, i differenti significati che gli autori più antichi e que’ de’ secoli posteriori attaccavano a siffatta parola. Allorché noi sappiamo indubitatamente che la musica loro era rigorosamente soggetta alla quantità, d’altro non abbiam d’uopo che di por niente al meccanismo della loro poesia per fissare insieme l’importante e vera forza di tal termine. E di ciò appunto io ne feci serio esame. A tutti è noto che il più bello e più squisito artificio della versificazione greca e latina consisteva nella combinazione delle sillabe brevi e lunghe. È palese ancora che le parole atte a formare la misura propria di ciascuna spezie di versi furono chiamate piedi o numeri secondo il maggior o minor numero di sillabe di che eran composti. I grammatici, i retori, i poeti ed i filosofi ancora han disaminate le varie proprietà di questi piedi e di questi numeri: e comecché una pronunzia esatta basti per farci sentire l’indole diversa, e le peculiari energie di tai piedi o numeri, pure ho creduto di poter dare un’idea di essi ancor più precisa e più chiara trasferendoli alla musica per modo che il valore d’ogni nota corrispondesse perfettamente a quello d’ogni sillaba. Con questo metodo così semplice ho veduto operarsi i più meravigliosi effetti. Il trocheo al dire degli antichi grammatici è un piede saltante, leggiero, pieno di forza e di nobiltà; cosicché noi leggiamo in 187 che quando la tragedia era un’intreccio di canti e di danze rusticane eseguite da un coro di bifolchi si adoperava in essa il verso tetrametro, il quale è composto di trochei. Ora una serie di questi medesimi piedi m’ha espresso il movimento proprio di gran parte delle nostre contradanze, e in particolar modo delle da noi chiamate “gavotte” e “vaudevilles”. La grandezza e dignità dello spondeo, che voleva che fosse consecrato ai canti religiosi, m’ha tornato in mente la sinfonia preliminare, e l’accompagnamento dei bassi del Juravit Dominus di , e l’apertura del suo Exurgat Deus, composizioni alla cui maestosa e sublime semplicità non potrebbero arrivare giammai li più studiati raffinamenti. 188 ci riporta che i Lacedemoni correano animosi alla zuffa, allorché i loro bellici strumenti facevano sentire l’anapesto; e difatti mercé la veemenza e l’impeto di questo piede riaccese negli animi loro il valor guerriero, che da molte reiterate perdite era quasi spento del tutto. I nostri artisti se ne prevalgono ognora ne’ canti bellicosi, e il Signor , benché non avesse posto giammai attenzione al passo di , pure m’ha confessato egli stesso che fa toccar di continuo l’anapesto in quelle sinfonie dove cerca di esprimere, imitandolo, il canto sublime e vigoroso di . Il giambo è vivo e pieno di fuoco, ed ha quindi il primo luogo ne’ soggetti ardenti ed appassionati. Lo stesso m’è venuto fatto d’osservare in tutti gli altri piedi da me indicati, ed ho ravvisato con piacere (e meco l’hanno parimenti ravvisato i più dotti artisti e gli amatori dell’arte, ai quali comunicai le mie esperienze) accordarsi esattamente l’osservazioni degli antichi colla natura, e gli esempi miei colle osservazioni degli antichi.
[5] Io debbo qui avvertire, o Signore, che la legge della quantità, alla quale s’assoggettavano i musici, non li costrigneva talmente che non potessero allontanarsene un cotal poco. osserva esser doppio il rapporto della breve e della lunga, e corrisponder la lunga ora a due brevi, ora a più di due, ora ad una breve e mezzo soltanto. Egli soggiugne in appresso esservi dei monosillabi assai più lenti e più tardi gli uni degli altri, e ad esempio ci addita le parole “stant tristes”; ove, come si scorge, il monosillabo “stant” esige una pronunzia più lenta e più durevole che in queste “stant acies”. Leggesi ancora nel medesimo autore (IX. 4.), che vi ha delle sillabe lunghe più lunghe delle une e dell’altre, e così delle brevi più brevi; “pallentes” per esempio, e “divini” sono del pari composte di tre lunghe: ad ogni modo e chi non s’accorge che la prima parola va più lentamente della seconda? Perlochè a questo corso più o meno rapido, più o meno lento de’ medesimi piedi io ho attribuita la principal cagione dell’estrema varietà e dell’irregolarità frequente del ritmo della musica antica. Io non poteva far conoscere a nostri musici tutti i mezzi che il ritmo appresta per l’imitazione, né poteva tampoco indicare la corrispondenza delle misure impiegate dagli antichi con quelle onde noi ci serviamo, senza metter in chiaro lume questa parte della loro musica onde mi sono inoltrato con tanto più impegno quanto più sapeva nulla essersi scritto finora di concludente su tale proposito, e M. medesimo essere malgrado la sua perspicacità e l’estesa sua erudizione incorso in grandissimi abbagli. Né mi dimenticherò di riflettere che ogni sorta di misura ha l’energia sua propria, e che siffatte energie non ponno trasferirsi, scomporsi, o simplificarsi, ove non se ne alteri l’espressione. Del che tenterò accuratamente di spiegar le ragioni, e soprattutto d’avvalorarle cogli esempi onde sieno meglio intese; giacché molte di tali sensazioni si devono collocare nel novero di quelle percezioni indistinte, che noi proviamo spesso senza poterle valutare, e quasi senza conoscerle. La musica dice, M. 189, non è a molti riguardi che un calcolo oscuro e secreto che l’anima fa senza esserne consapevole190.
[6] Da quanto ho l’onore di dirvi, o Signore, ne viene che gli antichi non ebbero il costume d’affastellar più note intorno ad una stessa sillaba, e che non conobbero punto le prolazioni191. Noi all’opposto ci approfittiamo talmente della libertà che ci lascia la troppo ignorata prosodia delle nostre lingue, che spezzando e ognor più accorciando i nostri suoni indeboliamo di giorno in giorno quella parte della espression musicale, ch’è fuor d’ogni dubbio la più vigorosa. Io voglio adunque persuadere a’ nostri musici quanto lor monterebbe di conoscere il meccanismo della loro lingua, e segnatamente di rivolgere l’attenzion loro all’energia de’ piedi onde ogni parola è composta. Io addito loro i moltissimi vantaggi che ne trarrebbono da questo studio. E primieramente mercè la scelta e il giudizioso intreccio di tali piedi, e di tali numeri essi perverrebbero a fissare, e a determinare l’espressione vaga, e sovente difettosa delle lor sinfonie. Mi farò in oltre a svegliare la loro emulazione mostrando il grado di perfezione a cui essi potrebbero inalzare la nostra lingua. La greca, che per la sua bellezza meritò d’essere considerata come l’opera degli dei, altro non fu che l’opera de’ musici. Del resto io son ben lontano dall’escludere tutte le prolazioni. Servono esse talora a creare di novelli sentimenti, e delle imagini novelle, nel qual caso sono da commendarsi assaissimo. Né intralascierò di indicare i luoghi ove queste suppliscono in un modo vantaggioso e superiore ancora ad una delle maggiori bellezze della lingua greca, voglio dire all’onomatopea, di cui ne fa tanto conto, che si lagna forte perché la lingua latina non ne sia abbastanza doviziosa. La nostra ci fornisce pur troppo pochissimi esempi. Porrò fine facendo di passaggio un qualche motto della lunga controversia che durò sì lungo tempo tra gli eruditi, e che non può ancora dirsi spenta intorno alla natura degli accenti. e il Padre furono di parere che non si potesse riflettere a questi nella pronunzia senza distruggere l’armonia del verso. Cosiffatti segni, l’istituzione de’ quali è posteriore d’assai alla bella età della lingua greca, non furono inventati se non per fissare i suoni di questo linguaggio veramente musicale in occasione che gli stranieri erano avidi d’impararlo considerandolo come il primo passo inverso la scienza e la coltura, e non già per alterare la quantità delle sillabe a cui erano apposti. Puossi pronunziare, e si pronunzia di fatti ognora una sillaba più alta e più bassa, senza che v’entri per niente la sua quantità, ed io non capisco il perché la maggior parte degli eruditi s’ostinano a slungare una sillaba che sarà breve di sua natura, ove unicamente sarà segnata con accento acuto; gli è questo un opporsi tutto ad un tratto al sentimento ed alla ragione distruggendo la bellezza principale, e l’artifizio il più felice della greca versificazione. Per quanto siasi beffato il celebre dei sapienti del suo secolo192, i quali confondendo in tal guisa i suoni coi tempi s’erano dichiarati in favore di questa difettosa pronuncia, ad ogni modo essi hanno avuto de’ successori, coi quali vengo alle prese, e oppongo loro delle ragioni invincibili, e senza replica cavate dalla cognizione della musica. Oltracciò le riflessioni da me fatte sopra il ritmo m’hanno naturalmente portato a dedurne delle altre intorno al meccanismo delle lingue, al loro genio, e al loro carattere. Avvegnaché vi sieno dei filosofi, i quali sostengono che parlando a rigore non avvi lingua alcuna che possa dirsi superiore ad ogni altra, e che le diverse qualità degli idiomi essendo puramente arbitrarie e dipendenti dai costumi, dagli usi, e dal carattere dei popoli non contengono cosa che meriti una preferenza esclusiva: io porto ciò nonostante opinione che sebbene le lingue sieno strumenti arbitrari e fattizi delle nostre idee, niente di meno questi strumenti ponno essere, e sono in realtà più aspri o più dolci, più lenti o più rapidi, più deboli o più forti gli uni degli altri. Prescindendo da ogni pregiudizio il suono d’un flauto è più dolce di quello d’un tamburo… Ma io non m’avveggo che qui mi fo a sviluppare le cose, quando voi non m’addimandate che un semplice abbozzo. Prima di passare alla melodia permettete, o Signore, ch’io ragioni un poco de’ modi della musica antica, che non differivano dalle nostre modulazioni. A dir vero noi ci sforziamo a rendere di giorno in giorno più giuste le inquietudini de’ saggi, i quali gridano contro alla decadenza del gusto. L’idea delle proprietà, e di caratteri insensibilmente dileguasi, e poco manca che le lettere e le arti non ricadano in quella confusione onde furono tratte dai riflessivi nostri antenati per opera appunto di coloro, la fama, e il grado de’ quali sembra che renderli dovesse non i distruggitori ma i sostenitori del decoro delle arti e delle scienze. S’è già posto in obblio avere la tragedia un diletto proprio di essa, e non comunicabile agli altri generi, come più non si pensa che il ridicolo è l’anima e il fondamento della commedia193. Noi ci promettiamo de’ nuovi e più squisiti piaceri allor che ne infettiamo le sorgenti, e ne confondiamo la diversa natura. Quello che parla all’imaginazione, che ne ricrea lo spirito, e lo sorprende, quello che porta seco un certo carattere di novità, e di singolarità è accolto e gustato contrasporto, e quasi direi con delirio. Ma basta egli che piaccia una cosa, perché debba essere accolta ed applaudita? E non fa egli d’uopo che il piacere che se ne ritragge, conciliar si debba colla ragione? Altrimenti cosa diremo a coloro che preferiranno l’archittetura de’ Goti e de’ barbari a quella de’ Greci e de’ Romani, il poema di a quello di , e le tragedie di a quelle di ? Gli antichi conobbero molto meglio il pregio della bellezza. Voi sapete fino a qual segno la tennero in considerazione. Non sì tosto la scopersero che si fecero un religioso divieto non dico di corromperla ma persin di metterla fuori di luogo; cosicché ne’ templi ch’essi ergevano agli dei, non solo faceano mostra delle più belle proporzioni, ma applicavano ad ogni divinità l’ordine che più s’acconciava al suo carattere. Il dorico pien di forza e di maestà fu consecrato a Giove sovrano degli dei e degli uomini, il corintio che spira eleganza e dilicatezza fu destinato a Venere madre degli amori e delle grazie; e quest’attenzione ch’essi mettevano universalmente nella pratica di tutte le arti, la portarono con la scrupolosità la più grande alla musica. Ogni soggetto avea il suo modo, da cui era disdetto l’allontanarsi. dopo aver notati i differenti generi di musica soggiugne che ognuno di questi avea un modo e un’energia sua propria, e che il carattere dell’uno non si affacceva all’altro. paragona una vita menata in mezzo a’ disordini ad una melodia ove entrasse alla rinfusa ogni maniera di ritmo. E ciò mi torna a mente un tratto singolare, che mi fia permesso di farvi noto. L’anno 1751, alcuni musici ottennero dal re il permesso di formare un’Accademia di musica a Parigi, ma per quanto dilettosa ella si fosse, non essendo né diatonica, né cromatica, ned enarmonica, ma piuttosto un intreccio confuso di questi tre generi194, e ciò ch’è più, discorrendo questa per diversi modi in uno stesso soggetto, il presidente Dudrac e tali altri membri del Parlamento deputati all’esame di simile novità la riprovarono e la bandirono con particolare decreto. Mi sarebbe lecito di avventurare una riflessione intorno ad una condotta così singolare? Questi magistrati temettero senza dubbio riguardo a’ costumi de’ Francesi que’ tristi effetti che presagiva a’ costumi de’ Greci, ove eglino permettessero che il disordine, la confusione, ed anche il solo cangiamento entrasse nella loro musica195. La lettura di formava l’occupazione e le delizie de’ sapienti di quel secolo, e le inquietudini del filosofo ateniese dovettero fare vie maggior impressione nel cuore de’ magistrati avendo l’agio di osservare in , in , e in , che la decadenza della musica de’ Greci seco trasse anche quella de’ loro costumi. Ma tornando a noi, la musica de’ Greci fu nella sua origine in tal modo semplice che ogni strumento non avea che un modo solo196. E questo ci rende ragione della quantità prodigiosa de’ loro strumenti, e in un ci scopre come essi giunsero a formarsi delle proprietà e de’ modi un’idea così ben fondata che giammai li confusero insieme. Io so che rigorosamente parlando v’hanno due modi, il maggiore e il minore: e contuttociò un pezzo di musica d’un genere grande rimane tanto sfigurato, ove si voglia trasportarlo ad un’altro genere quanto resterebbe un opera di gusto trasferita da una in un’altra lingua. Di ciò non può dubitarsi in verun conto. Sì: ogni modo o modulazione ha la sua energia, la sua proprietà; ed è talmente vera questa proposizione che non havvi suono il quale ne sia privo. E se i musici si mostreranno ritrosi nell’accordarmela, io dimanderò a loro donde nasca ch’essi tutti spinti da un senso interiore impieghino i re maggiore ne’ canti romorosi e bellicosì, l’ut minore ne’ soggetti teneri e lamentevoli, e il fa minore nelle cantilene tetre e lugubri? Or io esorto appunto i nostri compositori a non confondere le proprietà de’ modi da loro impiegati, a rintracciarne quelli ch’essi trascurano, e a porli in opera acconciamente. Per riuscirvi non si avrebbe mestieri che di prescrivere un tuono, e di fissarlo per tutti i concerti dell’Europa. Tal mezzo non potrebbe essere più semplice, e più vantaggioso insieme. In cotal guisa ci verrebbe fatto di comprender lo spirito, e la verità dei diversi componimenti che dovrebbono eseguirsi; i nostri organi acquistarebbero un’aggiustatezza più decisiva e costante, e la nostra perspicacia in distinguere e separare la natura d’ogni modo s’adopererebbe con maggiore avvedutezza, e con sicurezza maggiore. Potremmo eziandio comparare allora i nostri tuoni con quelli degli antichi, e venirne a capo, avvegnacchè io non possa convenire con M. , il quale pensa che il nostro minore risponda al modo dorico affaccendosi assai poco la gagliardia e la maestà che attribuivano a questo modo gli antichi, alla molle dolcezza del nostro “A-mi-la”. Del resto s’io rivolgo il pensiero alla severità della musica antica, non perciò pretendo di ristabilirla; voglio bensì che il musico conduca un medesimo soggetto per diverse modulazioni, purché queste rendano più interessante e più forte l’espressione, e che innanzi ad ogni altra cosa abbia egli in vista d’afferrare quella giusta ed adeguata misura, fuor della quale fuggono, e a così dir, si dileguano tutte le bellezze di quest’arte. Quanti pezzi sublimi non languiscono e non restano impiccioliti o per isregolatezza di fantasia, o per la smania di mostrare spirito e profondità! L’imitazione è un solo tratto, un punto, a così dire, ove l’arte e la natura si uniscono e si prestano vicendevolmente abbellimento ed aiuto. Ben avventurato l’artista che sa coglierlo! E più felice ancora colui che dopo aver toccato il segno, non lo lascia smarrire di nuovo!
[7] La melodia è un campo feracissimo di osservazioni, ma io non farò che sbozzarne i principali caratteri. Definisco la melodia in generale, o quello che noi chiamiamo “un bel canto” una tessitura di suoni omogenei e proporzionati che hanno un intimo legame fra loro, e ch’esistono in qualche guisa da sé. E siccome giusta l’osservazione de’ veri filosofi il canto in ogni lingua debbe essere sì vario come lo è l’accento naturale, (poiché altrimenti ciò ch’esprimerebbe bene una passione in una lingua, la esprimerebbe male in un’altra) così io soggiungo che codesti suoni debbono essere conformi a quelli di cui abbonda il linguaggio della nazione. Distinguo la melodia libera da quella che non lo è. La melodia libera, la strumentale a modo d’esempio può scorrere a suo grado per tutte le idee musicali che si vorranno, e per quanto vaga e indeterminata sia la sua espressione, purché riesca grata ed uniforme al gusto generale ella ne ha sortito l’intento. Non avviene lo stesso della melodia obbligata, o vocale. Abbia questa tutte le bellezze e le ricchezze possibili, pure può essere difettosa oltre modo; e di fatti lo è sovente. Imperocché essendo una seconda espressione de’ sentimenti e delle imagini che si ricercano, essa non debbe essere toccante, viva, allegra, maninconica, dolce e terribile, se non quanto lo permettono le parole197. Onde può rilevarsi a qual segno monti a nostri compositori il fare uno studio serio e profondo non solo delle differenti proprietà de movimenti e de’ modi, ma ancora di quelli de’ suoni; studio che gli antichi aveano molto a cuore, e che caldamente raccomandavano ai principianti, come la parte della musica la più utile all’eloquenza e in cui mostrerò a qual grado di perfezione essi salirono.
[8] Io applico alla melodia quel riposo di cui son tanto gelosi i pittori e gli architetti. La mancanza di questo induce dell’imbarazzo, e del disordine in tutte le parti, e per esso nella musica lo spirito gode del canto presente di quello che lo ha preceduto, e si accorge in certa guisa del canto che dee venire in appresso. Bellezza inestimabile e negletta per disavventura dalla maggior parte de’ nostri artisti anche più celebri. Io osservo che nella musica più che in ogni altra arte v’ha de’ luoghi che si dovrebbero trascurare, o levar via del tutto, imperocché quanto più un’arte è dilettevole, altrettanto è vicina a generare la sazietà. , e insieme , hanno giudiziosamente notato che il merito principale delle dissonanze è di preservar l’anima dalla noia insopportabile d’una continua e non mai interotta dolcezza. Io farò che tutto ciò comparisca più evidente per mezzo di esempi; e siccome non parlo a prima giunta che della sola melodia francese: così li traggo dalle opere de’ nostri più rinomati autori. Poscia mi rivolgo al canto italiano, il quale giusta la definizione per me data innanzi della melodia, e giusta le osservazioni ch’io farò su d’esso trattando dell’analogia del canto colle lingue, debbe così differir dal nostro, come l’accento, le inflessioni, il meccanismo della lingua, e i costumi degli Italiani differiscono dalla prosodia, dai costumi, e dal genio de’ Francesi. Porrò a confronto ciò ch’han detto della musica italiana alcuni personaggi ragguardevoli per la varietà e l’ampiezza delle loro cognizioni, con quello che ne han pensato i più grand’uomini dell’Italia198, e tenterò infine di scoprire le cagioni della sua seduzione, e della sua magia, mostrando che la monotonia di cui noi l’incolpiamo deriva meno dall’uniformità dei tratti, delle combinazioni, e dei riposi del nostro canto che dall’uniformità del suo andamento. Soggiugnerò che le forme del canto italiano non sono né più abbondanti né più varie di quelle del nostro, ma che la musica italiana debbe in gran parte l’interesse e l’incanto ch’ella produce, al contrasto che v’è fra la maniera secca e quasi direi urtante del suo recitativo colle grazie e colle dolcezze dell’aria199. Farò ravvisare ad un tempo stesso l’intreccio felice de’ suoi modi, la finezza de’ suoi passaggi, la bellezza de’ suoi episodi uniti mai sempre al soggetto, e sopra ogni altra cosa l’artifizio ammirabile con cui sono sviluppati i motivi. Mi fo lecito d’assicurarvi, o Signore, che trattando siffatta materia, io cercherò di farlo con quel candore e con quella imparzialità che si richiede da chi ama e tiene in pregio il bello, ovunque lo ritrova. A me piace fuor di modo la musica italiana, ma non perciò voglio rassomigliare a quegli amanti appassionati che adorano fino i difetti delle loro belle200. I dotti i più giudiziosi e più illuminati dell’Italia traveggono de’ difetti e de’ vizi nella lor musica, e perché dunque ci faremo noi coscienza di osservarli entrando nel medesimo loro sentimento? Del resto, perché la poesia italiana è dotata d’un’arditezza maggiore, perché ha più di spirito e di brio che non la nostra, perché abbonda di tuoni più felici fa d’uopo perciò avvilire la poesia francese? Ma a miglior agio riserbiamo cotale riflessione, e vegniamo intanto all’armonia.
[9] Il maggior numero dei dotti che hanno penetrato più addentro in questa parte della musica, vuol concordemente che fosse sconosciuta agli antichi. Il Signor fra gli altri ha esposta quest’opinione con un’erudizione così profonda che parve non lasciar più adito alcuno a chi volesse sostenere il sentimento opposto; ma per quanto rispetto io porti alla memoria di questo sapiente accademico non posso aderire ciecamente al giudizio di lui. Ho letto le opere sue colla possibile attenzione, e in mezzo al grande apparato di dottrina, onde avviluppa, e involge i suoi pensamenti v’ho tuttavia rilevato delle dubbiezze, delle oscurità, delle contraddizioni, e degli sbagli. Ardisco adunque di ravvivare la disputa che sembrava conchiusa da lui, e reco a pro dell’opinion mia una folla di passaggi, dai quali sfido chiunque a trarne un senso favorevole ove non suppongasi la cognizione, e l’uso dell’armonia presso agli antichi. Io convengo nientedimeno che le nostre idee su tale proposito sieno di gran lunga superiori alle loro cognizioni. L’arte delle fughe, delle imitazioni, dei disegni opposti e in contrasto fra loro, quel concorso di dissonanze, quelle ardite combinazioni, tutto era ad essa nascosto: ma queste ricchezze che stan così bene che nulla più alla musica istrumentale, non convengono per niente alla vocale. Io distinguerò i luoghi di cui l’uso savio e moderato reca nuovo abbellimento e nuovo vigore all’espressione, da quelli che non servono ad altro che a procacciar fama di scienziato al compositore. Cercherò di render note le particolari energie degli accordi risguardati dalla parte delle proporzioni, e non già relativamente ad alcun oggetto. Passerò in appresso all’armonia di situazione ovvero sia di carattere, e la ravviserò come quella corrispondenza di mezzi, che adoprano tutte le arti imitatrici cogli oggetti che devono da loro imitarsi. In tali circostanze i suoni meno atti ad unirsi insieme, gli accordi i più disparati, e più aspri si cangiano in altrettante bellezze squisite e sublimi. Di tal maniera i piaceri dello spirito e della ragione devono preferirsi a quelli de’ sensi. Io parlerò poscia delle più intime squisitezze dell’armonia, e di tutti i mezzi ch’essa ci offre per l’imitazione. Osserverò soprattutto quanta diligenza vi si debbe prestare per non esporsi a quelle gratuite ripetizioni che il senso delle parole non vorrebbe, e che s’adottano soltanto pel bisogno di afferrar di nuovo le prime modulazioni.
[10] Dopo che vi ho accennati, o Signore, e sviluppati per quanto ad un estratto si conviene, i mezzi, onde si prevale la musica per giugnere al suo scopo ch’è l’imitazione, vengo al più importante oggetto dell’opera mia, ch’è l’imitazione medesima. Questa si rappresenta alla mia mente come il principio universale di tutte le belle arti, la cui natura, e le cui proprietà non potrebbero alterarsi per quanto fossero differenti fra loro i mezzi, e lo strumento, e le vie prese da ciascuna delle arti per riuscirvi. Io fo qualche motto in appresso del mezzo principale, onde si valeva la poesia antica a compiere la sua imitazione. Essa giusta il parere dell’Ab. otteneva ciò mercè quella misura invariabile composta di differenti parole, la modulazion delle quali variavasi all’infinito. Ma come quest’illustre accademico s’era egli dimenticato che e non han giammai dichiarato essenziale al poema il verso? Tali altri fondano l’essenza della poesia nelll entusiasmo, ma (parliamo di buona fede) l’entusiasmo è egli mai il carattere esclusivo della poesia? Si rinviene egli mai presso agli antichi la menoma prova, la più picciola conghiettura di siffatta opinione? Essi ci rendono consapevoli all’opposto che l’opere di , di , di , e di , comecché fossero scritte in versi, pure non furono giammai comprese nel numero de’ poemi, non perché loro mancava l’entusiasmo, ma perché era da loro sbandita la finzione. Egli è non pertanto indubitabile che col mezzo della finzione e della favola, la poesia antica formava la principal sua imitazione, ed è perciò che gli antichi l’hanno mai sempre risguardata come l’essenza della poesia201.
[11] Coloro che non abbracciano siffatta opinione ricorrono all’autorità de’ Latini, ma non s’avveggono che questi non aveano e non doveano aver nemmeno della poesia la medesima idea che i Greci, i poeti de’ quali furono i primi teologi, i primi legislatori, ned altro fecero che comunicare alla loro nazione la sapienza ch’essi ritraevano dagli Egiziani unita alla maniera di metterla in opera. I più degli autori moderni che han trattato di tale materia, anzicchè svilupparla e rischiararla l’hanno involta in maggiori tenebre, e confusione; lo che nacque dal non avere studiata accuratamente l’origine, e il genio della poesia antica. La semplice filologia non giugnerebbe mai a dilucidare queste materie. Siccome essa non si propone che di cucire, e tessere insieme de’ testi separati capevoli di varie interpretazioni, sui quali può ognuno profferire il proprio giudizio; così d’ordinario non fa che moltiplicare inutilmente i trattati, e i sistemi. Io ho voluto tanto più applicarmi all’esame di questa parte quanto più vedeva l’affinità di essa col mio soggetto, sendochè il canto era inseparabile dalla poesia degli antichi, appo i quali l’arte di comporre in versi era secondo l’Abate l’arte d’unire delle parole acconcie ad essere cantate, com’io proverollo più a lungo parlando della loro declamazione. Quindi io ritorno ai mezzi che la musica adopera per imitare, e dopo averli esaminati separatamente, osservo come tutti insieme concorrono a formare una buona imitazione. Vengo in appresso alle imitazioni particolari, e subordinate, ch’io divido seguendo l’esempio di in icastiche e fantastiche. Chiamo icastiche, o similitudinarie quelle che hanno per oggetto le cose non adatte alla fantasia, e tutti gli esseri fisici; chiamo fantastiche quelle che rappresentano gli esseri morali e le idee della imaginazione, che non hanno una certa e determinata corrispondenza cogli oggetti esterni. Metto in vista tutta l’indecenza e la scurrilità delle imitazioni istrioniche. La migliore imitazione, dice , è la più semplice, e la meno semplice è quella senza dubbio che vuol tutto imitare. Vò scorrendo tutti i tropi, tutte le figure onde si serve la musica del pari che l’eloquenza a piacere, commovere, e persuadere; parlo de’ suoi dialoghi e delle sue riflessioni, e mi sforzo di svelare infinite sue bellezze parando innanzi l’analogia che hanno coi fenomeni che ci stanno intorno; paragono le nostre opere in musica con le tragedie antiche, e quinci ne traggo molte cose nuove accende a riordinare la forma de’ nostri drammi lirici, che di tutti i drammi sono certamente i più imperfetti, non essendo per lo più che una serie d’episodi staccati fra loro senza verun bisogno e senza veruna verosimiglianza. Esorto i poeti a sbandir da loro quel pregiudizio a cui ha dato origine la debolezza del maggior numero de musici, imperocché se la musica ha potuto accompagnare le tragedie d’, e di , può senza dubbio maneggiar ancora gli argomenti tragici, grandi, e regolari. E appunto io fo accorti i nostri compositori, come ciò verrebbe lor fatto, se essi s’avezzassero a cogliere per tal modo il carattere principale de’ poemi che ponessero mente alle parti senza trascurare il tutto, se affrettassero la declamazion delle scene fermandosi meno sull’arie, e soprattutto se rivolgessero la sinfonia al suo vero fine ch’è d’accompagnare di sostenere, e non di dominare pervertendo il senso delle parole202. Conchiudo alfine osservando i diversi stili de più celebri musici non meno della scuola francese, che dell’italiana.
[12] Ecco o Signore un leggiero abbozzo dell’opera ch’io ho meditata soggiornando in un angolo d’una provincia, nel solitario gabinetto e nel silenzio che accompagna la riflessione. Amico dell’oscurità, il cui soave riposo m’è sembrato mai sempre più caro che non il fasto pieno d’inquietezze, e di noiosi fastidi, io non cantai, al dir d’un antico, che per me, e per le muse. Del resto se da un canto lo zelo dell’avanzamento delle arti m’incoraggiava talvolta, il sentimento della mia debolezza, e la grandezza, e la difficoltà della impresa mi sbigottivano dall’altro. I pochi mezzi, ch’io avea per le mani mi faceano cader d’animo intieramente, né mi lasciavano altro conforto che quello d’abbandonarmi a delle querele inutili. E di fatti dolevami non poco che simil disegno non fosse stato conceputo da qualche uomo rispettabile per l’autorità sua nella repubblica delle lettere, o delle arti, e portava invidia alla pittura, per aver meritato che voi le consecraste le vostre fatiche e le cognizioni vostre. Ma posciacchè vi ho comunicato il mio progetto, e voi avete creduto bene d’ispirarmi coraggio, tutto il mio ardore s’è acceso di nuovo. Il vostro consenso ha dileguati gli ostacoli, che fin ora aveano rallentato il mio corso, e dacché posso nodrire la dolce speranza, che voi seconderete i miei sforzi, e m’aiuterete coi vostri lumi non v’ha cosa, ch’io non osassi d’imprendere. Sono col più profondo rispetto.
L’Ab. .
FINE
Osservazioni §
Intorno ad un estratto del tomo 2 della presente opera inserito nel Giornale Enciclopedico di Bologna N. XIII del mese d’aprile del corrente anno.
[1] Il Sig. , maestro di musica, uno de’ compilatori del Giornale Enciclopedico di Bologna, ha fatto varie opposizioni a due capitoli del secondo tomo della presente opera. Mi è sembrato che l’esaminarle potrebbe contribuire a maggiormente rischiarare alcune mie idee intorno alla musica, il teatro e le Lettere. Ecco il perché ho creduto bene di rispondergli. Avrei nello stesso modo risposto ad altri miei critici, se facendolo avessi potuto sperare che la fatica restasse compensata dall’utile.
GIORNALISTA.
[2] «Noi non intendiamo di criticar questo libro, prima perché il nostro istituto è di non criticare, ma cercar solo la verità; poi perché desso è realmente corredato di molta erudizione, di bei voli di fantasia, di paragoni adattati, di filosofia… insomma degno di essere letto.»
RISPOSTA.
[3] Bel panegirico proemiale, che sotto l’apparenza di encomio nasconde una positiva e reale intenzione di screditar l’opera!
«Così all’egro fanciul porgiamo aspersiDi soave licor gli orli del vaso».
[4] Ma io ho quella cognizione del cuore umano che basta per non ignorare che la malignità sa talvolta dispensar delle lodi. Il giornalista “non intende di criticar il mio libro”, ma il suo estratto non è che una critica continuata dal principio sino al fine. Il suo istituto è di “cercare la verità”, ma egli dissimula quasi sempre la verità delle mie ragioni, sopprime le pruove e travisa le mie opinioni per poterle poi presentare in quel lume che le renda men giuste. La mia opera è “realmente corredata di molta erudizione, di bei voli di fantasia, di paragoni adattati, e di filosofia”, ma venendo all’applicazione invece di quella filosofia e di quella erudizione altro in essa non ritrova l’estrattista fuorché “imperizia, declamazione, e contraddizioni”. Il mio libro è “degno di esser letto”, ma il giornalista fa tutto il possibile perché nessuno il legga criticandolo perpetuamente, non dando la menoma idea delle materie che vi si trattano, né della maniera con cui vengono trattate, non indicando veruna delle riflessioni ch’ho cercato di spargere utili al progresso della musica e alla perfezione del gusto, passando insomma sotto un silenzio ingiusto quel poco di nuovo e di passabile che per avventura vi possa essere, e che tanti altri accreditati scrittori d’Italia hanno avutala gentilezza di rilevare. È vero che , , , , gli autori della Biblioteca ragionata, e non facevano a questo modo gli estratti; ma già si sa che i giornalistici enciclopedici di Bologna non sono nè , né , né , né gli autori della Biblioteca ragionata, né , né .
GIORNALISTA.
[5] «Ma però con raziocinio, e non senza una buona dose di cognizioni musicali per poter discernere il vero dal falso in cui purtroppo, se rari sono gli autori che non v’incorrino, quanto più facilmente vi caderà quello che tratta di una cosa non sua».
RISPOSTA.
[6] Gli errori e le falsità che il giornalista saprà scoprire nel mio libro, e le risposte che da me gli verranno date, faranno vedere la giustezza o l’insussistenza di quest’asserzione.
GIORNALISTA.
[7] «Intendiamo dunque solamente di esporre i nostri dubbi sopra alcune opinioni sparse nel medesimo circa la musica e circa l’opera italtana, che non ci sono sembrate conformi all’idee giuste che dobbiamo avere dell’opera e dello stato presente dell’arte musica, ch’è trattata da molti, ma conosciuta da pochi.»
RISPOSTA.
[8] Prima d’esaminare se le mie opinioni fossero conformi all’idee giuste che dobbiamo avere della musica e dell’opera italiana, parmi che il vero metodo di filosofare avrebbe richiesto che il giornalista fissasse quest’“idee giuste” che circa gli oggetti in questione si debbono avere, e che poi riportasse le sue censure a quella norma inconcussa del vero musicale e poetico, intorno a cui fossimo convenuti. E ciò per non ismarrirsi in seguito nell’ambiguità e nell’incertezza di mille domande e risposte inconcludenti. Ma ho riflettuto dappoi che questo metodo obbligherebbe il povero galantuomo ad un peso, al quale si vede non essere avvezzo, cioè a quello di ragionare per principi, e che siccome sarebbe un’ingiustizia l’esiggere che tutti gli uomini dovessero avere la forza di Milone Crotoniata, o la bellezza di Nirea: così è una indiscretezza il pretendere che un maestro di musica che fa il giornalista deva avere in testa la dialettica d’un , o lo spirito geometrico d’un .
GIORNALISTA.
[9] «Pretende in primo luogo il Sig. che l’opera italiana sia ora in decadenza: di addurre i motivi di ciò, e di fare il parallelo della nostra musica con quella dei Greci. Ma dio buono! Come può mai paragonarsi una cosa evidente, qual è la nostra musica, con una che non si vede, qual è la musica greca, che ora esiste solamente nella testa orgogliosa degli eruditi, e che realmente non sappiamo cosa ella si fosse?»
RISPOSTA.
[10] La ragione con cui l’estrattista vorrebbe provare l’impossibilità del paragone fra le due musiche è affatto puerile. La Roma d’oggidì è “una cosa evidente”, la Roma dei tempi di Traiano non si “vede”, dunque non può paragonarsi Roma antica con la moderna? La legislazione degli Spartani non si vede più, quella de’ Viniziani è sotto gli occhi, dunque non potrà paragonarsi la politica di Licurgo con quella del governo veneto? Ciò sarebbe lo stesso che levare ogni sua influenza alla storia, ogni sua forza alle prove critiche e morali. Ma non sappiamo cosa fosse la musica greca. Ciò è vero fino a certo punto, non è vero assolutamente. Siamo all’oscuro intorno alla natura intrinseca dell’armonia, ma non lo siamo intorno al fine, intorno a più d’uno de’ mezzi ond’ella si prevaleva, e intorno agli effetti che venivano prodotti. Un’intero dialogo degno dell’autore che ancor ci rimane fra le opere di , molte notizie tratte da , da , da , da , da , da , e da , più d’un raggio di teorica e d’istorica luce, che tratto tratto risplende negli scrittori greci di musica tradotti dal e dal ci ponno servire di guida per inoltrarci quanto basta nella ricerca di questo ramo delle greche cognizioni. Quindi è che si può istituire fra le due musiche un parallelo ragionevolissimo. La nostra ignoranza circa le loro teorie musicali farà che non si possano comparare a priori, cioè esaminando i principi, sui quali è appoggiato l’uno e l’altro dei sistemi; ma non toglierà mai che si possano mettere in confronto a posteriori, cioè argomentando dagli effetti che produceva l’una, e che non sono stati mai generati dall’altra. Di fatti il paragone è stato più volte istituito da uomini niente meno eruditi e sensati, che ne’ suoi Dialoghi sulla musica antica, nei libri de praestantia musicae veteris, nel ragionamento de poematum cantu et viribus rytmi, Monsieur in più dissertazioni inserite nelle Memorie dell’Accademia di Parigi, Fra nella Dissertazione che chiude il terzo tomo della sua storia della Musica, l’Abate nella Dissertazione intorno agli accenti della lingua greca, e cent’altri.
GIORNALISTA,
[11] «Egli asserisce che la musica e la poesia presso i Greci erano oggetti di somma importanza, quando adesso si considerano al più come un occupazione dilettevole bensì, ma sempre inutile al bene degli stati. Egli è evidente però che nello stesso modo dei Greci consideriamo ancor noi la poesia e la musica; mentre ce ne serviamo com’essi nei templi, nei teatri, nelle case… e la stessa stima ch’ebbero i Greci dei drammi l’abbiamo anche noi.»
RISPOSTA.
[12] È cosa evidente per l’incomparabile estrattista che noi abbiamo della musica, della poesia, e delle rappresentazioni teatrali le stesse idee che avevano gli antichi. Una tale evidenza si trova però essere falsissima svolgendo anche leggermente le loro storie. Bisogna vivere in una profonda ignoranza dell’antichità per non sapere che la poesia, la musica e gli spettacoli furono per molti secoli considerati dai Greci e dai Latini come oggetti di politica e di religione. Sarebbe opera troppo lunga il trattenersi a render la ragione filosofica di questa generale e incontrastabile usanza, intorno alla quale non poche cose abbiam dette nel penultimo capitolo dei secondo tomo dell’opera presente. E quantunque il giornalista non abbia addotta non che confutata neppur una sola di esse, nulladimeno sarà bene il confermarle qui con nuovi fatti e con nuove testimonianze degli antichi scrittori. Che i Greci, massimamente i primitivi, considerassero i loro musici e i loro poeti come rivestiti d’un carattere legislativo si vede da ciò che le loro prime leggi, le prime politiche istituzioni, furono tutte promulgate in versi accompagnati dalla musica. In verso dettò Orfeo le sue leggi a’ Traci, in verso parlò Anfione a’ Tebani, in verso scrisse le sue massime politiche ai Cretensi; così fecero ancora , , , , e cento altri. La poetessa veniva riguardata da que’ di Mitilene come una delle loro più celebri legislatrici non altrimenti che que’ della Beozia ammiravano come uno de’ primi loro sapienti. e erano tenuti in Isparta per uomini di stato rispettabilissimi e per cose sacre le lor composizioni poetiche. fu stimato dagli Imeresi, popoli della Magna Grecia, come il Franklin e il Wasington della loro patria. Il lettore non ha bisogno d’essere avvertito che parlandosi di que’ secoli quanto si dice della poesia intendersi dee anche della musica, imperocché l’una era inseparabile dall’altra.
[13] Non è meno incontrastabile che l’anzidette
facoltà fossero il primo veicolo e lo strumento principale della religione. nel suo dialogo sulla musica ci
assicura che la prima «applicazione che nella Grecia si
fece della musica fu alle cerimonie religiose in onore degli dei»
. Gli oracoli
si rendevano in musica, cioè cantando in versi la profezia. I numi stessi erano creduti
musici e ballerini, e niente v’era di più comune quanto il vedere le loro imagini o
sculte o dipinte con in mano qualche strumento musicale, di cui veniva ad essi
attribuita l’invenzione. Mercurio avea una
specie di lira consistente in un guscio di testuggine con quattro corde. Apolline portava la cetra con sette corde. Ad Iside veniva consecrato il sistro, e la sampogna a
Pane. Anche Giove il padre degli dei si vedeva in qualche tempio d’Atene colla lira in
mano. Quindi è che gli antichi poeti e musici meritarono il nome di “divini”, e talmente
gli chiama :
«Sic honor, et nomen divinis vatibus, atqueCarminibus venit…».
[14] , il
quale era più vicino a que’ secoli remoti, gli dà il titolo di “santi” secondo la
testimonianza di nell’Aringa in
difesa d’Archia, «quare suo jure noster ille sanctos appellat poetas»
. E lo stesso è di parere che siffatta appellazione data a’ poeti
fosse comune a tutte l’età e a tutti i popoli, «ex eo hominum numero, qui semper
apud omnes sancti sunt habiti atque dicti»
.
[15] Quanto s’è detto della poesia e della musica si
debbe interamente applicare agli spettacoli del circo, e dell’amfiteatro; luoghi quasi,
direi, consecrati all’idolatria, cioè alla religione dominante del paese. Erano essi
dedicati quale a Nettuno, quale a Diana, quale a Marte, e quale a Saturno, e
dappertutto vi si vedeano scolpiti i simboli propri delle mentovate divinità, e prima
d’incominciar lo spettacolo si portavano attorno in processione i loro simolacri, o gli
emblemi che gli rappresentavano. Per ciò che spetta alle rappresentazioni teatrali il
fatto è fuor d’ogni dubbio, o si riguardi la loro origine, o si ponga mente all’autorità
de’ più illustri scrittori. , grammatico,
riferisce il principio della tragedia alle cose divine, alle quali applicavansi gli
antichi ringraziando gli dei dopo la raccolta dei frutti. afferma che fossero inventati da un re di
Macedonia in onore delle Muse e di Giove. La comune
opinione vuole che fossero i drammi trovati in occasione di solennizzar le feste di
Bacco; quindi a Bacco erano particolarmente dedicati, e «artefici di Bacco»
si chiamavano nella Grecia i poeti tragici e gli attori. Dagli
antichi scoliasti si ricava che dentro del teatro, e sulle scene, e nell’ingresso
s’innalzavano delle statue in onore dei numi. La medesima usanza si raccoglie da un
luogo di nell’Amfitrione, e da
un altro di nell’Andria. La
prima introduzione degli spettacoli scenici in Roma fa vedere che
anche in Italia erano allora considerati come riti, e cerimonie
religiose. I Romani per liberarsi da una pestilenza non seppero trovare altro espediente
onde placare lo sdegno degli dei, che quello di chiamare dalla Toscana gli istrioni che
introducessero le rappresentazioni, come da noi in simile circostanza si farebbe un
pubblico voto di digiunare per l’avvenire un giorno dell’anno; laonde non è da
meravigliarsi che i più sensati autori ne facessero un così gran conto delle arti
drammatiche. chiama le favole sceniche un
dono che gli dei aveano fatto al genere umano compassionando le sue miserie. , come da noi altrove si asserì, dice che le
rappresentazioni tragiche contendono co’ trofei, e che e sono paragonabili
co’ più gran capitani.
[16] Ma nulla fa capir meglio lo spirito delle antiche
rappresentazioni quanto lo zelo de’ primi padri della chiesa nel riprenderle e
condannarle. Erano essi così persuasi che fossero una specie di rito religioso che per
loro l’assistere a’ teatri era lo stesso che confessarsi tacitamente idolatra. Di molti
passi che potrebbono addursi in conferma, basterà riportarne due, che sono decisivi. Il
primo è di
nell’Apologetico: «in tanto rifiutiamo, dice
parlando co’ gentili, i vostri spettacoli, in quanto abbiamo in odio l’origine
loro che sappiamo venire dalla superstizione»
. Il secondo è di nel libro sesto delle
istituzioni: «La celebrazione degli spettacoli sono feste de’
numi, e si fanno per sollenizzare il loro giorno natalizio o per dedicarne un qualche
tempio, e chiunque (soggiugne dopo) assiste a spettacolo,
dove si concorre per causa di religione, rinuncia al culto del vero Iddio per passar a
quello de’ falsi numi.»
Tale appunto è il linguaggio di , di , di , e d’.
[17] Ci dica ora il degnissimo membro
dell’Areopago enciclopedico di Bologna se sia cosa “evidente”
che noi consideriamo nel modo stesso che i Greci la poesia, la musica e gli spettacoli?
Facciamo noi forse la santissima trinità poetessa e suonatrice? Dipingiamo il Padre
Eterno col flauto in bocca, o col violino in mano? Crediamo che la Madonna fosse
ballerina? Si legge ne’ nostri libri canonici che gli apostoli promulgassero la legge
del Vangelo per mezzo di un’ode saffica, e ballando una qualche contraddanza? Diciamo
“San , San , San , San , San ,
San ”? Si vede esposta l’imagine di
Gesù crocifisso sulle scene, o ne’ palchetti
de’ nostri teatri? Vi si veggono le statue di San Francesco
di Paola, di Santa Caterina, o di
qualch’altro santo della nostra religione? Si fa voto di metter sulle scene un opera in
musica in occasione di tremuoto, di carestia, di peste, od altra calamità publica? Ci
avvisiamo di dover placare lo sdegno divino coi trilli di Marchesi o colle capriole dell’Angiolini? Se qualche calvinista interviene ad un’opera, crediamo perciò
ch’egli abbia rinunziato alla setta di Calvino
per abbracciare la religione romana? Se dunque nulla facciamo di ciò, anzi se il solo
scrivere e proporre tai cose ci sembra stravaganza e ridicolaggine, con quale fondamento
l’impareggiabile Signor decide che su
tutti i mentovati oggetti pensiamo come gli antichi? «Ma, replica egli con fortissima argomentazione, noi ce ne serviamo, com’essi nei
templi, nei teatri, e nelle case ecc.»
E che perciò? In tutti que’ luoghi ce
ne serviamo soltanto come di cose indifferenti e semplici passatempi, e siamo ben
lontani dal riguardare come oggetti di somma importanza o come un affare di stato la
musica fatta, per esempio, dal
sull’Alceste del , o le
sinfonie per accademia o per camera composte dall’. È vero che abbiamo un genere di armonia destinato al culto divino,
ma da questo solo ramo che comprende una picciolissima porzione di musica, e che non
caratterizza per niente l’indole e il gusto della musica nazionale, vorrà forse il
giornalista trarne un confronto con quella de’ Greci, la quale e nella sua istituzione,
e ne’ suoi progressi, e in pressoché tutte le sue applicazioni alla poesia, e alla danza
aveva uno scopo religioso, morale e politico? Ciò sarebbe lo stesso che se dall’avere il
parlamento d’Inghilterra citato talvolta in giudizio il proprio
re come facevano sovente gli efori in Isparta, altri argomentasse che la costituzione
anglicana fosse perfettamente simile a quella di Licurgo.
GIORNALISTA.
[18] «Se allora essi servivano per dilettare e istruire, senza parlare dei più antichi, quelli dello , e del non sono ornati di ottime massime religiose, morali e politiche?»
RISPOSTA.
[19] Ottime massime religiose e morali si leggono nel Don Quisciotte, nel Telemaco, nell’, nella novella Eloisa, nella Clarice del , e in molti altri romanzi; ma si dirà per questo che i mentovati libri vengono considerati da noi come cose sacre, o come oggetti di somma importanza civile? Lo stesso dicasi delle rappresentazioni sceniche. I drammi degli antichi avevano per oggetto il dilettare e l’istruire: ma l’istruzione procurata dal governo e diretta dalle leggi aveva uno scopo religioso, politico, e legislativo, del che si vedevano in pratica gli effetti; presso a noi l’istruzione lasciata in balia del poeta è sempre subordinata al semplice, e mero divertimento. A provar ciò vuolsi poca serietà e poca dottrina. Il Signor , che ha dimorato lungo tempo in Moscovia, e che vi sarà forse andato col disegno d’incivilire que’ popoli al suono degli strumenti come faceva Orfeo, o d’ispirare i principi della religione agli idolatri Samoiedi con un rondò, come facevan e , conserverà tuttora lo spirito di missionario e di legislatore, e quando va all’opera v’andrà probabilmente per assistere “agli esercizi spirituali”, per soddisfare alla penitenza impostagli dal confessore, o per accendersi di amor di dio coi salmi penitenziali posti in bocca d’Aristea, o di Cleonice. Quanto a noi meno costumati e purtroppo meno divoti v’andiamo per conversare, per giuocare, per far delle cenette, per passare il tempo, per ridere, per divertirci coi vezzosi gorgheggi della Maccarini, o coi bei recitativi del Pacchierotti, e pensiamo tanto “all’ottime massime religiose morali, e politiche” contenute nel libretto quanto gli indiani, allorché prendono il betel, o l’opio pensano ai dogmi del dio Brama, o ai precetti del legislatore Xenchia.
GIORNALISTA.
[20] «Se poi talvolta sono malamente eseguiti dai guastamestieri (che abbondano in ogni professione) non potendo il poeta e il compositore di musica eseguirli da loro stessi, non seguì il medesimo dei drammi greci quando migliorarono, cioè quando furono scritti a più personaggi? Mentre né , né furono certamente multiformi da poterne rappresentar tutte le parti.»
RISPOSTA.
[21] Sviluppiamo questo garbuglio d’idee, dal quale
come dall’uovo di Leda verranno fuori delle
cose pellegrine. Secondo l’estrattista se i nostri drammi sono talvolta malamente
eseguiti dai “guastamestieri” gli è perché il poeta e il compositore di musica non
possono eseguirli da loro stessi. Dunque (prima conseguenza) non essendo in
Italia il costume che il poeta e il maestro eseguiscano da loro
stessi i drammi, tutti saranno malamente eseguiti. Dunque (seconda conseguenza) essendo
tutti mal eseguiti, non avrebbe torto chiunque vituperasse l’opera italiana. Dunque
(terza conseguenza) non essendo né Marchesi, né
Pacchierotti, né la Deamicis, né Davide poeti o compositori di musica, i drammi eseguiti da loro saranno
malamente eseguiti, ed eglino dovranno considerarsi come altrettanti guastamestieri.
Dunque (quarta conseguenza) se i drammi fossero rappresentati dal poeta e dal maestro
che li mette in musica, allora sarebbero ben eseguiti. Ecco i meravigliosi corollari che
derivano dalla proposizione del giornalista. Di tutte l’illazioni surriferite, quella
che più mi rincresce è l’ultima. Non posso far a meno di non isdegnarmi contro il
costume che vieta ai maestri di musica di salir sulle scene a cantar i propri drammi. Oh
che bello spettacolo sarebbe allora quello di vedere il a farla da eunuco sul teatro di Venezia,
e su quello di Bologna! Ma andiamo innanzi. «Non seguì il
medesimo de’ drammi greci, quando migliorarono, cioè quando furono scritti a più
personaggi? Mentre né , né furono certamente multiformi da poterne
rappresentar tutte le parti»
? Un’altra serie di conseguenze non meno stupende.
Dunque quando “migliorarono” i drammi greci furono malamente eseguiti dai
“guastamestieri”. Dunque quando “peggioravano” furono eseguiti bene, perché
rappresentati dal maestro di musica, e dal poeta. E quando “migliorarono”? Quando furono
“scritti a più personaggi”. E quando ciò accadde sul teatro greco? Quando “né , né erano
multiformi da poterne rappresentare tutte le parti”. Così i drammi greci erano migliori
quando erano peggio rappresentati, erano migliori quando furono scritti a più
personaggi, e furono scritti a più personaggi ai tempi di , e di . Il
Calandrino del
comecché fornito di logica così prelibata potrebbe infilar meglio un ragionamento? Ma
pazienza se l’estrattista manca di logica, poiché si sa che questa non si può avere che
dalla madre natura; il peggio si è che manca nella storia, per la quale basta aver degli
occhi, e volontà di leggere. È falso che i drammi greci fossero malamente eseguiti
quando “migliorarono”; anzi tutta l’antichità ci assicura che i grandi attori della
Grecia fiorirono successivamente dai tempi d’ fino ai tempi di e di . È poi
falsissimo che i drammi greci cominciassero a scriversi con più personaggi da e da .
Molto tempo prima che scrivessero i due mentovati poeti s’introducevano più
interlocutori nella tragedia e nella comedia. , poeta tragico anteriore a
, usò dei cori nelle sue tragedie e i cori
certamente non erano composti da un sol personaggio. egli stesso introdusse parimenti i cori ne’ suoi drammi. , discepolo di , fu il primo a introdurre in teatro maschere da donna,
«muliebram personam introduxit in scenam»
, dice . I peani, al dire di nel
libro nono, erano rappresentazioni antichissime, dove s’introducevano più interlocutori.
Nelle tragedie di si trova una folla di
personaggi che parlano diversi da quelli del coro. Nelle sue Eumenidi,
oltre il coro delle furie sono Pizia, Apollo, Minerva, Oreste, e l’ombra di
Clitennestra. Nel Prometeo,
senza nominar le Ninfe Oceanitidi, che formano
il coro, declamano Prometeo, Vulcano, Oceano, Jo, Mercurio, la Forza, e la Violenza; nelle
Persiane agiscono Atessa,
Serse, l’ombra di Dario, ed un corriere, lo stesso si dica delle Supplicanti
e degli altri componimenti di quel poeta. , il
quale venne dopo di lui, le diè l’ultima forma ordinando il primo la dipintura del
palco, aggiungendo un personaggio di più al diverbio, e tre altre persone al coro
composto fin allora di dodici sole: onde s’avverò ne’ suoi componimenti il detto
d’ nella Poetica
«che dopo assai mutazioni che sopportò la tragedia si riposò infine ottenuto
ch’ella ebbe il suo intento»
. Che ne dice dopo tutto ciò il baldanzoso ed
erudito Minosse degli altrui libri?
GIORNALISTA.
[22] «Una cagion forte della decadenza della nostra opera dipende secondo il Sig. Arteaga dalla separazione della filosofia, della legislazione, della poesia, e della musica, le quali facoltà ne’ primi tempi della Grecia possedeva tutto unite un solo autore. Ma oltreché le nostre opere, come abbiam detto di sopra, non sono prive di massime filosofiche e morali ecc., ma tale separazione doveva risultar naturalmente a misura che le dette facoltà s’ingrandivano e si miglioravano; e lo stesso successe ancora al tempo che la Grecia fu colta e sapiente. Onde non si può dire con buona ragione che la detta separazione abbia ad esse pregiudicato, poiché sono libere ed esistono da se stesse; e sebbene unite abbiano più forza, ne hanno anche molta essendo separate, come lo dimostrano le belle opere che esistono di filosofia di legislazione, di poesia, e di musica strumentale ch’è la vera essenza della musica; mentre il diletto che reca la musica vocale può derivare ancora dalle parole, se non in tutto almeno in parte; ma quando una musica strumentale giunge a toccare, bisogna dire che tutto il merito è della sola musica; sebbene però questa non può commovere se non dipinge o esprime qualche cosa; onde ancor da sé sola è un linguaggio e una specie di pittura, e di poesia.»
RISPOSTA.
[23] Essendo fra noi da gran tempo separate la filosofia, la legislazione, la poesia, e la musica, la loro individuale influenza ha dovuto esser minore perché divisa. Ha dovuto altresì esser minore, perché spesse volte contraria distruggendo l’una l’azione direttrice dell’altra. Niente di più comune fra noi che il veder i governi prescriver delle leggi opposte a quanto detterebbe la sana filosofia, che sentir i filosofi insegnar massime e principi disapprovati dal governo, che l’udir poesie lontane da ogni oggetto morale, politico, e legislativo, che ascoltar infine delle musiche effeminate e frivole, che non hanno il menomo rapporto colle altre compagne. Perciò è un paradosso che fa vedere una profonda ignoranza d’ogni filosofia l’asserire che la separazione d’esse facoltà non abbia ad esse pregiudicato, come un paradosso sarebbe in meccanica il dire che la velocità d’un corpo è la stessa quando le forze che lo spingono sono divergenti, o contrarie, che quando l’azione loro è verso d’un solo punto diretta. Che la separazione dovesse risultar naturalmente a misura che le dette facoltà s’aggrandivano, ciò è verissimo, ed io l’ho detto prima dell’estrattista; ma da questa separazione appunto e dal loro ingrandimento successivo traggono i filosofi la cagione del perché nella Grecia le arti poetiche e le musicali acquistassero nuove ricchezze e perdessero la loro antica energia. Leggete, o mio caro giornalista, l’aureo trattato del sull’unione della musica e della poesia, e imparerete molte cose che ignorate.
GIORNALISTA.
[24] «Due altre cagioni della decadenza della nostra musica il Sig. le rileva da due de’ suoi più bei pregi, cioè dalla sua ricchezza e dal contrappunto. Ma chi può con certezza asserire che anche i Greci non conoscessero una specie di contrappunto, e che nei tempi più floridi della Grecia non vi fosse una musica ricca al par della nostra? Se v’era, essa sarà stata probabilmente simile alla presente, e se non v’era, sarà stata inferiore; perché il diventar più ricca specialmente in materia dì scienza, non crediamo che sia un demerito.»
RISPOSTA.
[25] Il giornalista movendo in aria di confutazione un
dubbio, se i Greci conoscessero o no il contrappunto, pare che voglia dare a credere
ch’io sono per la negativa. Quest’è una mancanza d’esattezza e di buona fede. Io non mi
sono deciso né per l’una, né per l’altra opinione. Alla pagina 184 del secondo tomo ho
detto «noi abbiamo un contrappunto del quale si dice che gli antichi non avessero
alcuna notizia»
. Alla pagina 240 scrissi le seguenti parole parlando del
comporre a’ più parti: «Senza decidere se cotesta invenzione sia propria de’
secoli moderni, e del tutto sconosciuta agli antichi (questione odiosa intorno alla
quale non potremmo assicurarci giammai nonostante i molti e celebri tutori che l’hanno
trattata).»
Ora un “si dice” in un luogo, ed un dubbio così decisivo in
un’altro fanno chiaramente vedere ch’io sono ben lontano dal voler pigliare partito in
così fatta questione.
[26] La ricchezza parlando delle arti d’imitazione e di sentimento può renderle più dotte, più variate, più estese, ma non è una conseguenza che debba renderle più patetiche e più commoventi. Nel luogo citato dal giornalista ho provato a lungo siffatta proposizione, ho fatta l’applicazione alla musica, ho esaminata la forza de’ suoni considerata nel loro carattere fisico e morale, l’ho confermato scorrendo la storia della musica, e coll’esempio della cinese, dell’araba, e delle nostre antiche cantilene di chiesa, ho speso in tali ricerche sedici pagine, cioè dalla 184 fino alla 201 del secondo tomo, delle quali l’estrattista non fa neppure un sol cenno. Le rilegga egli adunque, rechi in mezzo le mie ragioni, le esamini, e non usi la poca onestà di far credere a’ lettori ch’io avventuro delle cose senza provarle.
GIORNALISTA.
[27] «E il contrappunto non solo non ha pregiudicato alla musica, ma anzi, avendo fatto conoscere qual sia la buona armonia e buona modulazione, è stato quello che ha contribuito più di tutto all’avanzamento di essa. Ma qual è quella cosa ottima che non degeneri, se se ne abusa? Così segue del contrappunto, l’uso moderato del quale non può esser che buono; ma abusandone, cioè volendo comporre a troppe parti unite, e per conseguenza a troppe varie cantilene eseguite tutte in un tempo, come segue nel contrappunto, cori diversi, e nelle fughe in quelle specialmente a più soggetti, non può nascer altro sicuramente che un gran danno alla buona melodia ch’è quella accompagnata con poca e discreta armonia ossia poco contrappunto.»
RISPOSTA.
[28] Un’altra prova demostrativa della inesattezza o
della mala fede del giornalista. A sentir lui pare ch’io abbia condannato in genere e
assolutamente il contrappunto come cattivo, non già in ispezie, e riferendolo alla sola
musica drammatica. Eppure è tutto all’opposto. In più luoghi delle mie
Rivoluzioni ho fatto espressamente questa distinzione. Lungo sarebbe il
rapportarli qui tutti di nuovo, basterà soltanto ridire ciò che ho detto nel capitolo
stesso citato dal , acciocché si veda
quanto deve fidarsi il lettore di certa classe d’estratti od’estrattisti. Si rilegga la
pagina 240 del secondo tomo, e si troveranno parlando del contrappunto le seguenti
parole: «egli è chiaro, che la sua utilità almeno per la musica teatrale è tanto
problematica, che poco o niun motivo abbiamo d’insuperbircene»
. Alla pag. 244,
ragionando della nostra armonia e del contrasto delle parti, io dissi: «Non si
niega che da siffatto contralto non possa per opera d’un valente compositore
cagionarsi talvolta una combinazione di suoni che diletti l’udito per la sua vaghezza
ed artificio, e tale è appunto il merito intrinseco della moderna musica dove l’arte
et intrecciare le modulazioni, la bellezza delle transizioni e dei passaggi,
l’artificiose circolazioni intorno al medesimo tuono, la maestria nello sviluppare e
condurre i motivi, in una parola le bellezze estetiche dell’armonia sono pervenute ad
un grado di eccellenza sconosciuto affatto agli antichi.»
Ecco un elogio della
nostra armonia maggiore assai di quanti ne possa fare l’estrattista. È dunque falsissimo
ch’io abbia mai asserito aver il contrappunto pregiudicato alla musica in generale; ho
detto bensì che pregiudicava alla musica drammatica, e anche qui con distinzione,
perocché parlando del contrappunto ch’era in voga in Italia verso
il fine del Cinquecento lo condannai come contrario alla musica scenica, nel che altro
non feci che tener dietro alle pedate di , di , di e di , le parole dei quali addussi in vari luoghi della mia opera. Ma fui
ben lontano dal condannar l’armonia moderata, come si vede dagli elogi che fo in cento
luoghi, e del giusto tributo di laude che rendo ove parlo del secol d’oro della musica
italiana, a coloro che la ripurgarono dal fiammingo squallore. Soggiunsi che l’artifizio
del contrappunto non è atto ad eccitar le passioni, e provai alla distesa la mia
asserzione internandomi nell’essenza dell’armonia, e
facendo vedere che la moltiplicità delle parti, la natura degli intervalli e
l’intrinseca repugnanza che regna nel nostro sistema armonico, (ripugnanza nata dal
comprender insieme più spezie contrarie di movimento) non la rendono acconcia a produrre
una determinata e individuale passione203. L’estrattista osserva un’alto e
perfetto silenzio intorno alle distinzioni fatte da me, ommctte tutte le autorità
allegate, passa di lungo senza nemmeno accennar una sola delle mie ragioni, e poi si fa
avanti in aria trionfale, come farebbe Alessandro
dopo la conquista di Tiro. Oh! Sì che questa è una bella maniera
di far gli estratti
GIORNALISTA.
[29] «Pretendere ancora come fa il N. A. che altre cagioni più forti dimostrino la disuguaglianza delle due musiche, cioè i prodigi che faceva l’antica de’ quali è scarsa la nostra: la considerazione in cui l’aveano i Greci, che l’impiegavano nei loro maggiori bisogni ecc. quest’è un discorrere in aria.»
RISPOSTA.
[30] Un “discorrere in aria” chiama il giornalista ciò
che si dice della possanza della musica greca e della somma stima in cui era presso agli
antichi? Sarà dunque un “discorrere in aria” l’appigliarsi all’autorità de’ più distinti
poeti, degli storici più celebrati, de’ più sensati filosofi e de’ più illuminati
critici, che tutti concordemente ne assicuran di ciò. E quando , non contento di render musicali la terra, l’anima, e gli
elementi, sollevò fino al cielo l’armonia volendo ch’ella fosse il principio regolatore
del movimento dalle sfere; quando fa dipender
da essa non solo l’allegrezza, il dolore, l’iracondia colle altre passioni, ma le virtù
eziandio e i vizi e la sapienza degli uomini; quando ci assicura che gli Arcadi deponessero la loro ferocia costretti
dalla soavità dell’armonia, e che a questa fossero debitori di più temperati e più
religiosi costumi; quando ci insegna aver
gli dei donata ai mortali la musica non pel vano ed inutil diletto dell’orecchio, ma
sibbene acciochè s’occupassero ad affrenare gli sregolati movimenti che destan
nell’animo le troppo lussureggianti imagini delle terrestri Muse sotto il qual nome
compresa viene ogni sorta di sregolata cupidigia; quando , poeta greco, al cominciar il suo poema sulla musica scaccia
«lungi da sé i profani»
protestandosi di dover parlare d’un’arte
affatto divina; quando ne inculca la
necessità della musica per l’educazione, e rammenta i prodigiosi effetti operati da essa
su alcuni popoli della Grecia; quando impiega un’intiero capitolo della sua opera immortale dello
spirito delle leggi nel verificare i fatti che si rapportano, e nel
rintracciarne le cagioni; quando il dottissimo
ci fa toccare con mano la grande e generale possanza che acquistò l’armonica facoltà
sulle menti e sulle azioni degli antichi Greci; quando , il più accreditato scrittore ch’esista della storia musicale,
conferma il fin qui detto con una serie prodigiosa di fatti e d’antiche testimonianze:
sarà un “discorrere in aria” l’argomentare dall’autorità riunita di tanti e così bravi
scrittori, che gli Antichi avessero della musica un’idea superiore di molto a quella che
noi ci formiamo di essa, e che avvezzi fossero a veder operati dalla melodia degli
effetti sconosciuti ai moderni? E con quali ragioni s’oppone il giornalista ad una
opinione così verificata e così generalmente stabilita? Quali autorità opposte reca egli
in mezzo per distruggerla? Con qual logica con qual erudizione ci pruova che tutto ciò
altro non sia che un “discorrere in aria”? È inutile il dimandarglielo poiché altro non
apporta che la sua sola e semplice asserzione. Ma oh mio Signor dolcissimo! Voi non siete , ned io sono pitagoreo per ammettere come testo canonico il
vostro ipse dixito.
GIORNALISTA.
[31] «O son favolosi o alterati tali prodigi.»
RISPOSTA.
[32] Tai prodigi sono certamente favolosi, se per prodigi intendete il far camminare i boschi e le montagne come faceva Orfeo, il guarire il popolo tebano dalla sciatica al suono del flauto, come si narra di Meria, l’inalzar al suono della lira le muraglie di Tebe come dicesi d’Anfione, o il farsi ubbidire dai delfini, come si racconta da Arione. Ma non sono né favolosi, né alterati, se per prodigi s’intendano i meravigliosi effetti morali prodotti dalla musica sugli animi dei Greci sulla loro educazione, sulla loro politica, sui loro costumi, e il dubitare di questi se non paratamente, almeno in grosso, e quanto basta per attribuire alla loro musica una sorprendente energia, è lo stesso che spingere il pirronismo storico al grado cui lo spinse lo stravagante e pazzo .
GIORNALISTA.
[33] «O bisogna credere che non sarà stata la sola musica che gli avrà operati, ma ancora la poesia, che dessa accompagnava, dalla quale un tone nasce certamente maggior diletto e maggior forza.»
RISPOSTA.
[34] Vè che uomo avveduto è egli mai codesto maestro di cembalo dell’Imperator delle Russie. E la nostra musica non s’accompagna altresì colla poesia? Che vuol dire adunque che un siffatto accoppiamento non opera presso di noi il menomo di quei prodigiosi effetti che operava presso gli antichi Greci? La diversità dell’effetto non indica in buona logica la diversità delle cause.
GIORNALISTA.
[35] «Ma perché incolpare la musica, che adesso non operi tanto, se i miracoli gli ha già fatti, cioè, se ha già umanizzata gran parte di mondo.»
RISPOSTA.
[36] Oh il meraviglioso e singolar ritrovato! Non più i principi d’una morale dolce e sublime qual è quella insegnataci dalla religione cristiana, non l’abolimento dell’anarchia feodale, non lo stabilimento di governi più regolari, non la saviezza e la forza delle leggi che imbrigliarono l’impetuosità dell’interesse personale, non la comunicazione fra tutte le parti del globo procurata per mezzo della navigazione, non lo scambievole commercio fra il vecchio e il nuovo continente, non le ricchezze e il lusso che indi ne derivarono, non lo spirito di società il quale avvicinando l’uno all’altro i due sessi ne tempera la ferocia e ne ringentilisce lo spirito, non più il progresso della filosofia e dei lumi sono a’ nostri tempi le cagioni che hanno “umanizzata gran parte del mondo”, ma la musica fu la meravigliosa operatrice di cosìffatti prodigi. s’è affaticato invano ricercando le cause dell’attuale incivilimento d’Europa. Se quel francese avesse posseduti i talenti superiori del nostro enciclopedico baccalare le avrebbe tosto ritrovate nel Micrologo di , o nel Dodecachordon d’. Il re di Spagna dovrà essergli sommamente obbligato di questa scoperta. Se quel sovrano vorrà sottomettere alle leggi del vivere onesto e civile i Pampas, gli Apaches, i Tegas, i Siba-Papi, i Moxos, i Chiquitos ed altri popoli selvaggi dell’America non ha da far altro che spedire nel nuovo continente il maestro che insegni loro quattro leggi di contrappunto al giorno accompagnate da qualche lezioncella di salterio, ed eccoti “umanizzata” quella parte del globo.
GIORNALISTA.
[37] «E se anche adesso l’uomo di cuore più duro e indifferente purché abbia l’orecchio disposto alle impressioni della melodia, non può resistere al di lei incanto quand’è veramente della più perfetta, e perfettamente eseguita?»
RISPOSTA.
[38] E appunto perché di questa musica veramente la più perfetta, e perfettamente eseguita v’ha pochissimo fra i moderni, noi restiamo indifferenti all’azione di essa.
GIORNALISTA.
[39] «La musica cangiò al tempo dei Greci, ed ha cangiato al tempo nostro. Nella Grecia fu bambina, a poco a poco crebbe, divenne adulta e per conseguenza migliore, e lo stesso ha fatto in Italia. I Greci ebbero ancor essi i loro “guastamestieri” corruttori del buon gusto ecc,… e lo stesso è seguito e segue ancora fra noi; ma da tutto questo si deve forse arguire che non esiste più una buona musica, o si deve piuttosto confessare per nostra confusione che finché durerà il mondo vi sarà sempre il male accanto al bene, e vi saranno sempre autori mediocri e cattivi in tutte le arti e in tutte le sciente accanto a’ buoni? Sì, bisogna confessarlo, e ciò che è ancor più fatale ma che non è men vero, si è che non sempre gli stessi bravi autori hanno fatte opere perfette.»
RISPOSTA.
[40] Che la musica cangiasse al tempo dei Greci, come ha fatto nel nostro; che presso loro fosse prima bambina; che indi a poco a poco crescesse, e poi divenisse adulta al paro dell’italiana; che i Greci avessero i loro guastamestieri come abbiamo noi; ciò ha tanto che fare colla questione come i porri colla luna. Queste somiglianze estrinseche e generalissime possono stare, e ci stanno benissimo con una intrinseca e reale diversità di fini, di sistema, e di mezzi. L’arguire da tutto ciò che più non esiste una buona musica, è una conseguenza arbitraria, che cava l’estrattista, ma che a me non è venuta in mente nemmeno per sogno. La nostra musica è buona buonissima se si riguarda in essa la varietà, l’artifizio, la dottrina, il brio, la squisitezza, e il raffinamento. Il suo estetico è più copioso e più ampliato di quello dell’antica. Ma tutto ciò è assai diverso dal patetico nel quale, come ancora nello scopo morale e politico, la musica greca, e per mio avviso e per quello di molti uomini assai più dotti di me, superava altrettanto la moderna, quanto questa supera l’antica in altre doti pregievoli. L’ignorare queste cose note, come suol dirsi lippis et tonsoribus, sarebbe di poco decoro per qualunque erudito ma è un vitupero e un’obbrobrio per un maestro di musica, scrittore di professione, il quale dà con ciò a divedere essergli affatto sconosciuti i fondamenti filosofici dell’arte propria.
GIORNALISTA.
[41] «Il medesimo Sig. , unendosi alle opinioni del Sig. inglese (Dell’origine e progressi della poesia, e della musica) e del Sig. (Essai sur l’origine des langues), conviene con essi che noi siamo realmente all’oscuro sulla vera natura dell’armonia de’ Greci, sui loro generi, modi, strumenti ecc. quindi gli sembra strano che si voglia pospor la loro musica alla nostra; ma per le stesse ragioni non è ancor più strano il volerla antiporre?»
RISPOSTA.
[42] In primo luogo è falsissimo ch’io abbia antiposta la musica greca alla moderna senza restrizione. Replicherò per la decima volta che l’ho antiposta nella semplicità, nell’espressione, e nell’oggetto morale, come l’ho posposta all’italiana nell’artifizio, nella ricchezza, e nel raffinamento. In secondo luogo è anche falsissimo che non si possa instituire un paragon ragionevole fra le due musiche, quantunque non ci sia del tutto nota l’indole dell’armonia de’ Greci. Ho risposto su tal proposito nel principio dell’estratto.
GIORNALISTA.
[43] «Pensa ancora il Sig. che la nostra musica non possa accoppiarsi ad ogni genere di poesia p. e. al Sonetto, alla Canzone petrarchesca, alla pindarica, all’anacreontica ecc. ecc., ma altro è che tali poesie noi non usiamo di porle in musica alla maniera delle arie che sono più proprie a tale assunto; e altro è che la nostra musica non abbia modi da esprimerle: mentre desse si possono cantare benissimo, (e tutto ciò che si canta, anche da una sola voce, è sempre musica) e si possono ancora rivestir con note alla maniera delle arie; poiché, se si fa tal musica a della poesia quasi prosaica e barbara come sono certe composizioni latine ecc, tanto più si deve poterla fare a delle composizioni veramente melodiche, come sono le suddette cannoni pindariche ecc.»
RISPOSTA.
[44] Quest’accusa è una delle infinite inesattezze del
fogliettista. Nel luogo da lui citato204 io non ho mai detto che la nostra
musica non possa accoppiarsi ad ogni genere di poesia; ho detto soltanto «che per
una generale inavvedutezza noi abbiamo esclusi dal genere musicale quasi tutte le
moltiplici specie della poesia»
. Ora queste espressioni non indicano
un’intrinseca impossibilità nella nostra musica d’accoppiarsi coi suddetti generi, come
vorrebbe farmi dire il sempre degno estrattista, ma un’inveterato costume ne’
compositori di non mai eseguirlo. Tutto il paragrafo non è altro che un’illustrazione,
un comento dell’accennato pensiero, anzi tanto è lontano della verità ch’io voglia
negare alla nostra musica la capacità d’accompagnarsi coi detti generi poetici che in
più luoghi delle mie Rivoluzioni ho parlato de’ sonetti del posti in musica dal e dal , del famoso
canto del dove parla del conte Ugolino modulato da , dei Pietosi affetti di Don vestiti armonicamente dal , dell’Oronta del poema in ottava rima cui fecero la musica i più bravi compositori
romani, e di cent’altre sorti di poesie. Non può negarsi che il Signor non legga con attenzione l’opere che vuol onorare
della sua critica.
GIORNALISTA.
[45] «Passa quindi il N. A. ad asserire che noi ignoriamo la quantità sillabica nella poesia; che non sappiamo p. e. quale sia la sillaba più lunga della parola “spoglie”; che il maestro abbandona il valor della poesia per badare al valor delle note ecc. ma tutto questo è falso stante che il bravo compositore conosce benissimo la quantità e la qualità delle sillabe nella poesia sa che la parola “spoglie” è di due e non di tre sillabe, come ei la crede, e sa ancora adattar le note al valor della poesia.»
RISPOSTA.
[46] Tante proposizioni, altrettanti spropositi. In primo luogo il compositore non può conoscere né benissimo né malissimo la quantità delle sillabe nella nostra poesia, perché nessuno può conoscere ciò che non esiste. Fino i ragazzi che imparano i primi rudimenti della rettorica sanno che la nostra poesia non ha quantità sillabica, e che questa era propria soltanto dei versi greci e latini, e in generale dei versi appartenenti alla poesia chiamata metrica, i quali si regolavano col numero e varietà dei piedi, e colla lunghezza e brevità delle sillabe; all’opposto dei versi appartenenti alla poesia detta armonica come la nostra, i quali badano soltanto al numero delle sillabe e all’acutezza e gravità degli accenti. In secondo luogo è una scempiaggine il pretendere che il compositore conosca la quantità sillabica nella parola “spoglie”, perché sa che costa di due sillabe, e non di tre. Il sapere il numero non è lo stesso che sapere la quantità, perocché in grammatica e in filosofia sono due cose differentissime, e un giovinetto da scuola a cui scappasse di bocca un tale sproposito si meriterebbe le battiture del maestro. In terzo luogo, dove le sillabe non hanno un valore determinato di brevi o di lunghe il compositore non può adattare le note al valore della poesia, qualora il Sig. non voglia dare alla parola “valore” un significato diverso da quello che da tutti le vien dato in grammatica ed in rettorica. Nel qual caso noi lo consigliamo a premettere per l’avvenire ad ogni sua critica un picciolo dizionario che fissi la significazione arbitraria dei termini adoperati da lui, e ciò per risparmiare le quistioni di voce e per guadagnar tempo prezioso a tutti e in particolar modo a’ giornalisti che devono parlar d’ogni cosa.
GIORNALISTA.
[47] «Come non è men falso che, se sopra alla musica stessa si possono applicar varie parole, ciò dipende, perché il musico nella collocazione delle note non ha altro regolatore che il proprio arbitrio, poiché una tale operazione non può esser ben fatta, se non quando i versi sieno di una stessa misura, e il sentimento delle parole sia lo stesso: onde egli è sempre vero che non è la poesia che deve servir la musica, ma bensì questa che deve star soggetta in tutto alla poesia, e all’argomento della medesima: e in tal modo sono espresse le più belle composizioni che ora abbiamo, delle quali voglio supporre anch’io, che la Grecia abbondasse, e forse ne avesse anche delle migliori, ma queste esistono, e quelle sparirono, come pur troppo il tempo edace, sebben più tardi, farà sparire anche le nostre.»
RISPOSTA.
[48] Mi dica il mio avvedutissimo critico se la nostra poesia manca di quantità sillabica, ch’era quella che presso agli antichi diriggeva il tempo e la misura della musica e regolava il numero delle note, qual altro regolatore hanno i nostri compositori nelle cose accennate fuorché il proprio genio ed arbitrio? Se avessero eglino una norma fissa e costante a cui accomodarsi nella collocazion delle note si vedrebbero tanti capricci, tante irregolarità, tanti modi diversi di vestir l’aria istessa? Che vuol dire che se , , e metteranno sotto le note le stesse parole dalle mani del primo verrà fuori per lo più un lavoro esatto, ragionato e pieno di forza, da quelle del secondo una composizione vaga, ricca, e brillante, e da quelle del terzo probabilmente una cosa mediocre, o cattiva? Ciò vuol dire che ciascuno combina le note e gli accordi secondochè gli suggerisce il proprio talento, il quale non essendo eguale in tutti tre, nemmeno eguale può essere l’effetto che ne risulta. A questo inconveniente andava molto meno soggetta la musica greca principalmente ne’ primi secoli, quando il carattere di poeta e di musico si trovava riunito nella stessa persona, e quando i musici ubbidivano religiosamente alle leggi prescritte loro dai poeti. Non replicherò le pruove, che trovansi esposte alla distesa nella mia opera nel luogo appunto criticato dal giornalista, il quale fedele sempre al lodevolissimo costume adottato da lui combatte le proposizioni dell’avversario sopprimendo tutte le ragioni su cui sono appoggiate. I due canoni che prescrive il Signor per applicar rettamente la stessa musica a varie parole, cioè che i versi sieno d’una stessa misura, e che il sentimento delle parole sia lo stesso, sono piuttosto regole di ciò che dovrebbe esser che di ciò, ch’è infatti, imperocché ad eccezione d’alcuni pochi maestri la maggior parte dei moderni lavora delle musiche applicabili a cento sentimenti diversi, come io l’ho fatto demostrativamente vedere colle pruove alla mano in otto pagine dell’ultimo capitolo del secondo tomo, adducendo inoltre le carte musicali che lo confermano205, quantunque né di queste né di quelle l’incomprensibile benignità dell’estrattista abbia creduto opportuno di farne menzione.
GIORNALISTA.
[49] «In qualche abbaglio è incorso il N. A. parlando dei principi musicali in cui confessa egli stesso di essere poco iniziato. Egli asserisce p. e. che gli intervalli che sono in uso nella nostra armonia si riducono all’ottave, due settime, due seste, due terze, una quinta, una quarta, la seconda, il tuono, e il semituono, come se questi due ultimi non fossero due altre seconde, cioè la maggiore e la minore, e come se anche quasi tutti gli altri intervalli non fossero triplicati a riserva dell’ottava, ch’è d’una sorte sola.»
RISPOSTA.
[50] Ognuno s’aspetta che questa obbiezione debba essere la più terribile di tutte, giacché non è imaginabile che un maestro di musica riprenda uno che non è della professione intorno ai termini facoltativi dell’arte, e che non dica delle cose incontrastabili. Nulladimeno siccome nel mondo di quaggiù l’aspettazione degli uomini resta sovente delusa, così sarà bene il disaminare se per disavventura siamo ora in questo caso. Ei mi rimprovera perché noverando gli intervalli che sono in uso nella nostra armonia, non ho fatto parola delle due seconde maggiore e minore, e perché non ho detto che tutti gli altri intervalli a riserva dell’ottava sono triplicati. Buon per me che il rimprovero non cade sopra di me soltanto, ma sopra d’uno scrittore il quale s’inalza per comune opinione sì nella teorica che nella pratica della musica tanto al di sopra di tutti i critici giornalisti.
[51] «Quantum lenta solent inter viburna
cupressi. Ecco le sue parole, la cantilena (fermandosi nel
genere diatonico in cui tutti convengono) non può formarsi se non da tanti determinati
intervalli i quali sono semituono, tuono, due terze maggiore e minore, quarta, quinta,
due seste maggiore e minore, e l’ottava; nulla di più (noti bene
l’accigliato estrattista) perché il resto non è che una replicazione degli
antecedenti
206»
. Ora a chi dovranno prestar fede i lettori a
o all’estrattista? La conseguenza è facile
a ricavarsi. Oltrecché è falsissimo ch’io abbia passato sotto silenzio le due seconde
maggiore e minore. Eccone la prova. Non ho io forse nominato il tuono, e il semituono? E
il tuono e il semituono non sono essi appunto gli intervalli che si chiamano con altro
nome seconda maggiore, e seconda minore? Lo dice espressamente l’ nella introduzione a’ suoi elementi di musica, «Le ton, sono le sue parole, s’appelle encore seconde majeure ecc. le
demi-ton, seconde mineure»
. Lo dice lo stesso giornalista, «come se
questi due (cioè il tuono e il semituono) non fossero due
altre seconde la maggiore, e la minore?»
Ora qual è lo sbaglio da me commesso?
Il non aver dato al lettore l’importante notizia che i teorici davano due nomi diversi
allo stesso intervallo; lo chè in altri termini equivale a condannare uno storico perché
nominando non s’è presa la cura d’avvertire
chi legge, che altri lo chiamarono ancora . Così potrebbe con eguale giustezza rimproverarmi, perché non mi
sono avvisato di dire che la terza minore si nomina qualche volta seconda superflua, e
che alla settima maggiore si da in qualche occorrenza l’appellazione di settima
superflua. Indi mi potrebbe accusare, perché non ho parlato del triton e della quinta
falsa, e dopo aver parlato di queste, perché non ho fatto menzione della quinta
superflua, e della settima diminuita, e così riprendermi all’infinito perché spiegandole
cause generali della decadenza del melodramma non ho fatto un trattato teorico degli
intervalli.
GIORNALISTA
[52] «Ritornando poi a parlare del contrappunto che consiste in una successione di varie voci espresse contemporaneamente con diverso movimento pretende che tutto questo pregiudichi all’unità della cantilena, la quale certamente non può muovere gli affetti, se non è chiara, semplice, precisa; ma abbiamo già detto che quando il contrappunto è moderato (cioè quando le altre parti non confondano colle loro cantilene la cantilena principale, ma solamente la secondano, la rinforzano, e l’accompagnano) egli non solo non le pregiudica, ma anzi la fortifica e la perfeziona.»
RISPOSTA.
[53] In primo luogo l’estrattista attacca al suo
solito la mia proposizione isolata, e non adduce neppur una sola delle molte pruove che
la fortificano. In secondo luogo è falsissimo ch’io abbia detto che se la cantilena
composta in contrappunto non muove una qualche determinata e individuale passione, ciò
nasca dal non esser la cantilena chiara semplice e precisa. L’inefficacia del
contrappunto per muover gli affetti l’ho ricavata da ciò, ch’essendo necessaria ad eccitar un determinato affetto nell’animo una serie di
movimenti tutti dal principio sino alla fine conformi alll indole di esso affetto, il
contrappunto non può produrre la detta serie di movimenti conformi, perché composto di
moltiplicità di parti, ciascuna delle quali agisce con un movimento non conforme, ma
diverso, e perché si prevale d’intervalli, ciascuno de’ quali agisce con un’energia, ed
una direzione differente207. L’estrattista dunque non sol non ha inteso per niente né la mia
proposizione, né le ragioni su cui s’appoggia, ma ha ravvisato sconciamente e quella, e
queste. In terzo luogo non è men falso ciò ch’avanza il , che quando il contrappunto è moderato non solo non pregiudica,
ma anzi fortifica e perfeziona la cantilena. La perfeziona bensì, se per perfezionare
s’intende darle quella unità, che risulta dal trasportare la stessa melodia in più
tuoni, e dal collocarla ne’ siti analoghi della composizione, o anche dal congruamente
alternare le diverse cantilene, onde nasce la varietà208; e di questa sorta di
perfezione si trovano molti, e distinti esempi ne’ moderni contrappuntisti dal fino al ; ma non la perfeziona punto quando si tratta di produrre il vero
patetico ovvero sia l’imitazione degli affetti umani. Per quanto le cantilene subalterne
accompagnino e rinforzino la cantilena principale sarà sempre vero che a generare non
già un’affetto vago e indeterminato (del quale non è quistione presentemente), ma una
determinata e individuale passione voglionsi de’ movimenti omogenei e tendenti tutti ad
un fine; lo che non può assolutamente ottenersi col contrappunto. Perocché le parti
subalterne agiscono anch’esse coi rispettivi movimenti che sono diversi in ciascuna dal
movimento della parte principale, e gli intervalli per cui scorrono quelle sono di
natura differente da quella degli intervalli per cui camina questa: È impossibile
adunque che non risulti nel tutto una mischia di forze, una ripugnanza, un contrasto tra
la privativa energia degli intervalli e delle parti, il quale impedisca d’eccitare la
determinata serie di movimenti che voglionsi a svegliare un tale affetto. Sentasi il
, che da gran maestro ha prevenuta e
disciolta l’obbiezione del giornalista. «Né giova dire che la voce acuta, per
esempio, come estremo più intenso, essendo la dominante, si sentirà distintamente a
confronto delle altre voci, e però potrà produrre il suo effetto. Questa proposizione
è falsa secondo la pratica (notate bene,
dolcissimo, perché mi preme che un giornalista sia docile alla verità, notate, dico,
che uno de’ più eccellenti pratici che abbia mai avuti la vostra nazione dice che la
vostra proposizione è falsa secondo la pratica) in armonia perché tre voci contro una
sola han più forza sebben la sola sia più intensa, le altre più rimesse, purché siano
proporzionate, senza la qual proporzione non s’otterrà giammai l’armonia. E nel caso
che s’accordasse la proposizione non si può almeno di non negare che nascerà
necessariamente una tal distrazione tra la voce principale e le aggiunte, che impedirà
quella totale attenzione senza cui è impossibile ottener l’intento di
commuovere.»
GIORNALISTA.
[54] «Insomma ci può dir quel che vuole per provare che la nostra musica è inferiore alla Greca, che non proverà mai nulla, non potendosene fare il confronto; e le autorità dei tre rispettabili professori che adduce in favor suo ancor esse sono inutili su tal questione. stanteché il , il P. e il sono stati certamente grandi uomini, ma ebbero i loro pregiudizi ancor essi, fra gli altri quello che hanno quasi tutti i vecchi professori di qualunque arte, e ch’è prodotto da una specie d’invidia pei loro contemporanei, cioè di lodare assai le cose antiche e sprezzar le moderne, come se tutte le arti, nello stesso modo che son soggette a declinare, non fossero suscettibili di miglioramento, la qual cosa è assai più probabile per quella gran ragione che è facile l’aggiunger perfezione alle cose già inventate.»
RISPOSTA.
[55] Se la taccia di “pregiudicati” e d’“invidiosi”
data a tre uomini de’ più rispettabili che abbia avuti l’Italia
fosse una ragione, noi conchiuderemo che l’estrattista sapeva dire delle ragioni; ma
essendo quelli epiteti una ingiuria altro non si può conchiudere se non ch’egli sa dir
delle ingiurie. Colla stessa ragione potrebbe tacciare il , il , il , il , il
, lo , il , il , il , il
, il , e cento altri valenti scrittori, i quali accoppiando la più sagace
filosofia all’erudizione più scelta hanno deciso nella presente quistione in favore
della musica antica. Essi adunque tutti saranno pregiudicati, invidiosi, e adoratori del
rancidume. Ad onta però della magistrale decisione del , ci permetta parlando di qualunqne de’ suddetti scrittori che
noi gli susurriamo rispettosamente all’orecchio «malo cum errare, quam cum… bene sentire»
e ci permetta altresì di
mettergli sotto gli occhi le seguenti parole tratte dalle opere d’uno di quei
“pregiudicati” e “invidiosi”, le quali potranno forse servire di correttivo alla
ridicola baldanza di più d’uno dei moderni maestri. «Sempre fra gli uomini fu
grandissimo il numero di coloro a cui piacque più la loro età che l’antica, non tanto
perché reputiamo un atto lodevole pensar bene de’ nostri contemporanei, quanto perché
traendo origine ogni nostra affezione dall’amor proprio lodiamo con compiacenza que’
tempi, dei quali crediamo esser noi stati un non mediocre ornamento. Di ciò è un
manifesto argomento il vedere che infinite persone di niuna o pochissima vaglia e di
cui non potrebbe assegnarsi il luogo che occupano presso i loro contemporanei, ciò
nonostante inalzano a tal segno il secolo in cui vissero, che per poco non vanno sulle
furie quando altri commenda i tempi ov’essi non furono. La provvida natura dispose con
tale accorgimento le umane cose che sebbene l’uomo sia inchinevole a lagnarsi di
tutto, non si trova neppur un solo che non viva persuaso e contento del proprio
ingegno, e ciò che oltremodo fa meravigliare si è che quanto più si scarseggia di
talento, tanto di se medesimo più vantaggiosamente si pensa.»
209
GIORNALISTA.
[56] «Cosa diremo noi, se il Signor sembra essere appunto nel numero di quei tali vecchi spregiatori, lodando egli moltissimo le opere del , del ecc. a preferenza delle più moderne, che sono cento volte migliori e più perfette?»
RISPOSTA.
[57] Queste quattro righe altro non sono che un gruppo d’inesattezze e di false supposizioni.
[58] 1. Finora s’era parlato della musica moderna in generale paragonandola coll’antica; ora il generale si converte all’improvviso in parziale, la parola “moderna” si confonde con quella “de’ nostri tempi”, dal sistema si salta al gusto e da tal confusione propria dell’estrattista risulta un’accusa contro di me, che mai non ho pensato a confondere una cosa coll’altra.
[59] 2. Il giornalista mi riprende mettendomi nel numero de’ vecchi sprezzatori, perché ho lodato e , due compositori che sono stati ricolmati di lodi dai più accreditati scrittori di musica non meno stanieri che Italiani.
[60] 3. M’imputa d’aver commendate l’opere del
a preferenza delle più moderne, che sono
cento volte migliori e “più perfette”, lo che è falso assolutamente, giacché non ho
lodati i recitativi del se non
paragonandoli cogli altri del suo tempo, ch’erano negletti, non già con quelli dell’età
posteriore, quando s’imparò ad applicare la musica alla drammatica con più gusto e
leggiadria. Ecco le mie parole: «, illustre compositore romano dopo la metà dello scorso secolo,
cominciò a modular i recitativi con più di grazia e di semplicità avvegnacchè non vi
si facesse allora particolar riflessione, sì perché il gusto del pubblico rivolto
intieramente alle macchine e alle decorazioni badava poco alla dilicatezza della
composizione, come perché la poesia dei drammi così poco interessante faceva perdere
il suo pregio anche al lavoro delle note»
. Convien dire che gli occhiali con
cui il Signor guarda le cose abbiano la
virtù di rappresentare gli oggetti al rovescio. Del resto, se prima di censurare i detti
altrui si prendesse egli la briga d’esaminare il fondamento delle proprie censure,
avrebbe potuto vedere nella Musurgia del una serie di composizioni musicali de’ più bravi maestri del
passato secolo, e comparando queste collo stile recitativo del , di cui esistono pure gli esempi, avrebbe rilevata la differenza
tra gli uni e gli altri.
GIORNALISTA.
[61] «Cosa diremo, se egli che attribuisce al contrappunto la rovina della musica, lodale suddette opere, delle quali il più gran merito consiste appunto nell’abbondare di contrappunto?»
RISPOSTA.
[62] Ho già spiegato più volte in qual senso io condanni il contrappunto. Del resto appunto perciò ho commendati i recitativi del , perché fra quelli de’ suoi contemporanei sono i meno ingombrati di contrappunto.
GIORNALISTA.
[63] «Per criticar poi la musica delle nostre arie, adduce quei difetti che sono già stati conosciuti da tanti altri, e dei quali son più di venti anni che sin la ciurma dei nostri compositori se ne astiene, e in cui veramente i bravi maestri mai non sono incorsi. Essi infatti non hanno mai fatti ritornelli e passaggi dove non andavano, non hanno mai coperta la voce colla troppa affluenza degli strumenti, non hanno ecc.»
RISPOSTA.
[64] Se i difetti da me apposti alla musica de’ nostri tempi sono stati conosciuti da tanti altri, essi adunque sono verissimi, e il quadro ch’io ho proposto non è per niente alterato, come ha finora preteso il giornalista. Parmi per altro d’aver toccate molte cose non osservate imprima da nessuno scrittore, particolarmente intorno alle cagioni del difetto, e ai mezzi di correggerlo. È poi falsissimo che da venti anni in quà fin la ciurma de’ compositori se ne astenga. Gli esempi che ho recato in mezzo (e de’ quali secondo il costume non fa parola l’estrattista, quantunque gli aprissero un bel campo di farsi onore difendendoli) non sono cavati dalla ciurma, ma dalle opere di compositori stimabili. Se però tutti questi sembrano pochi al Signor , chi scrive gli promette di slungare in altra occasione il catalogo, e di fargli toccare con mano che la maggior parte de’ moderni maestri mettono i ritornelli e passaggi dove non ci andavano, coprono la voce colla troppo affluenza degli strumenti, hanno ecc. ecc.
GIORNALISTA.
[65] «Egli asserisce ancora che , colle molte bellissime comparazioni, ha contribuito a propagare il difetto della troppa musica strumentale nei teatri, ma queste comparazioni hanno anzi giovato alla musica; come da noi si asserì nella nota 13 del nostro Libro delle Regole armoniche.»
RISPOSTA.
[66] Senza riccorrere alle Regole armoniche del (libro frivolo, che altro non contiene fuorché delle nozioni elementari e triviali), io aveva detto nel tomo 2. pag. 263. della mia opera che le belle comparazioni che si trovano ne’ drammi di hanno giovato alla musica. Ma ciò che ho detto io, e che il non vorrebbe che si dicesse, si è che dall’uso troppo frequente di esse comparazioni è risultato il troppo affollamento degli strumenti, e per conseguenza il prossimo pericolo d’affogar la voce del cantore. Si può aggiungere ancora che siffatta usanza troppo intemperantemente imitata dai seguaci di ha recato ancora un gran danno alla poesia, perocché i poeti alloppiati dalla vaghezza delle similitudini profondono le bellezze di pura imaginazione in quei luoghi del dramma, dove solo dovrebbero aver luogo le bellezze di sentimento. L’estrattista doveva esaminar queste ragioni e combatterle, e non contentarsi di citar se stesso e le Regole armoniche, perché ned egli né le sue Regole armoniche fanno autorità, quando non sono avvalorate dal giusto ragionamento.
GIORNALISTA.
[67] «Dove si disse ancora il nostro parere circa all’apertura dell’opera di cui parlando il N. A., e parlando della nostra musica in generale, impiega una quantità d’osservazioni inconcludenti o false…»
RISPOSTA.
[68] Se l’estrattista si fosse degnato d’indicare partitamente quelle osservazioni, io cercherei ora di rispondergli o di confessargli il mio torto; ma essendosi contentato di dire in generale che sono “inconcludenti, e false” senza provarlo, non posso risponder altrimenti che dicendo esser falso il suo “false”, e inconcludente il suo “inconcludenti”.
GIORNALISTA.
[69] «Che esamini bene le buone composizioni di , di , , , , , , e di tanti altri, e veda se il moderno quadro della musica teatrale è tal quale ei lo dipinge.»
RISPOSTA.
[70] E appunto perché le buone composizioni di , , , , , e meritano che si parli con distinzione, l’autore delle Rivoluzioni ha parlato con distinzione ed ha cavato l’esempio del recitativo obligato, del rondò, dell’aria e delle altre parti che ha preso a disaminare dal , dall’, dall’ e da più altri, che non sono né , né , né , né , né , né , né . E se pure in questi valentuomini ha talvolta ripreso qualche difetto, lo ha fatto rendendo loro la dovuta giustizia, separandoli dalla feccia comune, e nominandoli con particolar elogio. Qual nuovo genere d’onestà letteraria è mai quella di tacere ciò che ha detto l’avversario, e poi combatterlo come se realmente non l’avesse detto? È malignità? È stolidezza? È capriccio?
GIORNALISTA.
[71] «Senza tanto declamare e senza ripetere ciò ch’è stato già detto da altri (cioè che vi sono molti guastamestieri che le regole non sono ancora tutte perfette; e che se anche lo fossero esse non basterebbero per formare un grand’uomo, lo che è più vero) poteva dire che pochi riescono nell’arte musica, perché non tutti son nati per la medesima; ma non perché i maestri insegnano il contrappunto ai loro scolari col fargli ritrovare gli accordi, e concertare le parti sul cembalo mentre questo è falsissimo.»
RISPOSTA.
[72] Quest’ultima riflessione mi giunge nuova. Mi farebbe la grazia il giornalista d’insegnarmi come imparano gli scolari il contrappunto senza avvezzarsi a “ritrovare gli accordi, e a concertate le farti”?
GIORNALISTA.
[73] «Come non è men falso che tutti i compositori siano tanti ignoranti non sappiano nemmeno la propria lingua non che la latina, non conoscano la poesia, la letteratura e gli autori che han trattato e trattan di musica; poiché gli conoscon benissimo; e sanno ancora distinguere gli aurori buoni dai mediocri, e non li pongono tutti a sacco, come ha fatto il N. A. alla pag. 81.»
RISPOSTA.
[74] Io non ho parlato punto di tutti quanti i compositori, ma del maggior numero; pure confesso d’avere il torto. Invece d’avanzare ciò ch’ho avanzato, dovea sostenere con zelo apostolico che la maggior parte dei moderni maestri sono dottissimi, che intendono a meraviglia la lingua latina, e gustano le più intime squisitezze della toscana, che sono versatissimi nella poesia, e nella letteratura, che hanno come suol dirsi sulla punta delle dita tutti gli autori, che hanno trattato e trattan di musica. Infatti per tacer di tanti altri la scelta erudizione è vastissima, la prodigiosa lettura, la critica finissima, le viste sublimi e filosofiche, l’aureo stile e la logica esatta che risplendono nell’estratto del Signor mi doveano far accorto del mio errore.
GIORNALISTA.
[75] «Perché condannar tanto il desiderio di novità che hanno gli uomini in generale di musica, se lo hanno ancora per tutte le altre cose, e se a quelli che non sono automi viene infuso dalla natura? Dunque, perché vi fu un , un ecc. non doveva scrivere un , un , ecc.? Perché vi è stato un , un , ecc., non dovrebbe scrivere un , un ecc.? E se ognuno che coltiva una professione vuol distinguersi dai compagni, desidera di esser grande piuttosto colla lode propria che coll’altrui, cerca di avanzarsi nella sua carriera per sentieri non battuti ecc., perché farlo reo, quando al contrario giusto per questo è degno di lode? In verità noi non intendiamo un tal modo di ragionare.»
RISPOSTA.
[76] Quando l’estrattista avrà un pò più di filosofia in testa, intenderà facilmente il mio modo di ragionare. Allora vedrà ch’ei non ha inteso né poco né molto lo stato della quistione, e che lavora in falso, perché non sa dare alla parola “novità” il significato che nel caso nostro le si conviene. Il desiderio di novità considerato metafisicamente è una inclinazione ingenita in noi dalla natura, come un’effetto immediato della curiosità. L’anima nostra è fatta per pensare, cioè per percepire e combinare l’idee. Tutti gli oggetti dell’universo sono legati fra loro e quasi direi in dipendenza scambievole gli uni degli altri; quindi è impossibile il conoscerne un solo senza che si svegli il desiderio di conoscere quello che seguita, o quello che lo precede. Ma quest’idea metafisica di novità lodevole in se stessa anzi necessaria all’uomo è in tutto differente dall’altra che vien condannata allorché si parla delle arti di sensibilità e d’imaginazione. Il desiderio di essa altro non significa allora se non se il prurito che hanno molti di coloro che le coltivano, di rendersi singolari scostandosi dal buono stile e dagli ottimi esemplari, o l’inquieta smania degli ascoltanti, che infastiditi delle cose passate e noiati delle presenti bramano ricevere delle scosse, e delle agitazioni mai più sentite. L’una e l’altra di queste cose sono la rovina delle arti e delle belle lettere, imperocché consistendo il bello di esse nell’imitazione della natura, ed essendo siffatta imitazione ristretta ad una limitata sfera di sentimenti e d’imagini espresse con certi colori e con certe determinate forme, qualora la suddetta sfera sia stata, a così dire, intieramente trascorsa per opera dei trapassati autori, e qualora agli artisti comincino a sviare da quelle forme e da quella determinata maniera; vanno a rischio di perder affatto le traccie della vera imitazione, smarrita la quale non resta per loro altro principio regolatore fuorché il capriccio, onde si genera la stravaganza. Ecco il perché la novità degenera sì spesso in licenza nelle materie di gusto, e perché il rispetto per gli antichi e così commendabile, quando non si converte in fanatismo o in idolatria. Legga il Signor l’aureo dialogo De causis corrupte eloquentiae attribuito a , e fra i moderni la bella Dissertazione del intorno alle cause della decadenza del gusto, e vedrà la felice applicazione ch’ivi si fa del principio esposto pur ora all’eloquenza, alla poesia, e alla storia. Legga il terzo libro della Repubblica di , e i Trattenimenti sullo stato della musica greca intorno al quarto secolo dell’era cristiana di Monsieur , e troverà verificato il mio principio anche nella musica. Dopo ciò si vergognerà forse di aver combattuto una proposizione chiara quanto il lume di giorno, e capirà che un ragionamento che serve di base ai più accreditati scrittori per ispiegar la decadenza del gusto non può essere alterato con tre “perché” e con cinque ridicolosi “eccetera”, i quali fanno vedere essere egualmente ignote al giornalista l’arte di pensare, e quella di scrivere.
GIORNALISTA.
[77] «Quello poi che ci sorprende maggiormente si è che dopo che il N. A. ha resa giustizia a una quantità di professori viventi separandoli dai mediocri torna da capo, sostiene che la maggior parte delle finezze armoniche onde vanno tanto superbi i moderni maestri, invece di provare il miglioramento del gusto altro non provano che la sua decadenza. Questa non è una patente contrariazione? Quando si vuol sostenere un opinione bisogna ben provarla, e non contraddirsi, come fa talvolta il N. A.»
RISPOSTA.
[78] Il giornalista somiglia a quel Margita sì celebrato dai maestri di rettorica del
secolo scorso, il quale, quando vedeva incurvarsi sotto l’acqua una parte del suo
bastone, invece d’attribuirlo ad un’inganno della propria vista, credeva che il bastone
si fosse realmente sotto l’onda incurvato. Non avviene altrimenti delle contraddizioni
che vede ne’ miei sentimenti il giornalista, ma ch’esistono soltanto nel di lui
cervello. Due proposizioni hanno dei rapporti alquanto lontani, ma conciliabili fra
loro, non si scorge da chi legge il filo che le avvicina o per pochezza d’ingegno, o per
precipitazione di giudizio, e tosto grida “contraddizione”. Quindi questa sorta d’accuse
deve essere ed è molto frequente presso certa classe di censori; i quali veggono ne’
libri i pensamenti degli autori come gli itterici veggono negli oggetti la giallezza
onde sono tinti gli umori de’ propri occhi. Ma esaminiamo ora quelle che mi vengono
imputate, e incominciamo dalla prima. Trova un’opposizione il giornalista ne’ miei
sentimenti, perché avendo resa imprima la dovuta giustizia ad una quantità di professori
viventi separandoli dai mediocri, sostengo poco dopo che «la maggior parte delle
finezze armoniche, onde vanno tanto superbi i moderni maestri»
invece di
provare il «miglioramento del gusto altro non provano che la sua
decadenza»
. Se quest’ultima proposizione cadesse su quegli stessi maestri
ch’io separai dai mediocri, il giornalista avrebbe ragione di dire ch’io era in
contraddizione con me medesimo; ma cadendo, come cade infatti, sui mediocri, invece di
provare ch’io mi sono contraddetto altro non prova se non ch’egli precipita i suoi
giudizi e le sue censure. Si ricorra alla pag. 130. del mio secondo tomo e si vedrà che
dopo aver terminato il catalogo dei valenti professori che meritano, a mio avviso,
d’essere separati dagli altri, soggiungo: «sarebbe più facile ad una ad una
noverar le stelle, che il fare partitamente menzione di tanti altri compositori o
esecutori ptù giovani, che sotto la scorta degli accennati maestri coltivano
quest’arte deliziosa in Italia. Ma l’andare più oltre né piace,
né giova, non essendo il mio scopo il tessere una nomenclatura od un catalogo, ma
presentare soltanto agli occhi de’ lettori una rapida prospettiva. Quello che in
generale può dirsi è che nelle mani loro (cioè non de’ maestri
accennati prima ma di questi secondi), la musica acquista a certi riguardi una
maggiore bellezza mentre la va perdendo a certi altri»
. Dopo alcune righe dove
c*ontinua sempre senza interruzione il sentimento medesimo, viene l’altra proposizione
citata dal giornalista. Dov’è dunque, o
dolcissimo, la patente contraddizione?
GIORNALISTA.
[79] «S’egli vuol sostenere, per esempio, che la musica sia decaduta, perché nel primo tomo parlando della melodia si è lasciato uscir di penna il seguente paragrafo?
«Essa è l’unica parte della musica che cagioni degli effetti morali nel cuor dell’uomo, i quali oltrepassano la limitata sfera dei sensi, e che trasmette ai suoni quell’energia dominatrice che ne’ componimenti s’ammira de’ gran maestri.»(T. 3. pag. 177.) Se non vi fosse come si potrebbe ammirare?»
RISPOSTA.
[80] Le mie parole citate nell’estratto si trovano
alla pagina sesta del tomo secondo della presente edizione. Chiunque si prenderà la pena
di leggerle troverà ch’io, facendo in quel luogo il paragone tra l’armonia e la melodia,
esalta i pregi della melodia in riguardo all’espressione e all’imitazione della natura,
e che favellando di essi dico che dobbiamo a lei principalmente «quell’energia
dominatrice, che ne componimenti s’ammira de gran maestri»
. Egli è chiarissimo
che parlandosi ivi della melodia in genere e non in ispecie, anche i maestri, ne’
componimenti de’ quali s’ammira la sua energia, devono intendersi in genere e non in
ispecie, cosicché può applicarsi con ogni giustezza la mia proposizione tanto ai
compositori greci, latini, tedeschi, francesi quanto agli italiani. Per trovarmi dunque
in contraddizione avrebbe dovuto il giornalista far vedere ch’io in qualche luogo della
mia opera avessi espressamente negata a’ compositori d’ogni età l’arte di far valere la
melodia, e che poi nel luogo citato da lui l’avessi loro espressamente conceduta. Non
potendo egli provare ch’io abbia avventurato né l’una né l’altra di tali proposizioni,
anzi trovandosi in molti luoghi delle mie Rivoluzioni smentite entrambe,
mi permetterà che torni alla mia similitudine di Margita, col quale il giornalista ha più d’un punto di rassomiglianza
GIORNALISTA.
[81] «E più oltre parlando della melodia in contrappunto si spiega come segue:
“Si badò sopra tutto a conservar l’unità nella melodia, regola fondamentale di musica, come lo è di tutte quante le belle arti, la quale consiste nel rivolgere verso un’oggetto tutta l’attenzione e tutto l’interesse dell’uditore, nel rinforzar il motivo dominante, ovvero sia il canto della parte principale con quella di ciascuna in particolare, e nel far sì che l’armonia, il movimento, la misura, la modulazione, la melodia e gli accompagnamenti s’acconsentano scambievolmente, e non parlino, a così dire, che un solo linguaggio. Codesto pregio che non sembra a prima vista né straordinario, né difficile ad ottenersi, è nulla meno uno degli sforzi più grandi, ch’abbiano fatto i moderni italiani.”Basti questo solo saggio di contraddizioni per far vedere, che il Sig. non doveva deprimere quelle cose che prima egli avea lodate con tanta eloquenza. E s’egli ci dirà che s’intese di lodar la musica de’ primi inventori del buon gusto, come di un , di un ecc. e non la nostra; noi gli risponderemo lo stesso che già si rispose ad altri nella summentovata nota13. del nostro libro Regole armoniche, cioè che la musica d’allora in poi avendo sempre guadagnato, non è stata mai tanto eccellente come lo è presentemente.»
RISPOSTA.
[82] E dov’è mai in queste parole neppur un’ombra di contraddizione? Ho detto che uno degli sforzi più grandi che abbiano fatto i moderni italiani, è quello di conservar l’unità della melodia; ho inteso nel luogo citato (tom. 2. pag.) per “moderni italiani” lo , il , il , il e più altri di quell’età; non ho mai smentito il giusto elogio dato a que’ valentuomini, dove dunque si trovano depresse da me quelle cose ch’io aveva lodato? Ma io ho depresso alcuni compositori della nostra età? Ebbene il lodare gli scrittori d’un tempo e il biasimare alcuni d’un altro è forse un contraddirsi? O pretenderebbe il giornalista che per non essere in opposizione con me medesimo avessi io dovuto confondere i compositori d’allora coi compositori di cinquanta anni dopo? La pretensione sarebbe tale che non meriterebbe risposta. Circa i guadagni e le perdite che ha fatto la musica dai tempi del e del insino a’ nostri giorni, io ho detto il mio sentimento nell’ultimo paragrafo del secondo tomo. Se il non lo trova giusto, rechi in mezzo fedelmente le mie ragioni, le combatta, e poi la discorreremo. Ma non si contenti di dirci un sì e un no, poiché il sì e il no in buona logica lasciano le cose come si stavano. E se il ragionare gli costa fatica, tralasci di fare il censore e il Radamanto degli altrui libri colla sicurezza che la repubblica letteraria ne farà piccolissima perdita.
GIORNALISTA.
[83] «Non ci sembra neppur ben provato ciò che asserisce il Sig. , cioè:
«L’amor del piacere che ricompensa gl’Italiani della perdita della loro antica libertà, e che va del paro in una nazione coll’annientamento di pressoché tutte le virtù politiche, ha fatto nascere la frequenza degli spettacoli (…). In ogni piccola città, in ogni villaggio si trova inalzato un teatro (…). Il popolo italiano ora non chiede che panem, et circenses, come facevano i Romani a’ tempi di . ecc.»Ella è cosa incerta se ogni villaggio ed ogni picciola città abbia il teatro, ma egli è ben certo che l’abbondanza dei teatri e la frequenta degli spettacoli quando però non sia eccessiva, prova piuttosto l’avanzamento che l’annientamento delle virtù politiche d’un paese; mentre se per istruire e incivilire gli uomini giovano anche molto le buone rappresentazioni teatrali; e se gli spettacoli sono necessari e vantaggiosi ad una colta nazione per riunirla e per trattenerla con qualche onesto ed utile passatempo, crediamo appunto che anche perciò l’Italia possa dirsi fortunata, conciosiachè se adesso più che in passato abbonda di teatri e di spettacoli, abbonda ancora degli ornamenti più essenziali, cioè di Università, di Accademie, di Scuole, di Stamperie, di Spedali di altre pie istituzioni, e di uomini sapienti in ogni facoltà, dei quali pregi tutti, se gli stranieri stessi, quelli che sono giusti ed imparziali non ne fossero persuasi non verrebbero sì spesso in Italia, chi per vederla e goderla, e chi per istruirsi.»
RISPOSTA.
[84] Il giornalista entra nelle regioni della
filosofia come i soldati di Goffredo entravano
nella selva incantata. Sarebbe una scipitezza il trattenersi a combatterlo seriamente,
giacché non si saprebbe come né da qual banda afferrarlo non trovandosi nel suo scrivere
la menoma analisi la menoma connessione. Per far conoscere il guazzabuglio d’idee che
regna nelle sue parole basterà scomporre le fila del mirabile ragionamento che vi
s’asconde. Aveva io detto: «L’amor del piacere, che va del paro in una nazione
coll’annientamento di pressoché tutte le virtù politiche, ha fatto nascere la
frequenta degli spettacoli.»
Per distruggere la mia asserzione il giornalista
doveva provare due cose, che l’amor del piacere in una nazione non va del paro
coll’annientamento di pressoché tutte le virtù politiche, e che l’amor del piacere non
ha fatto nascere la frequenta degli spettacoli. In luogo di ciò pianta fin da principio
una proposizione in tutto differente, cioè che l’«abbondanza de’ teatri e la
frequenta degli spettacoli provano l’avanzamento delle virtù politiche in un
paese»
. Fin qui si vede ch’egli non ha inteso me, vediamo almeno se intende
meglio se stesso. Come prova la sua tesi? Ecco il sillogismo: se per «istruire, e
incivilire gli uomini giovano molto le buone rappresentazioni teatrali, e se gli
spettacoli sono necessari ad una nazione per trattenerla con qualche onesto
passatempo»
, dunque, la conseguenza doveva essere l’abbondanza de’ teatri e la
frequenza degli spettacoli provano l’avanzamento delle virtù politiche in un paese, ma
la conseguenza è dunque «crediamo appunto che anche perciò
l’Italia possa dirsi fortunata»
. Non vi par che
l’estrattista giuochi al giuoco degli spropositi, e che interrogato “perché fa caldo
nella state?” risponda “perché il Padre ha
fatto il Trattato del matrimonio”? Tralascio le proposizioni intermedie
che non reggono a martello per tener dietro alla sua logica mirabile.
«Conciosiachè, ecco la causale che dee rinforzare la sua
conseguenza, se adesso più che in passato abbonda di teatri e di spettacoli,
abbonda ancora d’Università, d’Accademie, di Scuole, di Stamperie, di
Spedali»
, come se gli Spedali, le Stamperie, le Scuole, l’Università e
l’Accademie fossero altrettante virtù politiche generate in
Italia dall’abbondanza de’ teatri, e dalla frequenza degli
spettacoli, ch’era ciò che doveva provarsi. «De’ quali
pregi (seguita il nostro ) se gli
stranieri giusti ed imparziali non fossero persuasi, non verrebbero sì spesso in
Italia, chi per vederla e goderla, chi per
istruirsi.»
Sicuramente vi vuol poca persuasione, poca imparzialità e poca
giustizia negli stranieri, per credere che in Italia vi saranno
degli Spedali, delle Scuole, delle Stamperie e delle Università come vi son dappertutto,
né penso che il desiderio di vedere tali cose gli spronerà a partire dal proprio paese;
ma che ha da fare tutto ciò colla prima proposizione che doveva dimostrarsi falsa cioè:
l’«amor del piacere ha fatto nascere la frequenta degli spettacoli»
? La
dialettica del ha l’arte di raccozzar le
cose come si trovano raccozzate in quel verso del
«Zaffiri, orinali, ed ova sode».
GIORNALISTA.
[85] «E lo stesso Sig. se non ci fosse venuto da giovine, non ci avesse fatti i suoi studi, e non dimorasse ancora fra una nazione ricca in ogni coltura (quantunque si veda ne’ suoi scritti, che non l’ho per anche conosciuta), non avrebbe potuto diventare quell’uomo erudito e virtuoso ch’egli è.»
RISPOSTA.
[86] Anche qui sembra che il giornalista amico di sollazzarsi abbia guiocato al giuoco dei pegni, e che per riscuoterne qualcheduno de’ suoi gli sia stato imposto per penitenza che dica una lode e un biasimo. Lo ringrazio quanto debbo, e debbo ringraziarlo moltissimo per la prima, la quale cortesemente mi dispensa senza meritarla; e in quanto al secondo compreso nella parentesi mi protesto che attenderò per conoscer meglio la letteratura italiana, che l’eruditissimo Sig. , della cui estesa e profonda dottrina in ogni ramo dell’italico papere ha l’Europa tante luminose e replicate prove, mandi in luce una storia generale di essa che ci faccia dimenticare quella del .
GIORNALISTA.
[87] «Nei tre seguenti capitoli, cioè nel terzo, quarto, e quinto, che compiscono questo secondo tomo, grazie al cielo non vi sono tante opinioni che ci facciano dubitare di loro certezza, ma anzi vi sono tante belle verità, specialmente sopra l’infame usanza dell’evirazione, e sopra molte altre cose, che ci uniamo ben volentieri alle giuste idee del N. A., ma preghiamo il lettore a vederle in fonte, perché troppo ci vorrebbe se tutte volessimo qui riportarle.»
RISPOSTA.
[88] Più d’un osservazione può farsi intorno alle precedenti parole. Ne’ tre seguenti capitoli del secondo tomo dell’edizione bolognese non vi sono secondo l’estrattiva tante opinioni che gli facciano dubitare della loro certezza: pure i principi ond’io parto per esaminare lo stile del moderno canto italiano sono gli stessi stessissimi, che mi serviron di scorta per disaminare lo stile delle moderne composizioni. Se questi sono falsi, anche falsi devono essere quelli del canto, e se non si può dubitare della certezza de’ secondi, non può nemmen rivocarsi in dubbio la certezza de’ primi. Nulladimeno il giornalista accusa di “false”, e d’“inconcludenti” le mie riflessioni intorno ai compositori, e trova poi “tante belle verità” nel capitolo dove si parla dei cantanti. Che vuol dire questa incoerenza? Forse ch’ei non ha letto con attenzione quel capitolo, o che non l’ha inteso?
[89] Si mostra inoltre molto soddisfatto di quanto
dissi intorno «all’infame usanza dell’evirazione»
, ma non creda il
lettore che ciò sia per farmi una grazia. Il giornalista ha le sue cagioni segrete, onde
bramare di vedere alquanto umiliati cotesti evirati. Uno di essi ebbe
la temerità di rivedere ben bene i conti al Signor mostrandolo agli occhi del pubblico ignorante ne’ principi
della scienza del canto210, quindi l’astio del
contro gli eunuchi. Lo compatisco. Se
Martano fosse giunto una volta a buttar giù
dall’arcione Rinaldo, Rinaldo avrebbe ragione d’impallidire ogni qual volta
sentisse nominare Martano.
GIORNALISTA.
[90] «Solo non avremmo voluto udire che uno, il quale ha preteso di unirsi al Sig. per tacciare i moderni scrittori italiani di neologismo straniero, chiamasse “ressorti della virilità” le parti nobili dell’uomo, essendo vero francesismo la parola ressorti, e non abbisognandone la nostra ricca favella.»
RISPOSTA.
[91] L’espressione “ressorti della virilità” è stata cangiata “in sorgenti della virilità” nella veneta edizione. Se il avesse (siccome il pregai espressamente per lettera) compilato l’estratto della mia opera sull’edizion veneta anziché sulla bolognese, il secondo tomo della quale fui costretto per motivi che non sono di questo luogo a non riconoscere per mio, avrebbe ora risparmiato questa frivola riprensione. Ma in tal caso avrebbe preferita la gloria d’esser cortese e gentile alla meschina e miserabile compiacenza di criticare un francesismo nel libro d’un’oltramontano, compiacenza a cui difficilmente resiste quella genia di persone che vive delle secrezioni dei talenti come i corvi e gli avoltoi si pascono della carne infracidata dei cadaveri.
GIORNALISTA.
[92] «Nè si vorrebbe ch’egli avesse asserito che
«la musica non sa accompagnarsi colla poesia senza portar seco tutto il corredo degli abbigliamenti, e per conseguenza senza opprimere la compagna, e a guisa dell’amore ella non sa regnare che sola». No: questo non sembraci vero. La musica può regnar sola, ma non vuole, e sanno benissimo i bravi maestri che dessa ha sempre più efficacia ed espressione quand’è unita alla poesia.»
RISPOSTA.
[93] Non mi saprebbe dire il lettore quale fosse in
questo paragrafo la confutazione, e quale la cosa confutata? Io aveva detto, che
«la musica, cioè non la musica in genere, ma la troppo sfarzosa e brillante,
non sa accompagnarsi colla poesia senza opprimerla»
. Il giornalista risponde
che non è vero, e perché? «Perché la musica può regnar sola, e perché i maestri
sanno benissimo ch’ella è più efficace ed espressiva quando va congiunta colla
poesia»
. La mia proposta era che la musica al dì d’oggi affoga le parole. La
risposta è che la musica può star da per sé, e che ha più forza quando s’unisce alle
parole.
«La raison dit , et la rime .»
GIORNALISTA.
[94] «Egli è ancor d’opinione che la divisione in recitativo semplice, obbligato, ed aria, di cui è formata la nostra opera, non fosse la stessa presso i Greci, ma noi ci uniamo piuttosto al parere del Sig. avvocato , e crediamo che fosse la stessa stessissima.»
RISPOSTA.
[95] Il giornalista è prudente, e politico nel tempo stesso. Ei si dispensa dal ragionare, e in ciò mostra la sua prudenza. L’esame che fin qui s’è fatto della sua logica mostra parimenti che avrebbe fatto meglio ad essere prudente più di buon’ora. Mi vorrebbe inoltre costringere a venir alle prese con un letterato di tanto polso, qual è il Signore D. , e in ciò fa vedere la sua politica insidiosa. Di più, non indicando in qual luogo delle sue opere, che sono comprese in molti volumi, abbia quel dotto ed erudito scrittore asserito che la nostra divisione in recitativo semplice, recitativo obligato, ed aria fosse la stessa stessissima presso ai Greci, io non posso né disaminare le sue ragioni, né accusare di falsiti il giornalista. Due sono le dissertazioni dove il celebre avvocato napolitano tratta di proposito questa materia; l’una intitolata Nuovo sistema d’interpretar i tragici greci, l’altra intorno alla poesia lirico-drammatica de salmi. Nella prima il lodevole desiderio di veder trasferita in Roma e in Napoli l’antica Atene lo sollecita a cercar nelle tragedie di , di e d’ le arie, i duetti, i terzetti, i quartetti e i finali qualmente si trovano nell’opera italiana. Ei ci dà questo suo sistema come una nuova scoperta sconosciuta a tutti fino al presente. Se ciò fosse vero non si dovrebbe sdegnare l’illustre autore, che il pubblico non abbandonasse così presto l’opinione di venti secoli per l’ingegnose conghietture di pochi giorni. Allora avrà diritto di trarre il mondo letterario nel suo sentimento, quando vedremo da lui rischiarato l’abbuiamento dei codici ch’egli suppone tutti scorretti, e rettificati i pregiudizi de’ traduttori e de’ commentatori ch’egli crede tutti inesperti. Ma fin tanto che il dotto scrittore non s’accigne a così magnanima impresa, noi continueremo a far uso dell’edizioni che abbiamo, e a prestar fede a que’ dotti commentatori, l’osservazioni de’ quali non ci fanno punto vedere ne’ drammi greci quelle rassomiglianze coi nostri ch’egli pretende che vi siano. Per esempio, nella prima scena dell’Atto IV. dell’Ecuba d’ tradotta dal Signor con molto brio e molta disinvoltura, trova egli un duetto in due versi greci d’ tradotti da lui in questa guisa:
Ecuba ed uno del coro } a 2:
«Ahi chi udì, chi vide maiChi provò di quel ch’io sentoUn affanno, ed un tormentoPiù terribile e crudel?Se dell’ospite infedeleNon punite il tradimentoAh che fate, o numi, in ciel?»
ma con quali argomenti si prova che l’aria qui esposta sia un duetto?
1. Nel testo greco le parole si mettono in bocca d’Ecuba. 2. In nessuna edizione d’ s’applicano al coro e alla confidente. 3. I versi sono giambici,
come tutti gli altri di puro recitativo, non anapestici o lirici d’altra natura, quali
essere dovrebbono se formassero un duetto. 4. Il sentimento non indica per niente che
qui vi deva essere un duetto. Ecco la traduzione letterale dalla quale si è scostato un
pò troppo il Signor : «Cose infami,
inaudite, da farne stupire, inique, insopportabili! Dove sono i castighi contro gli
ospiti?»
Lo stesso dico del finale che il traduttore mette in bocca di tutti
al terminarsi la scena, quantunque non vi sia edizione che non lo ponga in bocca della
sola Ecuba, e dovendosi considerare
manifestamente quelle parole come una continuazione del senso anteriore.
[96] Nella seconda dissertazione dice molte belle
cose, parte delle quali mi sembra vere, e parte no intorno allo stile drammatico-lirico
in generale, e intorno a quello de’ salmi in particolare, ma io non ho saputo rinvenire
il luogo dov’egli, secondo il giornalista asserisca, «che la divisione della
nostra opera in recitativo semplice, recitativo obbligato, ed aria fosse la stessa
stessissima presso ai Greci»
. Quanto a me ho ritrovato bensì la distinzione
tra il recitativo e l’aria come l’ho fatto distesamente vedere nella lunga nota posta
alla pagina cinquantesima terza di questo volume, ma non m’è venuto fatto di ritrovare
la differenza tra il recitativo semplice e l’obligato.
GIORNALISTA.
[97] «Soggiunge ancora (ibid.), che un dramma di moverà le lagrime leggendolo, e sentendolo cantare sarà indifferente: ma ancor questo ci sembra un inganno, mentre se il dramma sarà ben accompagnato dalla musica e bene eseguito dai professori, toccherà assai di più.»
RISPOSTA.
[98] Questa è una di quelle verità che gli Spagnuoli chiamano “di Pietro Grullo”, e in qualche parte d’Italia “del Dottor Graziano”. Se in tempo di notte vi fosse il sole, ci si vedrebbe, ma appunto perché di notte il sole non c’è, non ci si vede. Se i drammi di fossero ben accompagnati dalla musica e ben eseguiti dai cantanti, senza dubbio ci moverebbono di più che se fossero semplicemente recitati, ma appunto perché non c’è codesto accompagnamento ben adattato né cotesta acconcia esecuzione, essi ci lasciano sul teatro freddi quanto un ghiaccio. Che così realmente accadda in pratica è una verità di fatto, e solo può darsi ad intendere il contrario a qualche tartaro Kalmuko che non abbia la menomissima idea delle rappresentazioni musicali. E tanto è vero che i drammi del non fanno più effetto sulle scene, che rare volte hanno gli impresari il coraggio di esporveli, e se talvolta lo fanno, non gli espongono se non mutilati, e così mal conci che appena sono riconoscibili. Le cagioni di questo fenomeno non sono difficili a ritrovarsi. 1. Il canto moderno altera colle sue stranezze, e travisa l’imitazion naturale a segno che, tolta ogni connessione colla poesia, altro non rappresenta fuorché un quadro arbitrario, e in tutto disforme. 2. Il recitativo semplice, onde si forma la maggior parte del dramma, è così trascurato dai maestri e dai cantanti, che non può ned eccitare la curiosità dell’uditore, né tener sospesa la sua attenzione. 3. I balli occupano in oggi tanto spazio di tempo nella rappresentazione, che bisogna accorciare anzi stroppiare i drammi acciocché lo spettacolo non riesca d’una insofferibiie lunghezza. Dalla forza ed evidenza degli accennati motivi è venuta ai poeti la quasi necessità di slontanarsi dal piano stabilito da riducendo il melodramma ad una serie di quadri con pochissima connessione fra loro come hanno fatto il , e il Conte ; e così la tragedia musicale, che fra le mani dell’illustre avea toccato la perfezione di , e d’, è ritornata un’altra volta ai tempi di . Al vedere l’ignoranza che mostra di tutte queste cose il giornalista non si crederebbe ch’egli fosse un maestro di musica de’ nostri tempi, ma che simile al greco si fosse addormentato quaranta o cinquanta anni fa, e che avesse prodigiosamente continuato il suo sogno fino alla mattina che compilò l’estratto.
GIORNALISTA.
[99] «Quindi non è colpa della musica se tante volte le opere sono malamente composte, e peggio eseguite, e la questione non consiste nel decidere se i drammi, che ora si rappresentano, son male composti e male eseguiti, che questo purtroppo succede spesso; consiste nel deffinire se abbiamo adesso una buona poesia e musica teatrale, in favor di che le opere del gran e di qualcun altro, e l’eccellente musica di tanti bravi maestri parlano abbastanza. La scarsezza dei bravi artisti non può mai derogare alla perfezione d’un arte; anzi ci sembra che questo appunto sia un segno del suo valore sublime; mentre il diventare artista quando l’arte è ancor fanciulla è facile a molti, ma diventarlo eccellente quando l’arte è quasi giunta alla perfezione, è fortuna di pochi.
Pauci quos aequus amavit Jupiter.»
RISPOSTA.
[100] La questione non consiste nel decidere se abbiamo ora una buona poesia, od una buona musica, se per tali cose s’intende qualche pezzo di buona poesia e qualche pezzo di buona musica. Gli altissimi e sinceri elogi dati da me a , e la lode con cui ho nominati molti maestri della trascorsa età e della presente, fanno vedere ch’io non ho mai dubitato né dell’uno, né dell’altro. Ma la questione consiste nel sapere se al presente vi sia tra i più una buona musica ed una buona poesia; ed ecco ciò ch’io ho negato, e che il Signor non m’ha provato finora. E se tra i più non regna il buon gusto nelle anzidette facoltà, io ho avuto ogni ragione di dire ch’esse sono al presente nella loro decadenza; giacché lo stato d’un’arte in un secolo, e presso ad una nazione dai più si misura, e non dai pochi. E siccome i , gli , e i non tolsero al secolo d’Alessandro la gloria d’essere uno dei più illustri nella storia della greca letteratura, come i , i , e i non impedirono che l’età di , di , e d’ non venisse chiamata il secol d’oro delle lettere romane, come i , i , i non annebbiarono per niente il letterario splendore del felicissimo regno di Luigi XIV, così uno scarso numero di buoni autori, quando la maggior parte è cattiva, non basta a caratterizzar il buon gusto d’un’epoca intiera; altrimenti il Seicento, ch’ebbe in Italia il Cardinal , il , il , il , e il anderebbe dal paro col secolo avventuroso di Leon X; e e , scrittori puri ed eleganti, basterebbono per mettere a livello i tempi di con quelli d’Augusto; e e potrebbono essi soli eguagliar l’epoca di Tolomeo Filadelfo a quella di Pericle e di Filippo.
[101] È inoltre da osservarsi che il giornalista, il
quale finora altro non ha fatto che menar rumore perché mi sono mostrato poco contento
dello stato presente della musica, conviene ora meco intieramente accordandomi, che
siamo «nella scarsezza de’ bravi artisti e che l’opere che al presente si
rappresentano sono mal composte, e peggio eseguite»
.
«Quo teneas vultus mutantem Protea nodo?»
GIORNALISTA.
[102] «È ancor di parere uniforme il Sig. al P. e a qualcun altro, cioè che la musica non abbia un gusto fisso; che le composizioni dei primi maestri del nostro secolo sieno già divenute anticaglie; e che lo stesso succederà alle migliori che si compongono presentemente, e tutto ciò perché vi è molta musica, tanto antica che moderna, assai mediocre e inverisimile, non essendo adattata niente affatto alle parole e agli oggetti che deve imitare ecc. Ma perché parlar di questa, e non della buona? Non segue forse lo stesso nelle altre arti rappresentative? Per una Venere medicea, per un Apolline di Belvedere ecc., ecc., quante statue inferiori di gran lunga a queste non abbiamo. Per una Madonna di Corregio, un S. Pietro di Guido ecc., non son quasi infinite le pitture mediocri ch’esistono? Per finir dunque ripeteremo solamente ciò che già si disse nella più volte citata nota 13. delle Regole armoniche ed in un altro estratto incluso in questo giornale al N. VIII dell’anno scorso, cioè che quello ch’è veramente buono e bello in qualunque arte vesta sempre tale; che la musica, essendo un’arte nuova o rinnovata, i suoi perfetti monumenti non possono essere sì antichi come quelli sono di pittura e di scultura, arti perfezionate molto prima, e che se le composizioni dei primi maestri del nostro secolo fossero state buone, lo sarebbero ancora, come lo sono alcune del , del , dello , di , di , di , di , di , del , del , del , del , del P. , del , del , dell’, dell’ e di tanti e tanti altri, le quali composizioni potranno sempre servire di classico esemplare ai giovani che vorranno diventare eccellenti nell’arte di comporre.
.»
RISPOSTA.
[103] Io non mi sono contentato di dire che la nostra
musica non ha un gusto fìsso. Ho cercato di provarlo adducendo delle ragioni, e
indicando delle viste filosofiche su tal proposito, che mi lusingo non saranno riputate
triviali da chi è qualche cosa di più che cattivo compilatore di estratti. Siffatte
ragioni si trovano dalla pag. 82 fino alla 89 del presente volume, ed ecco il perché mi
dispenso dal riportarle qui di nuovo. Ivi pure si trova prevenuta e disciolta
l’obbiezione del giornalista tratta dal paragone della pittura e della scoltura;
obbiezione che forse non gli sarebbe mai venuta in mente se non l’avesse letta nel mio
libro. Ma desideroso di comparire sulla fine dell’estratto, qualis ab
incepto processerat non adduce veruna delle mie pruove, non si fa carico dei
fondamenti su cui s’appogiano le mie opinioni, lascia a capriccio e muta ciò che non
intende, o che non fa per lui, ricorre a luoghi comuni nel confutare, e riempie le mezze
pagine di declamazioni fuor del luogo, o di critiche frivolissime che spariscono da sé
tostochè si sono rilette le mie parole. È poi una incoerenza delle molte, in cui è
solito d’incorrere il logicismo estrattista, il dire che le composizioni del , e del fra
gli altri potranno sempre servire di classico esemplare ai giovani che volessero
diventar eccellenti nell’arte di comporre. E non m’ha egli ripreso in altro luogo,
perché ho lodata la musica del e del
a preferenza di quella de’ nostri tempi? Ecco
le sue parole: «E se il Signor Arteaga ci dirà che s’intese di lodar la musica
de’ primi inventori del buon gusto come d’un , e d’un ecc. e non la
nostra, noi gli risponderemo lo stesso che già si rispose ad altrui nella summentovata
nota 13. del nostro libro Regole armoniche, cioè che la musica d’allora
in poi non è stata mai tanto eccellente quanto lo è presentemente.»
Ora se la
nostra musica “ha sempre guadagnato” dai tempi di e di infino al presente,
e se trovasi attualmente nella sua eccellenza, perché non trarre i classici esemplari
dalla nostra musica, da loro anziché da quella degli inventori del buon gusto? O se
e
devono servire di esemplare e di modello alla gioventù, come può darsi che la musica
abbia sempre guadagnato dopo loro, e che si ritrovi nella sua eccellenza, ora che tanto
s’è allontanata dal gusto di quei classici scrittori? Contradizioni infelici!
[104] Mi pare d’aver partitamente risposto alle
opposizioni fattemi dall’enciclopedico giornalista. Tocca ora ai lettori giudiziosi e
imparziali (i soli al cui suffragio io aspiri), il riflettere con quanta ragione avesse
il Signor promesso fin dal principio del
suo estratto «di segregare il vero dal falso, in cui pur troppo se rari sono gli
autori che non v’incorrino, quanto più facilmente vi caderà quello che tratta d’una
cosa non sua»
. Se l’amor proprio non mi seduce mi sembra però che l’autore
“che tratta di una cosa non sua”, ha evidentemente mostrato al giornalista dotato di
tanto “raziocinio”, e di tanta “dose di cognizioni musicali” che il raziocinio di lui è
inconcludente, frivolo e contrario alla buona logica, e che la sua dose di cognizioni
musicali, è molto scarsa in ciò che spetta la parte filosofica storica e critica della
musica, i soli aspetti cioè sotto i quali venga riguardata quell’arte nell’opera delle
Rivoluzioni. Ciò mi fa sperare che il Signor giornalista diverrà un pò men baldanzoso
per l’avvenire, e che uscirà dalla persuasione in cui è che il saper combinare bene o
male dei diesis e dei bemolle gli dia un diritto d’infallibilità quando parla a coloro
che non sono della professione. Se questi devono avere la prudenza di non mischiarsi nel
tecnico e nel pratico dell’armonia, per non precipitar negli sbagli (dei quali per altro
il giornalista non ha saputo ritrovare neppur un solo nel mio secondo volume), i maestri
devono guardarsi non meno dal farla da filosofi, da eruditi, e da metafisici nell’arte
propria per non palesare la propria ignoranza.
«Tocca, dice , a’ poeti far la poesia, e a’ musici far la musica, ma
non s’appartiene che al filosofo il parlar bene dell’una e dell’altra.»
Fine del Tomo Terzo.
